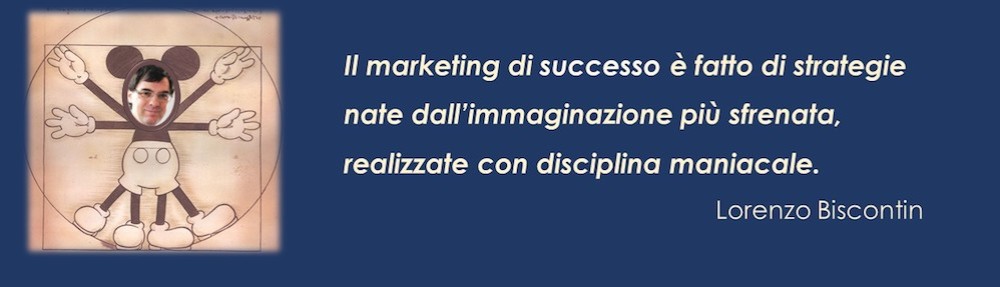Sfogliando la stampa specializzata del settore bevande nell’ultimo mese non si poteva fare a meno di noatre le pubblicità di alcune novità di prodotto: Bacardi Originals, Bacardi Pina Colada+Bacardi Mojito e Pampero Mojto alla spina (qui il link non è al sito del Pampero, già difficile da trovare di suo, perchè lì questo prodotto non è citato).
Sono prodotti che mi hanno fatto pensare al fenomeno dei ready to drink dei primi anni 2000. Immagino che più di qualcuno si ricorderà dei vari Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, Campari Mixx ed Havana Loco. Si trattava di long drinks a base di superalcolico (vodka, rum, campari a seconda dei casi) e di acqua gassata apparsi sul mercato a partire circa dal 2002 e sostanzialmente spariti per il 2005. Nessuno di questi è riuscito a consolidarsi sul mercato e, malgrado i volumi sviluppati siano stati molti importanti grazie ai fortissimi investimenti pubblicitari delle aziende, nel milgiore dei casi il business ha raggiunto il breack-even o poco più.
Era un segmento che avevo analizzato a fondo perchè nel 2003 in Stock eravamo pronti a lanciare due ready to drink a marchio Keglevich (definite e testate ricette e packaging, definiti gli accordi con gli imbottigliatori, ecc..), quando poi abbiamo deciso di non schiacciare il bottone del via. Esperienza, competenza, fortuna o presunzione? Non l’ho mai capito, ma è andata bene così. Secondo me il punto debole della categoria stava nel concetto stesso di prodotto che non era nè una bibita gassata, visto il circa 5% di grado alcolico, nè aveva la qualità di un long drink preparato sul momento, sia intrinsecamente che di immagine (percezione di “beverone” industriale). Inoltre non si basavano su long drinks affermati, ma proponevano sostanzialmente gusti nuovi per il mercato dei long drinks (il capostipite Smirnoff Ice era vodka con leggero gusto di limone, stessa base limone del principale Bacardi Breezer).
Riusciranno le proposte dell’estate 2011 ad avere il successo che non hanno avuto i ready to drink di qualche anno fa? Hanno dalla loro la proposta di long drink classici e molto richiesti (mojito in primis) e la praticità per il trade che deve servirli.
Io però dubito che la valutazione fatta dal consumatore (che ricordiamo sempre sono persone) a suo tempo sarà molto diversa oggi. E’ vero che nelle discoteche e nei locali di grande afflusso è prassi normale oramai da alcuni anni quella di preparare la basi per i long drinks più richiesti, ma c’è comunque una forte componente di intervento del bartender al cui confronto la spina di mojito Pampero mi sembra francamente agghiacciante.
In realtà credo che possa esistere una terza via, che hai tempi avevo proposto in Stock senza successo, ed è quella del facilitare la preparazione di cocktails e long drinks nel consumo in casa. Il numero di persone che per motivi generazionali di ciclo di vita sta riducendo o annullando aperitivo/happy hour/serate fuori casa comincia ad essere rilevante.
Il fatto che queste persone abbiano dovuto cambiare il loro stile di vita riguardo alla frequentazione dei locali non significa che vogliano cambiare anche gli stili di consumo, però preparasi cocktails e long drinks a casa può essere complicato, soprattutto se si tratta di situazioni “sociali” in cui sono presenti più persone.
Una riposta a questa esigenza attualmente insoddisfatta mi era stata ispirata da E’ un concetto che avevo preso da una confezione di Tequila Sauza comprata in un duty free: nell’astuccio c’era una bottiglia da 1l di tequila ed una da 1l di margarita mix, totalmente analcolico. Idea intelligente, però era stata pensata come promozione tattica a se stante e non come innovazione strategica. Il risultato dell’esperienza di consumo era quindi deludente, non per la qualità del cocktail che ne derivava, ma perchè seguendo la proporzione consigliata di 1/3 tequila e 2/3 margarita mix, il mix finiva prima del tequila, per cui, a meno di non darsi agli shoot (ma è un consumo da tutt’altro target) uno rimaneva con del tequila di cui non sapeva che farsene.
Da qui la mia idea di produrre e vendere basi per per cocktails e long drinks come categoria a sè (se poi il lancio avesse previsto confezioni in co-pack con il distillato era un tecnicismo), prevedendo che avessero tutti gli ingredienti necessari, anche quelli alcolici, se del caso. Per rimanere all’esempio del margarita mix, quello che volevo fare io prevedeva al suo interno anche la giusta % di Triple Sec, che è il nome del distillato generico fatto con lo stesso processo del Cointreau (ingrediente ufficiale del Margarita).
In questo modo si ottenevano due obiettivi: si forniva al consumatore un prodotto con cui poteva realizzare un cocktail assolutamente fedele a quello che avrebbe preparato un bartender e, dal punto di vista dell’azienda, si aggiungeva una modalità di vendita del triple sec.
Non c’è la praticità del ready to drink, ma c’è l’autenticità del coinvolgimento diretto del consumatore nella preparazione (semplificata) che gli permette di aggiungere il suo tocco e di variare le proporzioni a suo gusto.
Magari prima o poi riuscirò a realizzarla ed a scoprire se era veramente un bel concetto strategico o solo un’alzata d’ingegno.
Tag Archives: strategia
Inversioni di marketing: Keglevich + Limoncè
Quando ho visto la promozione della foto qui sotto mi è venuto in mente un, oramai, vecchio libro di Domenico Barili, ai tempi Direttore Marketing di Parmalat.
 .
.
Questo sia per il titolo, “Inversioni di marketing” appunto, che pensando al percorso fatto dall’azienda di Collecchio. Va detto per onor di cronaca che, a quanto ne so, Barili non è mai stato coinvolto in alcun modo nelle vicende del crack Parmalat.
Per correttezza aggiungo anche che ho ovviamente un occhio particolarmente attento per marche come Keglevich (che ho gestito per 7 anni prima da Group Brand Manager e poi da Direttore Marketing) e Limoncè (che ho gestito per tre anni e mezzo da Dir. Mktg) e credo si possa intuire la mia limitata stima per l’attuale gestione di quella che era la Stock di Trieste.
Tutto ciò premesso, la domanda è semplice: cosa c’entra la Keglevich con Limoncè? A voler scendere dal livello di marca a quello di prodotto: cosa c’entra la Keglevich Vodka Classica con il nuovo Amaro Limoncè?
Tanti anni fa un mio chairman mi disse che le brand-extension funzionano solamente se si rivolgono allo stesso target occupando un diverso momento/modalità di consumo oppure se si rivolgono ad un target diverso e nuovo rispetto all’esistente. In questi casi sostanzialmente si annullanno i rischi di cannibalizzazione e le prospettive di aumento del volume d’affari possono compensare il rischio, sempre difficile da valutare, di diluzione dell’immagine della marca.
A prima vista qui potremmo ricadere nel caso del diverso momento di consumo, visto che il target per l’Amaro Limoncè si assume per definizione il medesimo Della Keglevich Classica utilizzando lo strumento promozionale del gift on pack.
Il punto però è che qui non si tratta di una brand extension, ma dell’abbinamento tra due brand diversi, leader di due categorie affini (liquori da dopopasto e distillati da cocktail), quindi con un’immagine ed una personalità forte e chiara.
Allora che interesse può avere il consumatore di Keglevich Classica, che avrà tra i 20 ed i 30 anni (massimo) e la utilizza per un consumo miscelato a provare un amaro, categoria di prodotto tradizionale, che si consuma liscio, a marchio Limoncè? Dell’ascesa e declino del marchio Limoncè, se volete parliamo un’altra volta, altrimenti questo post rischia di diventare troppo lungo ed antipatico.
Secondo me l’interesse è minimo, mentre l’indebolimento per l’immagine di Keglevich è elevato.
Di base poi io non credo per niente al concetto dell’Amaro Limoncè perchè ho visto le ricerche di dieci anni fa che dimostravano come Limoncè fosse un marchio estremamente forte, evocativo, ma stretto che non ammetteva estensioni al di fuori del limone (nomen omen) ed ho visto l’esperienza, negativa, del Limoncè Mint.
Qualcuno potrà dirmi che in dieci anni sono cambiate tante cose (ovvio), io però ricordo sempre quello che mi disse un giorno un filibustriere titolare di una media agenzia pubblicitaria del nord-est: le ricerche bisogna saperle leggere. B U G I A: LE RICERCHE BISOGNA SAPERLE SCRIVERE. Ne parliamo sul prossimo post.
I dettagli NON fanno la differenza
“The devil is in the details”, trovare questa frase come titolo di un articolo della rivista dell’AMA “Marketing Management” nel 2007 fu uno di quei momenti di soddisfazione professionale perchè da alcuni mesi il motto del mio ufficio marketing in Stock era “Sono i dettagli che fanno la differenza”. E per quanto uno sia convinto che le sue idee siano buone, trovare una conferma di quel livello è sempre di conforto (oltre a rendere sempre più labile il confine tra orgoglio e presunzione).
Il concetto era sorto dall’osservazione della pratica del business ed era diventato una sorta di linea guida nella realizzazione dell nostre strategie, quasi una precondizione del successo, che sembrava trovare continue conferme. Quella che mi sembrò più evidente fu quando, durante gli incontri con i potenziali acquirenti della Stock, un Direttore Generale di un’importante azienda concorrente mi disse “Biscontin io proprio non capisco, adesso che vedo le vostre startegie dal di dentro mi convinco sempre di più che noi facciamo circa le stesse cose, eppure voi avete una quota di mercato superiore al 50% che continua a crescere, mentre noi siamo stabili come quota e perdiamo in vendite assolute”. al che io ho risposto che tutta la differenza stava in quel “circa” e quel circa era fatto di dettagli.
Oggi continuo a pensare che la differenza fosse tutta in quel circa, ma non sono così sicuro che quel circa fosse fatto di dettagli, oppure bisogna capirsi su cosa si intende per dettagli.
Il fatto è che il concetto di cura del dettagli è gratificante per chi segue un progetto, lo fa sentire un professionista migliore, superiore alla massa che si accontenta di fare le cose come può o come vengono. In una parola è un concetto a cui è bello credere (un po’ come ad “amor ch’a nullo amato amar perdona” per fare un paragone che conoscono tutti).
Il problema però è che cercare di seguire (seguirli davvero tutti è impossibile) tutti i dettagli è estremamente dispendioso in termini di tempo e di soldi e quindi implica un grande rischio di inefficenza ed inefficacia causato dalla perdita di focalizzazione sulle cose veramente rilevanti per il successo del progetto.
Non sono considerazioni che faccio alla leggera, “Sono i dettagli che fanno la differenza” è il monito che campeggia ancora sulla pagina generale del mio profilo Netvibes, però incomincio ad avere dei forti dubbi.
Sarà perchè ultimamente ho ragionato un po’ di oceani rossi ed oceani blu, ma credo che la differenza tra due o più proposte in apparenza simili la faccia l’originalità e la rilevanza del concetto sottostante. Poi è evidente che se questo concetto è supportato coerentemente e con forza da tutti gli elementi della sua implementazione è meglio, però ottimi dettagli non daranno il successo ad un concetto debole e, viceversa, pessimi dettagli non potranno affossare un concetto forte.
Faccio un esempio pratico: neò 2007 in Stock abbiamo cambiato radicalmente il packaging della vodka Keglevich alla frutta, passanto dalla bottiglia smerigliata con etichetta ed una bottiglia trasparente interamente coperta da uno sleever (film plastico che avvolge tutta la bottiglia). Questo ci ha permesso di lavorare con la grafica su tutta la superfice della bottiglia e sviluppare un’immagine del prodotto maggiormente in linea con il concetto di posizionamento “Your Fun”. Per una serie di ragioni tecniche nei primi mesi (almeno 6) lo sleever era evidentemente storto in circa il 10% delle bottiglie, con il risultato che le bottiglie a scaffale apparivano un po’ diverse tra loro. Eppure, malgrado questo dettaglio scadente, la bontà della grafica era tale che la forza del concetto passava ugualmente e quindi la quota di mercato continuò a crescere ben oltre il 50%.
Forse la prioritizzazione tra elementi di differenziazione sostanziali e di contorno è uno di quegli elementi del “barebone marketing” che ho annunciato qualche post fa. Fatto sta che oggi mi sto convincendo che sia sempre più cruciale non fossilizzarsi sui dettagli (inutili) ed investire più tempo nell’identificare quali sono gli elementi sostanziali, anche solo approccio concettuale e che quindi non sempre si manifestano in modo eclatante, ma che fanno realmente la differenza.
Attenzione che non si tratta di elementi fissi, perchè il plus di oggi è destinato a diventare il must di domani.
Non so se centra o se addirittura smentisce tutto quello che ho detto fino a qua, ma ieri ho visto al supermercato le nuove confezioni di caffè illy con la pennellata d’artista di diverso colore che identifica le varie miscele. Posto la foto senza commenti, prima che si dica che ce l’ho con loro.

illy, Lavazza ed il riciclo delle capsule
Leggo sul numero di aprile della rivista della COOP nella rubrica “Italiani brava gente” a firma Cirri-Solibello (conduttori di “Caterpillar” su radio2, mio appuntamento fisso se sono in macchina dalle 18:00 alle 19:30) l’esperienza di riciclo del comune di Capannori, provincia di Lucca.
A Capannori hanno un progetto chiamato “Rifiuti Zero” per arrivare entro il 2020 e non produrre più alcun rifiuto. Oggi sono all’81% di differenziata ed hanno attivato diverse azioni per evitare la produzione di rifiuti a monte (prima del riciclo c’è il minor uso come insegna la famosa regola delle 3 R dell’ecosostenibilità: nell’ordine RIDUCI, RIUSA, RICICLA). Secondo questo approccio sono andati ad analizzare cosa c’è in quel 19% di rifiuti non differenziabili ed hanno scoperto che un volume rilevante è dovuto alle capsule per l’espresso fatto con le macchinette da uso domestico/ufficio. A Capannori ogni anno ne utilizzano 750.000 del 1.000.000.000 che se ne consumano in Italia.
Queste capsule sono indifferenziabili perchè non possono essere riciclate con la plastica a causa della polvere di caffè che contengono e, meno che meno, possono essere riciclate come materiale organico a causa della plastica di cui sono fatte.
Allora l’assessore all’Ambiente di Capannori ha scritto alla Lavazza per stimolare lo sviluppo industriale delle alternative già esistenti, tipo capsule biodegradabili, riciclabili o cialde in carta compostabili. Para che la Lavazza abbia colto lo spunto e ci stiano lavorando.
Fin qui la cronaca, ma perchè ne sto parlando? Perchè di questo articolo mi hanno colpito alcune cose.
La prima è che poco meno di un anno fa affrontavo su questo blog la medesima questione, analizzando la posizione di Illy. Scoprire di essere in sintonia (e magari un po’ in anticipo) con quello che succede nel mondo è sempre una bella rissicurazione.
Soprattutto però mi ha colpito il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza, quando proprio illy è stato tra i pionieri nell’ideazione delle cialde.
Lavazza è storicamente l’azienda leader in Italia nel mercato del caffè in termini di quota di mercato, ma illy aveva una leadership che io ritengo più importante: la leadership delle idee.
In altri termini illy era chiaramente il leder italiano (e non solo) del caffè nella definizione dello scenario, di contorni, del settore. Era il riferimento per tutti, consumatori, intermediari commerciali e concorrenti. Scrivo era perchè il fatto che i signori di Capannori si siano rivolti a Lavazza mi sembra un (ulteriore) segnale della perdita di questa leadership.
Ed è un peccato perchè, anche riguardo all’espresso in casa, le idee le aveva tutte in anticipo, con l’ideazione del sistema E.S.E. che prevedeva l’utilizzo di cialde (compostabili) e, soprattutto, l’utilizzo gratuito del brevetto disponibile per tutti. Si evitavano così le inefficenze intrinseche al monopolio di fatto con cui lavorano attualmente le principali case di caffè (illy compresa).
Perchè è successo? Questo ovviamente non lo so. Qualcuno potrebbe dire che è il naturale ciclo di vita delle marche, ma è una visione che io contesto perchè le marche non sono organismi soggetti ai cicli biologici (le persone che le gestiscono però sì), ma sono entità che si alimentano con le idee. D’altra parte anche Lavazza è una marca con di età ragguardevole.
Quello che mi viene da ipotizzare è che illy abbia provato a fare Lavazza, dimenticandosi che se ci si era avvicinata in termini di dimensione era proprio grazie al fatto che proponeva al pubblico uno stile diverso. Stile che ad un certo punto non ha più avuto il coraggio di seguire fino in fondo.
Lavazza invece ha imparato a fare illy (penso al collegamento con l’arte, il design o l’alta cucina), portandosi quantomeno allo stesso livello, sia in termini di qualità intrinseca (capsule+macchine per espresso) che di interlocutore pubblico sulle questioni legate al caffè.
Rivedendo nel mio post dell’anno scorso le dichiarazioni di Andrea Illy sulla riciclabilità delle capsule, spero per l’azienda che fossero frutto dell’amor proprio e non di disonestà intellettuale.
Marketing all’osso
Barebone marketing suonava francamente meglio, ma tanti anni fa mi sono dato la regola di non utilizzare terminologia inglese, a meno che non esistesse un’espressione equivalente in italiano.
Questo post volevo scriverlo per motivi di pura opportunità e cortesia, nel senso che mi rendo conto che, a furia di tenerlo a metabolismo basale con le frasi dell’AMA, il blog rischia di morire e poi c’era qualche richiesta di cortesi lettori.
D’altra parte non mi sembrava di avere niente di interesante da dire, che è la situazione peggiore ed è anche un po’ sorprendente, visto che da Natale ho scritto solo un post.
Anche perchè durante le vacanze ho letto un po’ di cose interessanti di gestione di marketing e di economia aziendale, ho visto quello che succede in Spagna, insomma in teoria ho avuto un po’ di stimoli. Eppure tutto mi sembra già visto, perfino al Corte Ingles non ho trovato niente di nuovo (è la prima volta che mi succede in 18 anni).
Sarà vecchiaia oppure la stanchezza della preparazione del Vinitaly del 50° del Pinot Grigio Santa Margherita.
Allora mi sono detto: scrivo un post di cazzeggio di marketing. Farebbe bene a me, che mi sto fossilizzando in post sempre e solo strategici, ed a chi mi dice che questo blog richiede sempre grande attenzione (forse troppa).
Un bel post facile facile, con i complimenti al (semi) nuovo spot di Campari oppure la perplessità sul nuovo spot del nuovo amaro Limoncè, del quale mi convinceva già poco il concetto di prodotto e lo spot stile anni ’80 ancora meno.
Mentre pensavo che forse è il legame emotivo con una marca che ho gestito tanti anni ad impedirmi di vedere le cose con obiettività, mi sono reso conto che sempre di più imposto le attività di marketing in generale, e la comunicazione in particolare, con modalità tendenzialmente scarne.
Riflettendo mi rendo conto che a fronte dell’affermarsi della propoganda nella comunicazione e della sensazione generale di già visto, mi sposto sempre più distante dalla logica son-et-lumiere, o stucco-e-pittura come diceve una mia ex collega.
in altre parole la mia visione del marketing è sempre più quella di un marketing all’osso, che va all’essenza, che, come c’è scritto nei libri, punta a rendere inutile le attività di pubblicità e promozione grazie alla forza della proposta in termini di interesse per il servizio offerto.
In altre parole l’I-Pad, per cui tutti i giornali si sono affrettati a fare la versione compatibile, indipendentemente dalla diffusione o meno dell’apparecchio.
Sarà l’ennesimo segnale che mi sto convertendo in uno dei vecchietti del Muppet Show, l’evidenza che non sono più al passo con i tempi oppure sono la punta più avanzata dell’avanguardia (che comunque non è mai positivio).
Se qualcuno ha l’occasione di analizzare come si fa il marketing in Brasile, soprattutto, Cina e India, troverà la risposta.
Sempre la solita storia.
Dopo aver inutilmente pagato il doveroso dazio al teatrino dei gattopardi della politica (proverbio spagnolo: de noche todos los gatos son pardos), torno ad oocuparmi di cose serie, ossia teoria e strategia di marketing.
Durante le ferie ho approfittato per studiare un po’ ed ho trovato un interessantissimo articolo sull’analisi narrativa per ls creazione di storie persuasive che permettano di connettersi a livello emotivo con la propria audience. Dico da subito che tralascerò completamente qualsiasi commento riguardante la questione della persuasione occulta.
La cosa interessante è che le ricerche basate sull’analisi dei testi hanno identificato meccanismi e strutture che si ripetono attraverso la storia e le culture.
I livelli di comprensione della storia sono sempre tre. Dal più superficiale al più profondo: il messaggio, a livello razionale, il significato, a livello di sentimenti e convinzioni, il mito, a livello del nostro inconscio universale ed eterno.
Quindi comunicare alle persone attraverso miti universali, permette di parlargli al più profondo livello emotivo. Il bello è che anche il mito, sfumature a parte, si può ricondurre sempre ad alcuni modelli fondamentali:
- il mito dell’eroe: una persona normale viene chiamata a fare cose eccesionali, supera prove difficili, combatte i propri demoni esterni ed interni che lo spingono a mollare ed alla fine, guidato da un mentore, raggiunge il suo obiettivo. Marca? Nike “Just do it”.
- il mito del ciclo della vita: il continuo fluire delle generazioni in cui il vecchio passa la propria saggezza al giovane in un ciclo di ottimismo e speranza dove non c’è fine, ma solo nuovi inizi. Marca? Ford Mustang con lo spot del 2005 che resuscitava Steve McQueen.
- il mito della creazione: qui non serve nemmeno spiegarla. Marca? L’immagine di Jobs e Wozniak che montano il primo Apple nascosti nel loro garage.
- Il mito della creazione dalla distruzione: scegliete quello che vi piace di più tra Noè e l’Araba Fenice. Marca? Coca Cola Classics resuscitata dalla ceneri della New Coke.
- il mito della lotta tra il bene e il male: la battaglia tra il caos e l’ordine si trova già nella cultura sumerica. Marca? Vespa vs. Lambretta, Apple vs. Microsoft, ecc…
E la vostra marca di che mito è?
Oscar Farinetti: stupor mundi
L’altro giorno ho ricevuto una risposta personale al mio post sulla campagna radio fatta dall PAM. Anche se l’intenzione di scrivermi personalmente invece di postare un commento mi pare fosse quella di non sparare sulla croce rossa, credo (spero) non se ne abbia a male se riporto parte della sua mail: .…. ma c’è una situazione in questo settore (della distribuzione N.d.A.) che definire drammatica è dir poco.
C’è una battaglia sul prezzo pazzesca, c’è il problema della terza settimana, ci sono competitor che entrano da un giorno all’altro.
E ti assicuro che di fronte ad una situazione del genere non si riesce più a farli ragionare: sono come impazziti, rapiti nel vortice di promozioni, sconti e buoni spesa, pronti a tradire posizionamenti e format pur di far quadrare i fatturati.
Il risultato sarà che qualcuno alla fine salterà e che si apriranno nuove opportunità per chi le saprà cogliere, mettendo in crisi le “vecchie” insegne.
Tutto vero, tutto giusto, tutto condivisibile, P E R O’ poi viene fuori Oscar Farinetti che apre Eatily con posizionamento forte basato su una chiara promessa di valore per un determinato target (che in questo caso è tutti i segmenti di consumo) e tutti rimangono a bocca aperta. E poi tutti i concorrenti lì a trovare scuse, …. è amico di Petrini, …. è proprietario delle cantine, ecc…, per giustificarsi di non averlo fatto (anche) loro.
Ma la cosa interessante è capire cosa ha in più Farinetti per ottenere i successi che ottiene.
Secondo me Farinetti ha più testa e più cuore (manca solo la coda e poi abbiamo rifatto il Carosello della grappa Piave).
Più testa nel senso che ha l’acume, le conoscenze e la creatività per pernsare e formulare della proposte di valore inovvative e rilevanti per ampie fasce di persone. Il buon vecchio marketing strategico. Il bello è che l’innovatività della proposta non sta tanto nei singoli elementi che la compongono, che in buona parte sono già presenti in modo sparso sul mercato, ma nel fatto di metterli e nel modo in cui vengono collegati. In parole povere nel pensiero che ci sta dietro, cosicchè il valore per i consumatori sta innanzitutto nel pensiero di base, di cui i servizi che gli vengono offerti (ribadisco una volta di più che nessuno compra mai prodotti, ma sempre servizi) sono la “semplice” concretizzazione. Il buon vecchio marketing strategico
Coem scrivevo in un mio vecchio post il concetto di “unique selling proposition” è spesso sopravvalutato perchè nella maggioranza dei settori è talmente difficile da rischiare di portare l’azienda ad inseguire chimere irragiungibili. Quello che fa Farinetti è sviluppare una “best selling proposition”, inserendo alcuni elementi di novità in quella che è sostanzialmente una nuova, e più ampia, combinazione di elementi esistenti.
Il pensiero però non basta senza l’azione e qui Farinetti dimostra più cuore della maggioranza dei suoi concorrenti perchè ha il coraggio di credere nella bontà della sua proposta, anche se questa esce dai canoni classici dei settori in cui opera. Crederci davvero significa alimentarla con le risorse necessarie avendo la fiducia che queste verranno ripagate e realizzarla con disciplina, coerenza e costanza, in modo da far crescere sempre di più nel tempo la propria credibilità. in altre parole rifuggire i compromessi che potrebbero (dare l’impressione di) prendere in giro le persone.
Non è niente di complicato, ma la realtà di tutti i giorni dimostra quanto sia difficile.
Ecco perchè quando l’ho visto alla presentazione delle Guide de L’Espresso a Firenze lo scorso ottobre, mi sono tolto il cappello e sono andato a fargli i miei più sinceri complimenti.
PAM PAM! Bersaglio mancato?
Qualche settimana fa un mio amico mi citava la campagna radio della PAM. Sul momento avevo altro da fare ma, per motivi miei, la cosa mi incuriosiva e quindi oggi sono andato sul sito ad ascoltarli.
A parte il fatto che in programmazione non li ho mai sentiti perchè (pare) siano stati pianificati su una sola emittente.
A parte che non capisco che senso abbia con una pressione così limitata investire tempo e soldi a fare quattro soggetti: anche se gli speacker si pagano a chiamata, una certa confusione è assicurata.
A parte il fatto che la musica tipo Guerre Stellari è, ad essere buoni, un po’ vintage (deve essere una caratteristica delle catene distributive, oltre che dei detersivi, perchè anche Interdis con Bugs Bunny gioca la carta retrò, di quando eravamo giovani e felici).
A parte che ho sempre bene in mente un decalogo di Lintas visto più di 20 anni fa che diceva che la pubblicità deve concentrarsi su una sola idea, quella individua come più rilevante per il target dalle ricerche di mercato.
A parte tutti i discorsi su benefit e reason why (confesso che non ho mai capito bene la differenza tra le due cose e se c’è un pubblicitario all’ascolto sarei curioso di scoprirla dopo 16 anni che faccio questo lavoro).
A parte tutto, perchè non c’è nemmeno un briciolo di tentativo di costruire/rafforzare un minimo di posizionamento per dare dei motivi alle persone di andare a fare la spesa alla PAM? E non venitemi a dire che l’obiettivo della campagna è tattico, perchè non comunica una promozione/offerta/concorso ma comunica una concetto (leggi posizionamento) di convenienza.
A parte tutto, uno slogan/pay off/claim finale ci stava non solo per dichiarare e rendere più facile da ricordare il concetto di convenienza, ma anche solo per rendere meno monco lo spot.
Oggi mi sento generoso, come dimostrano due post nello stesso giorno, ne suggerisco uno io che esrpime al 100% il concetto della campagna: PAM: Più a Meno.
Strano che non ci abbiano pensato loro? Forse vi sembrerà ancora più strano sapendo che, a quanto mi risulta, “Più a Meno” è esattamente lo slogan da cui i fondatori del gruppo hanno creato l’acronimo PAM e che a capo dell’azienda ci sono i loro discendenti (che quindi dovrebbero conoscerne storia ed anima).
Ogni tanto la marginalizzazione del marketing non porta solo dei risparmi espliciti (di personale di investimenti), ma anche degli (elevati) costi impliciti.
La marginalizzazione del marketing e la crisi economica mondiale
BUUUUMM! E’ il mio ego che è esploso, sarà l’effetto Al Bano. Però questo post mi è venuto in mente mentre scrivevo la serie sulle terapie e quindi non scriverlo sarebbe stato un po’ (sana) modestia ed un po’ disonestà intellettuale. alla fine la vanità ha prevalso e quindi eccolo qui.
Senza avere la pretesa di affrontare l’argomento delle cause e soluzioni dell’attuale crisi economica mondiale (un minimo di sanità mentale mi è rimasta), ho l’impressione che se la funzione marketing nelle aziende avesse mantenuto almeno il peso che aveva una decina di anni fa, FORSE la crisi non avrebbe raggiunto la gravità che stiamo vivendo.
Al di là delle cause tecniche (come le precondizioni di rischio create dalla riforma del sistema finaziario dei tempi di Reagan, la velocità degli scambi finanziari, i mancati controlli, la politica sui tassi di cambio ecc…), la mega bolla è stata gonfiata da un atteggiamento del sistema, finanziario innanzitutto, concentrato esclusivamente sul COME, tralasciando completamente il cosa e meno che meno il perchè.
Una visione legata al portato culturale delle funzioni che attualmente giocano il peso maggiore nelle aziende: finanza e vendite.
E’ fisiologico che la finanza sia favorevole ad elevati ritorni a breve sugli investimenti e che supporti quindi l’altrettanto naturale orientamento delle vendite di dare al mercato quello che si vende meglio.
D’altra parte la misura dei risultati della funzione finanziaria è il ritorno (scegliete voi se preferite ROI, ROE o EBIT) e quello della funzione vendite è il numero di contratti chiusi/di ordini consegnati.
Questo modus operandi rischia però di diventare patologico (come in realtà è stato), se non è bilanciato da una visione del business anche nel periodo medio-lungo, di fidelizzazione del cliente, di soddisfazione articolata dei suoi desideri nell’intero processo di fruizione del prodotto (mutuo, salame, o bicicletta che sia), al di là della semplice vendita.
Tutti elementi tipici della cultura di marketing strategico, o almeno di quella che dovrebbe essere il contributo culturale che il marketing strategico porta in azienda.
Allora, forse, una delle terapie contro la marginalizzazione del marketing (poi giuro che chiudo l’argomento) potrebbe essere anche la necessità di un rinnovamento della cultura aziendale, dove le esigenze e richieste degli stakeholders trovano maggiore considerazione rispetto ad oggi, al di là delle dichiarazioni che si scrivono nelle relazioni di bilancio e sui siti aziendali.
Terapie contro la marginalizzazione del marketing 4 (ed ultimo)
Riguardando l’ultimo post mi sono accorto che sono andato un po’ per le spicce, lasciando una indeterminatezza probabilmente eccessiva.
La scelta di cosa e come misurare i diversi fenomeni aziendali e di mercato per migliorare efficenza ed efficacia delle attività di marketing rappresenta infatti la formalizzazione e quantificazione della visione strategica teorica.
Dal percorso teorico che disegno/immagino per arrivare agli obiettivi stabiliti e quindi dai meccanismi con cui ipotizzo che le attività che andrò a realizzare si ripercuoteranno sull’equazione del profitto, deriva la definizione di cosa misurare e come misurarlo.
Quanto più il percorso teorico sarà preciso, tanto più conseguente sarà la definizione delle diverse metriche necessarie.
Tanti anni fa, prima di entrare in azienda (era il 1994) ho scritto un articolo in cui sostenevo che la forza di un marchio più essere descritta riconducendo tutte le sue caratteristiche a due soli descrittori: conoscenza e reputazione. Dopo quindici anni di marketing aziendale continuo ad essere della stessa opinione.
La differenza sta nella direzione del processo:
- in una logica analitica si lavora di sintesi partendo dalla complessità della realtà per ridurla alle due dimensioni di cui sopra, – - in una logica di sviluppo strategico si lavora di espansione, partendo dalle due dimensioni della conoscenza e della reputazione ed esplode in tutte le loro componenti per definire dove e come agire.
Credo sia abbastanza evidente che si tratta di situazioni piuttosto complesse, quindi mi permetto di consigliare di non spaventarsi se le metriche da utilizzare dovranno/potranno essere diverse da quelle usuali e se i metodi sono un po’ più complessi della media aritmetica (potete spaziare dall’analisi statistica multivariata alla neurofisiologia cognitiva).
Chiudo con questo blog la serie sulle terapie contro la marginalizzazione del marketing, sperando, sia per me che per chi legge, di alleggerire un po’ i contenuti dei prossimi post.
Terapie contro la marginalizzazione del marketing 3
Oggi quello schifo di programma che risponde al nome di power point mi si è piantato di punto in bianco (presentazione fatta apporta senza NESSUN elemento grafico per evitare problemi) e così ho perso due ore di pensiero sulle strategie di marketing per il 2011. D’altra parte c’è poco da aspettarsi da un software che non è ancora in grado di fare alcune cose come le faceva harvard graphics vent’anni fa. Lo stesso si può dire comunque anche di word nei confronti di word perfect.
Grazie a Bill Gates quindi non sono proprio nello spirito giusto per scrivere questo post, però una promessa è una promessa e quindi sono andato a rileggermi i due precedenti per recuperare un po’ il filo di questo discorso, che si sta un po’ stiracchiando settimana dopo settimana.
SOLUZIONE N.2: L’EFFETTO DELLE STRATEGIE E TATTICHE DI MARKETING DEVE ESSERE MISURATO.
La misurazione delle attività di marketing, il che implica renderle misurabili, è necessaria principalmente per due motivi:
1. guadagnare maggiore credibilità all’interno dell’organizzazione aziendale.
2. migliorare la propria efficacia ed efficienza attraverso l’applicazione del metodo sperimentale del provare e riprovare ossia l’attivazione del ciclo PIANIFICAZIONE-ESECUZIONE-VALUTAZIONE-RIPIANIFICAZIONE.
Va sottolineato che il primo è un motivo esterno mentre il secondo è un motivo interno. Questo implica che per raggiungere il primo obiettivo non è indispensabile che la misurazione sia effettivamente efficace, è sufficente che l’organizzazione abbia la PERCEZIONE che le attività di marketing non sono arbitrarie, bensì sottoposte ad un qualche tipo di valutazione oggettiva. Può sembrare strano, ma si è visto nel post n.2 come la misurabilità dei risultati delle azioni di altre funzioni aziendali sia più presunta che effettiva.
Il raggiungimento del secondo obiettivo, su cui si fonda nel lungo termine l’effettiva crescita e consolidamento della credibilità richiede invece che il sistema di controllo sia realmente funzionante.
Il primo passo in questo senso è definire COSA dobbiamo misurare e la risposta, in ambito aziendale è abbastanza automatica: dobbiamo misurare gli effetti delle attività di marketing sull’equazione del profitto:
Profitto= Ricavi-Costi; volendo dettagliare ulteriormente
Profitto= ((Ricavo netto unitario-Costi Variabili)* Quantità vendute)-Costi fissi).
Non credo sia il necessario dettagliare ulteriormente l’equazione, ma forse val la pena di ricordare che il ricavo netto unitario è determinato dalla combinazione dei prezzi di listino, degli sconti in fattura e fuori fattura, nonchè dalla quantità di prodotto contenuto nell’unità di vendita.
Più importante è forse ricordare che le unità vendute dipendono dalla diffusione del prodotto nel mercato (distribuzione numerica e ponderata), dalla frequenza di acquisto (occasioni di acquisto) e dalla quantità acquistata in ogni occasione.
Per amor di precisione, ricordo che in realtà non c’è perfetta corrispondenza tra costi variabili/fissi e costi diretti/indiretti.
Infine sottolineo che basta sostituire le quantità vendute con quelle consumate per ottenere l’equazione del consumo invece di quella di vendita.
Potreste anche dire che non serviva che arrivassi io per darvi una lezione di economia elementare, ma, a parte dire che il marketing è la scienza dell’ovvio a posteriori, vi chiedo: quante voltre avete visto definire gli obiettivi aziendali (di qualsiasi funzioni, marketing a parte) legandoli a questi parametri?
Eccoci quindi al COME dobbiamo misurare.
Per il marketing infatti le cose sono un po’ più complicate perchè deve trovare il modo di misurare l’effetto mediato delle proprie attività su quei parametri che determinano l’equazione del profitto. La campagna pubblicitaria che modifica awareness e reputazione della marca che effetto avrà sulle vendite di baseline (fatte in assenza di promozioni) e quindi sui volumi sul ricavo medio unitario?
D’altra parte il grande vantaggio di definire gli obiettivi in base a parametri misurabili legati all’equazione del profitto è la possibilità di seguire lo sviluppo delle strategie mana mano che si realizzano e quindi di poter prendere eventuali azioni correttive. Le quantità vendute sono inferiori al previsto perchè è un problema di distribuzione, di occasioni d’acquisto/consumo o di quantità acquistate/consumate per occasione? Evidentemente le strategie da intraprendere cambiano a seconda dei casi.
Mi spiace dire che non ho (ancora) la risposta deterministica su come misurare. Il marketing agisce in ambiti complessi è cambianti, su fattori interconnessi, spesso in relatione additiva tra loro (esempio banale: la promozione sul punto vendita il cui effetto è moltiplicato dalla contemporanea campagna pubblicitaria e ridotto della riduzione della cpacità di spesa del consumatore). E’ quindi necessario che ogni azienda determini i contorni delle proprie situazioni e definisca le proprie metriche di conseguenza.
Non nascondo che magari ci si troverà a misurare le distanze con i chili oppure i pesi con i metri, me questo è l’unico percorso per arrivare ad individuare le metriche corrette e raggiungere il secondo degli obiettivi esplicitati all’inizio. Il primo nel frattempo l’avremmo raggiunto, ed è già qualcosa.
Per non chiudere lasciando troppo amaro in bocca, ricordo che c’è una misura abbastanza generale, pur senza essere la pietra filosofale della metrica di marketing, ed è il breack-even. Da quanto tempo non lo calcolate quando intraprendete un investimento di marketing? E’ vero che non può essere l’unico parametro di giudizio, ma almeno pianta un paletto da cui partire.
Chiedo venia se i concetti sono un po’ disconnessi, ma la stanchezza è tanta. Magari tornerò in forma quando tornerò ad Apple.
Terapie contro la marginalizzazione del marketing 2 e mezzo
Ho praticamente già pronta la puntata numero 3 in testa, ma oggi sono davvero troppo stanco.
Domani la scrivo, promesso.
Buona notte.
Terapie contro la marginalizzazione del marketing 2
L’altro giorno, dopo aver letto il mio (ennesimo), cahier de dolances, una persona mi ha chiesto: “Ma allora se il marketing è marginalizzato, quali sono le funzioni aziendali che contano?”.
La domanda è più che legittima e trovare una risposta risulta sicuramente importante per individuare le terapie del titolo. Per pfarlo però credo sia indispendabile prima definire cosa si deve intendere per centralità di una funzione (un po’ come per fare strategie di marketing di successo va capito cosa si intende per potere di mercato).
La centralità o marginalizzazione di una funzione e/o di una persona all’interno di una organizzazione dipende dall’importanza/peso che hanno le sue necessità e la sua visione delle cose rispetto alle altre funzioni (persone) nell’allocazione delle risorse economiche, di tempo (quantità e qualità dello staff) e di strumenti per svolgere il compito assegnato.
In questa ottica le funzioni attualmente centrali nella generalità delle aziende (ci sono sempre le eccezioni) sono l’amministrazione-finanza-controllo di gestione e le vendite.
L’altra domanda chiave è come sempre: perchè (queste due funzioni sono centrali)?
Io, ma non solo io, credo che debbano molto della propria centralità alla (presunta) misurabilità delle attività che svolgono.
La misurabilità dell’amministrazione-finanza-controllo di gestione non è messa in discussione per definizione in quanto è la funzione che misura le performances aziendali mentre le vendite sono misurabili grazie alla relazione diretta che si può stabilire tra le azioni (tattiche) di vendita ed il fatturato.
Però io ho scritto tra parentesi che la misurabilità di queste funzioni è presunta. Perchè? (sembro un bambino di due anni).
I dubbi nel caso dell’amministrazione-finanza-controllo di gestione mi nascono dalla semplice constatazione della quantità di analisi et similia, sia ad hoc che routinarie, gestite su foglio elettronico in tutti gli uffici di tutte le aziende. Credo siano una dimostrazione del gap di efficacia ed efficenza che la funzione amministrazione-finanza-controllo di gestione ha nel fornire al resto dell’azienda le informazioni di cui le diverse funzioni hanno bisogno, nel formato necessario. Nella prima azienda in cui ho lavorato, la Levoni S.p.A., il direttore amministrativo ogni anno passava a tutti gli uffici un’analisi dell’andamento delle vendite in volume, valore e prezzo medio dei principali prodotti e dei principali mercati negli ultimi cinque anni. Non l’ho visto fare in nessun’altra azienda, dove normalmente ci si limita al confronto anno precedente e budget. Mi viene quindi da dire che la situazione generale non è di soddisfacimento da parte della funzione amministrazione-finanza-controllo di gestione delle esigenze del resto dell’azienda, bensì che la centralità di questa fa sì che le sue esigenze/punto di vista siano prevalenti su quelle delle altre, che quindi si arrangiano come possono (dedicando tempo prezioso allo sviluppo e gestione di fragili files excel). Ulteriore indizio al riguardo è la tranquillità con cui nelle aziende si accetta che l’implementazione di un nuovo programma gestionale che costa svariati milioni di euro, richieda svariate centinaia di migliaia di euro in consulenze e lasci l’azienda con una disponibilità limitata di dati (quando non nel buoi totale) per un periodo che va dai 6 mesi ad un anno. Avendo sempre lavorato nei beni di largo consumo dove un ritardo di un giorno nella consegna rischia, giustamente, di farmi perdere il cliente, devo dire che questa cosa mi affascina.
La presunzione della misurabilità delle vendite è ancora più evidente, basta considerare l’effetto moltiplicatore delle vendite (volumi e prezzi) di una campagna pubblicitaria/comunicazione o solo di un forte posizionamento della marca. Probabilmente solo le promozioni basate sullo sconto sono l’unico strumento di vendita dove l’influenza delle politiche di marca e poca o nulla. Però sempre più rapidamente promozioni di questo tipo portano ad un riposizionamento del proezo di vendita, in un circolo vizioso che spesso si rivela insostenibile.
La conclusione più importante che ho tratto da queste riflessioni è però il rafforzamento della mia convinzione della necessità di individuare e sviluppare reali parametri di misura per le attività di marketing. Viceversa continueremo ad essere marginali rispetto a quelle, presuntamente, misurabili e non riusciremo a dare il nostro apporto in azienda.
Aspettative quindi, non prometto quando, una terza (e forse anche quarta) puntata.
Terapie contro la marginalizzazione del marketing 1
Dopo la sommaria anamnesi e diagnosi dei giorni scorsi vediamo quali possono essere le soluzioni/azioni per ridare al marketing il necessario ruolo strategico all’interno delle aziende. Non mi dilungo sul perché questo sia necessario, perché il tema è stato l’argomento del primo post di questo blog (in realtà è la questione da cui tutto il blog ha preso le mosse oramai alcuni anni fa), che consiglio di leggere, se non l’avete già fatto.
La premessa ovvia ma doverosa è che la soluzione le possibili soluzioni non sono facili, né da formulare né da realizzare. Per questo ho deciso di scriverle a puntate: 1 post per soluzione, con considerazioni che derivano in parte dal solito “Marketing Management” ed in parte dalle mie riflessioni.
SOLUZIONE N. 1: IL MARKETING DEVE TORNARE AD ESSERE TEORICO
Il marketing deve tornare ad essere una scienza (sociale) di gestione delle organizzazioni. Deve tornare a sviluppare ipotesi teoriche strutturate con rigore (non sovrastrutture) relativamente a come le strategie e tattiche di marketing impattano la realtà (di mercato).
Esempio di vita vissuta (tanto oramai nessuna delle aziende e persone coinvolte sono più quelle che erano): primi mesi del 2004, riunione dei direttori marketing del Gruppo Eckes-Stock (tipo barzelletta: ci sono un italiano, un boemo, un’austriaca ed una tedesca). La mia collega tedesca presenta con giusta soddisfazione la crescita di vendite dell’anno precedente e passa a presentare COSA è stato fatto, con una tipica presentazione di condivisione di best practice. Per valutare se e cosa poteva valer la pena di trasferire sul mercato italiano, quando finisce gli chiedo una sua analisi sul PERCHE’ quelle cose avessero funzionato. Lei mi dà spiegazioni semi-tautologiche tipo con questa “sponsorizzazione abbiamo ottenuto un aumento di awareness” e mi dà ulteriori dettagli sul COME hanno realizzato le diverse cose. Io me ne torno a casa perplesso, anche perché non condividevo molto il focus dato dal top management tedesco: “stiamo perdendo vendite, dobbiamo sforzarci a FARE QUALCOSA per invertire la tendenza”.
Primi mesi del 2005, solita riunione dei direttori marketing del Gruppo Eckes-Stock di inizio anno, la mia collega tedesca è piuttosto abbattuta perché nell’anno appena trascorso le vendite sono calate, tornando sotto ai livelli del 2002. Soprattutto è preoccupata nel 2004 hanno confermato le stesse strategie che avevano funzionato così bene nel 2003 e quindi non capisce il motivo della perdita di fatturato, né sa cosa fare per affrontare il problema.
Mancava un quadro teorico di riferimento che fornisse una comprensione al di là del meccanismo stimolo-risposta, grazie a delle ipotesi sui motivi di quella risposta a quello stimolo. In altre parole mancava l’idea del percorso che portava dallo stimolo alla risposta.
Elemento fondamentale del rigore teorico è l’approccio sperimentale, nel senso galileiano del termine. Se infatti un quadro teorico è indispensabile nelle fasi di pianificazione ed esecuzione delle strategie, diventa poi cruciale la valutazione dei risultati per ripianificare con maggiore efficacia ed efficienza. Si va così a creare il circolo virtuoso PIANIFICAZIONE-ESECUZIONE-VALUTAZIONE-RIPIANIFICAZIONE.
Per realizzare l’approccio sperimentale ed evitare di fermarsi alla pura teoria, col rischio di riportare il marketing nella torre d’avorio dell’astrazione, sono quindi necessari dei metodi di analisi. Che saranno quindi l’argomento della prossima puntata.
Logo Barilla: evoluzione-rivoluzione e ritorno
Premessa: in questi anni di lavoro ho realizzato più volte cambiamenti di immagine di marchi/prodotti in senso evolutivo. Keglevich (2 volte), Limoncè, Brandy Stock, Grappa Julia, Santa Margherita sono i primi che mi vengono in mente. La questione è sempre di modificare l’aspetto dei marchi/prodotti in modo che le persone le percepiscano “meglio” rispetto al posizionamento voluto (più prestigio, più genuinità, più contemporaneità, più freschezza ecc.) senza quasi rendersi conto del cambiamento. In altre parole il prodotto diventa più “bello”, ma se non metto di fianco le due versioni (prima e dopo) difficilmente riesco a dire cosa è cambiato.
Visto che oramai sono vecchio del mestiere ho realizzato anche cambiamenti in senso rivoluzionario. I wurstel Principe sono diventati Wulevù, il Wapping Gin, l’amaro Radis, la grappa Goccia, i vini della Cantina Torresella e quelli della Tenuta Sassoregale. In questi casi l’aspetto delle marche/prodotti è talmente distonico rispetto al posizionamento voluto, che diventa necessario creare una rottura, nei casi estremi facendo un prodotto totalmente nuovo anche in termini di nome e di caratteristiche organolettiche (visto che ho sempre lavorato nell’alimentare).
Pensavo a queste cose oggi quando mi è arrivato l’invito per un convegno organizzato da Barilla, su una carta intestata che riportava il nuovo logo corporate che vedete qui sotto
E’ evidente, magari anche logico e condivisibile, che Barilla abbia voluto cercare di darsi un logo che possa rappresentare meglio l’allargamento del suo ambito di business, eppure non posso fare a meno di chiedermi perchè abbia abbandonato il suo logo storico:

Il nuovo logo corporate sarà anche graficamente è più pulito ed ha proporzioni che ne rendono sicuramente più semplice l’utilizzo sui più diversi materiali, però è artificiale. Sembra la copia fredda (non solo per il colore blu) di quello originale. Non so se è solo questione che quello originale (mantenuto per la pasta) sono abituato a vederlo da quando sono nato, argomento comunque non banale. Secondo mè è soprattutto dovuto al fatto che è troppo uguale, senza essere lui. Una volta qualcuno mi ha raccontato che l’ovale bianco contornato di rosso che fa da sfondo alla scritta Barilla è la stilizzazione di un uovo (che tra l’altro è l’esempio del packaging design perfetto) per richiamare la genuinità e la ricchezza degli ingredienti con cui veniva fatta la pasta Barilla. Non ho mai saputo se la storia fosse vera o meno, però è sicuramente bella ed altrettanto sicuramente poco conosciuta. Se proprio devo decidere che devo mettere una didascalia al mio logo (non proprio un sintomo di forza di marchio) almeno che sia affascinante.
Il logo corporate avrà (forse) guadagnato qualcosa in stile, ma ha perso molto in anima.
Chiudo rispondendo alla prevedibile obiezione che uno è il logo corporate e l’altro è quello di un’azienda (o strategic business unit che dir si voglia): non ho mai creduto alle aziende ed alle marche schizofreniche con personalità dissociata. Una marca è un insieme di segni a cui le persone attribuiscono un determinato significato, quindi o le varianti di marchio sono abbastanza simili da trasmettere lo stesso significato (Barilla corporate o Barilla pasta che sia) oppure sono abbastanza diverse da trasmettere due significati diversi (di conseguenza non capiscono più di cosa si sta parlando).
L’impressione guardando la cosa totalmente dall’esterno è che in Barilla abbiano quello che il mio maestro di scherma rumeno chiamava un attacco a coda di pesce, quando volendo fare una cosa, senza però esserne convinto fino in fondo, veniva fuori una cosa a metà, che andava un po’ da una parte ed un po’ dalla parte opposta.
Il 99% delle volte uno prendeva la stoccata, ma non è detto che questo succeda anche ai signori di Barilla perchè il mondo degli affari perdona molto di più degli avversari in pedana.