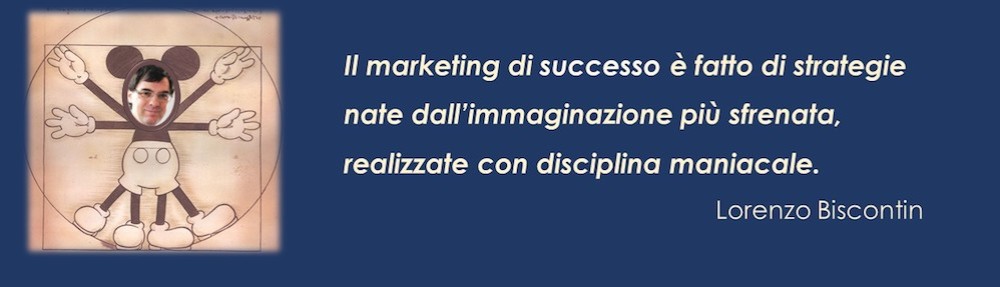Negli ultimi tre mesi mi sono trovato a riflettere sul concetto di “eterodossia” (i motivi che mi hanno spinto a farlo non sono importanti).
Questa riflessione mi ha portato al convincimento che il senso delle situazioni si può comprendere in larga misura partendo dal significato preciso delle parole che le descrivono. I ragionamenti sul concetto di eterodossia sono infatti proseguiti per quelle che potrei definire “tautologie successive”.
A ben guardare anche il titolo è una tautologia come si nota analizzando il significato della parola eterodossia:
Wikipedia: Con la parola eterodossia, dal greco heteros («diverso», «differente») e [[Doxa (filosofia)|doxa}} («opinione», «dottrina]]») ci si riferisce ad una serie di opinioni, ideologie, scelte di vita o credenze non in linea con quelle dominanti o maggiormente diffuse. È spesso usata, in modo contrastivo con ortodossia, per sottolineare e rivendicare la propria posizione non allineata a quella tradizionale.
Devoto-Oli: Atteggiamento di totale o parziale distacco dalle idee imposte o subite dalla maggioranza in determinati campi..
L’eterodossia è importante dal punto di vista della strategia (aziendale) perchè è la base dell’innovazione (o volendo si può anche dire che l’innovazione è sempre eterodossa), ergo del progresso (delle persone, delle organizzazioni, ecc…Scegliete voi la dimensione a cui volete riferirvi).
Risulta interessante come l’eterodossia si definisca in base all’ortodossia (non viceversa) perchè in realtà l’innovazione di successo nasce (quasi sempre) dal SUPERAMENTO dell’ortodossia. Citando Picasso “A quattro anni dipingevo come Raffaello
mi ci è voluta una vita intera per imparare a disegnare come un bambino”.
Non si tratta di fare qualcosa di diverso dal solito per il semplice gusto di farlo o per spirito di contraddizione. Si tratta di trovare un modo nuovo e proprio per risolvere le situazioni meglio di quanto non si possa fare con i modi ortodossi. L’eterodossia efficente parte dai limiti dell’ortodossia, che possono essere risonosciuti solamente se si ha il dominio della materia.
Conoscere la genesi dell’eterodossia che si ha di fronte serve per valutarne la credibilità e quindi ridurre la (forte) resistenza al cambiamento delle organizzazioni che puntano a garantire e massimizzare efficacia ed efficienza.
Per definizione (tautologia) l’eterodossia è destabilizzante e, sempre per definizione, la destabilizzazione spaventa.
Per questa ragione spesso si cerca di favorire l’adozione dell’innovazione nascondendone l’effettivo livello di cambiamento. E’ una soluzione che funziona solamente se l’adozione dell’innovazione è semplice in termini di processo e porta rapidamente a risultati che permettono di fugare qualsiasi dubbio.
Se invece l’adozione dell’innovazione richiede un intervento sui processi (quindi sull’organizzazione delle persone) ampio nel tempo e nello spazio prima di ottenere i risultati, sarà più efficace esplicitarne l’origine dall’ortodossia.
Lo so che, soprattutto a quest’ora tarda, il post puzza di fuffa, eppure è STRATEGIA (e i due termini NON sono sinonimi).