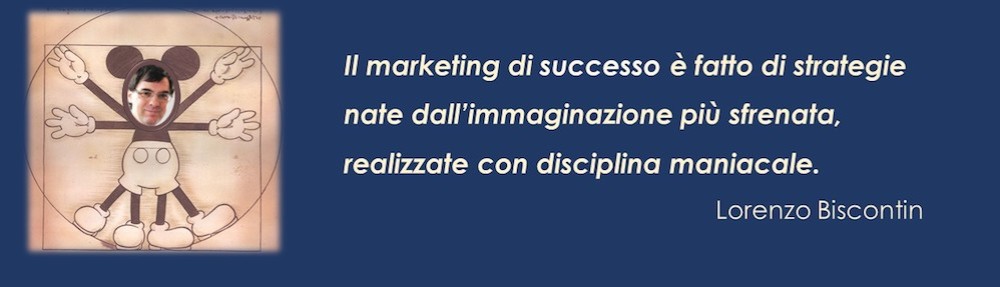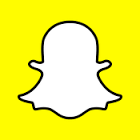Mi sono (un po’) riposato e quindi eccomi con il post preannunciato domenica scorsa.
Circa un anno fa mi sono trovato coinvolto in uno scambio di battute su facebook riguardo alla correttezza o meno di sincronizzare i profili social, poi la settimana scorsa ho partecipato su twitter ad una discussione più articolata sullo stesso argomento, nata dagli spunti al riguardo sorti nei seminari organizzati al forume wine2wine di Vinitaly.
Per sintetizzare il mondo si divide in due grandi categorie (che bello: sognavo da anni di scrivere questa frase): quelli che sincronizzano i propri profili social in modo da pubblicare in automaticamente sui vari medium e quelli che invece pubblicano post/aggiornamenti di stato specifici per ogni social.
I primi lo fanno principalmente per praticità, i secondi per accuratezza. Aggiungo che ho l’impressione che i secondi guardino i primi con una certa dose di sussiego, considerando il mancato adattamento del messaggio ad ogni medium una pigra sciatteria (l’ozio, si sa, è il padre dei vizi) ed una negligente mancanza di attenzione e rispetto nei confronti dei propri lettori.
Chi ha ragione? Dipende! (anche questa è una di quelle espressioni classiche che sognavo di scrivere da anni).
Klout, che è un sito/strumento di misurazione dell’influenza in rete, consiglia di collegare i network per aumentare il proprio punteggio Klout. La teoria classica della comunicazione indica di gestire in modo specifico ogni medium per:
- essere rivolta direttamente al consumatore;
- espressa nel linguaggio che il consumatore utilizza normalmente;
- concentrata su una sola idea;
- concentrata sull’idea chiave identificata dalla ricerca di mercato;
- avere un trattamento unico e competitivo;
- essere credibile, non ingannatoria;
- essere semplice, chiara e completa;
- avere un messaggio combinato strettamente con il prodotto (servizio) che promuove;
- sfruttare pienamente il mezzo utilizzato;
Queste sono le regole di una buona pubblicità che utilizzava nel 1988 (ossia, preistoria) una grande agenzia pubblicitaria multinazionale (la Publicis se non ricordo male). Le trovate commentate, ragionate ed integrate con altre considerazioni più recenti nel mio vecchio post “Teoria e tecnica della comunicazione (digitale)”.
Tornando a noi: dipende. Dipende da diversi aspetti, che vado ad analizzare partendo da quello che faccio io.
Io collego i diversi social networks in cui sono presente in una sola direzione. Linkedin è collegato a Twitter che è collegato a Facebook. Il mio ragionamento quindi è che tutto quello che pubblico su Linkedin ha senso che vada anche su twitter e tutto quello che va su twitter ha senso che vada anche su facebook. Non viceversa, nè tra fb e twitter, nè tra twitter e linkedin.
Ho anche un profilo Instagram e fino ad oggi quello che ho pubblicato su Intragram l’ho sempre collegato a Twitter, quindi fb.
Ho anche un profilo Google +, che sostanzialmente non uso.
Mentre scrivo mi chiedo se Whatsapp sia o meno un social network; fino ad oggi non l’ho mai considerato tale e quindi per il momento lo escludo dalla trattazione di questo post.
Ecco quindi, secondo me, da cosa dipende la scelta se, e cosa e quanto, collegare i diversi profili social.
1-Praticità/tempestività: la tempestività nella comunicazione sui sociale è cruciale. La praticità della sincronizzazione aiuta la tempestività. Se devo scegliere tra accuratezza e tempestività, io non ho dubbi nel scegliere la seconda.Una cosa detta perfettamente, ma in ritardo vale molto meno di una cosa detta in modo approssimativo ma nel momento giusto. Quindi l’equilibrio tra praticità ed accuratezza, ossia collegamento o targettizzazione della comunicazione social, dipende dalle risorse di tempo e persone che potete dedicarci. Se ne avete tante potete permettervi di personalizzare ogni contenuto rispetto al medium che utilizzate, viceversa collegate.
2-Coerenza/identità: non crediate che questo punto sia in relazione con il precedente, perchè non è così. Collegare i propri social network in modo da pubblicare la stessa cosa in contemporanea su tutti è garanzia di identità e di coerenza della comunicazione.
Io dico spesso che l’ideale sono marche dalla personalità articolata perchè questo permette di stare nei diversi contesti nel modo migliore, senza perdere se stessi. In altre parole, non è necessario essere integralisti per essere coerenti. Però bisogna stare attenti anche a non essere schizofrenici, contraddicendo se stessi a seconda del medium in cui mi trovo.
3-Riduzione della ridondanza: ho scritto “riduzione” perchè, come ho detto diversi anni fa, la rete è pervasiva. Quindi un certo livello di ridondanza è inevitabile.
Cosa intendo per ridondanza? Il fatto che parte dei miei amici di facebook sono anche i miei follower di twitter e i istagram, nonchè i miei contatti di Linkedin. E questo malgrado il mio tentativo di mantenere facebook nella sfera del privato. Il motivo per cui di fatto non uso Google+ è proprio perchè in questo caso la sovrapposizione dei contatti con gli altri social sarebbe massima. Non posso evitare lo “spam” di dire la stessa cosa più volte alla stessa persona sui diversi social networks, ma collegandoli la dico nello stesso modo e così lui/lei potrà riconoscerla subito e capire di averla già vista.
Cito testualmente la dichiarazione di Leslie Petry, Direttore Marketing della società di media intelligence “Aggregate Knowledge” di San Mateo, California: “Un sacco di aziende oggi stanno parlando/raggiungendo alle persone, ma non capiscono che stanno parlando alle stesse persone attraverso una molteplicità di canali diversi, e che forse gli stanno parlando così tante volte da generare una immagine negative per la marca”
Questo punto HA una relazione con il punto 2, nel senso che minore la sovrapposizione delle audiences tra i diversi social networks e minori sia i problemi di ridondanza che quelli di identità e coerenza.
4-Contenuti: la vostra comunicazione si caratterizza per il contenuto informativo o per l’intrattenimento? Nel primo caso il rischio di perdita di efficacia comunicativa implicito nel collegare i diversi social e minore rispetto al secondo. L’informazione infatti ha una base fattuale che non cambia sui diversi medium, mentre l’intrattenimento fatto nella forma sbagliata rispetto al medium …. non intrattiene.
5-Fonte: io collego, parzialmente, i social network perchè tutti i miei profili sono personali quindi la valutazione dei punti 1, 2 e 3 tendono verso la sincronizzazione (per il punto 4 posso decidere di volta in volta riguardo ai social più eterogenei e trasversali che sono, secondo me, facebook ed instragram). Dovendo gestire dei profili aziendali è (forse) più probabile avere maggiori risorse, una personalità meno definita, delle audiences meno sovrapposte e contenuti prevalentemente caratterizzati dall’intrattenimento. Quindi la valutazione dei punti precedenti si sposta verso la targettizazione. Dipende dalla dimensione e della strutturazione dell’azienda: l’artigiano, anche se è azienda, si avvicina di più al caso dei profili personali; la multinazionale al caso dei profili aziendali.
Attenzione però: non so per quanto durerà questa distinzione tra individui ed aziende. Nella società digitale la comunicazione si basa su rapporti tra pari, ossia, in sintesi, tra persone, poco importa se fisiche o giuridiche.
Concludo notando che tendenzialmente coloro che hanno meno di 25 anni collegano i propri profili social (e non sono nè andranno su fb). Se tanto mi da tanto, al di là di tutti le mie elucubrazioni qui sopra, è molto probabile che il futuro sarà questo.