Post pubblicato lunedi’ sul mio blog su Vinix. Per gli affezzionati lettori di biscomarketing ecco il link.
https://www.vinix.com/myDocDetail.php?ID=8256
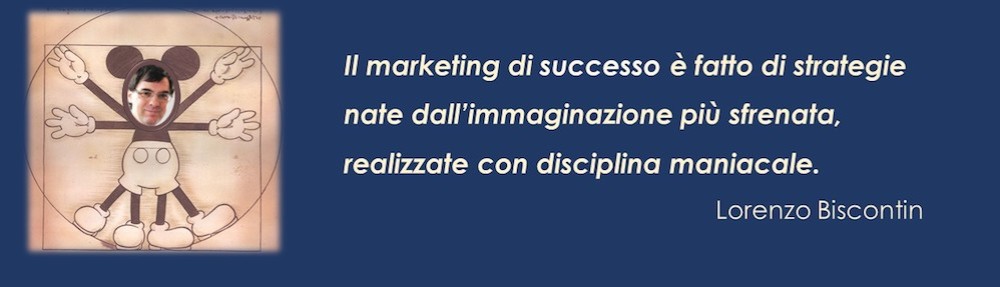
Post pubblicato lunedi’ sul mio blog su Vinix. Per gli affezzionati lettori di biscomarketing ecco il link.
https://www.vinix.com/myDocDetail.php?ID=8256
Oggi stavo preparando le lezioni sull’impostazione della marca per il Corso di Alta Specializzazione in Marketing Internazionale del Vino per la prossima settimana e quindi sono venuto sul blog a cercare il post sul concetto di supermarca.
Con mio grande stupore non ho trovato niente.
Lo stupore è duplice, sia perché ero convinto di aver scritto un post al riguardo sia perché ritengo il concetto di supermarca uno dei più utili ed interessanti tra quelli che ho sviluppato in tutti questi anni di ricerca e di professione.
Ho definito il concetto di supermarca nel 2005 o 2006 quando lavoravo come Direttore Marketing in Stock per avere un modello teorico che mi aiutasse a comprendere, e quindi gestire, meglio un fenomeno empirico che riguardava la Keglevich Vodka e Frutta.
Avevo osservato infatti che in seguito alle strategie di rilancio della marca iniziate nel 2001 le vendite continuavano a crescere, malgrado il declino della categoria.
Mi spiego meglio. Nei primi tre / quatto anni di realizzazione del nuovo piano di marketing, la quota di mercato di Keglevich Vodka e frutta era cresciuta perché le sue vendite erano cresciute più della crescita del mercato. Si trattava di una situazione abbastanza “normale” per cui la crescita del leader di mercato, Keglevich lo era con una quota del 44%, aveva avuto un effetto un effetto di trascinamento dei consumi di tutta la categoria merceologica di appartenenza.
Poi però la quota di Keglevich Vodka e Frutta aveva continuato a crescere perché le sue vendite in valore assoluto crescevano, mentre quelle della categoria calavano.
In altri termini l’andamento delle vendite di Keglevich Vodka e Frutta prescindevano e trascendevano da quelle della sua categoria merceologica (anche la quota della Keglevich bianca cresceva, quindi le sue vendite aumentavano più di quelle della categoria merceologica, che però era comunque in crescita).
Si trattava di un comportamento che mi ricordava quello del vermouth Martini: le vendite di vermouth erano in calo da almeno dieci anni e l’immagine del vermouth come categoria merceologica era assolutamente desueta, polverosa ed antiquata, ma il vermouth Martini continuava ad essere un prodotto di successo, con un percepito di contemporaneità, stile, ecc…
Il lavoro di posizionamento, e quindi differenziazione fatto sulla marca aveva di fatto staccato la percezione del (vermouth) Martini da quella del vermouth tout-court.
Ho immaginato che la stessa cosa stesse succedendo per la Keglevich Vodka e Frutta e l’ho dichiarata una supermarca all’interno dell’organizzazione aziendale, ossia anche nella percezione delle altre funzioni, quali vendite, produzione, acquisti, amministrazione, ecc…, e delle altre aziende del gruppo. Di conseguenza questa percezione si è trasferita anche ai clienti. Nei confronti dei consumatori questa presa di coscienza non era necessaria, perché loro ci erano già arrivati grazie alle attività di marketing che avevamo realizzato.
Ma quindi cos’è che fa di una marca una supermarca? Nella mia visione il fatto che il suo trend di vendita sia positivo ed in controtendenza rispetto alla sua categoria di appartenenza. Non basta quindi che sia leader e che aumenti la sua quota perché cala meno del mercato, deve crescere in valore assoluto all’interno di una categoria che diminuisce.
Da cui si conferma l’importanza di osservare anche gli andamenti dei valori assoluti dei diversi indicatori che misurano le performances di una marca (vendite in volume, valore, prezzo unitario, numero di clienti, ecc..) e non solo dei loro rapporti competitivi (quote di mercato, distruzione numerica e ponderata, ecc..)
Riconoscere che si ha in mano una supermarca è estremamente utile perché la sua gestione efficace richiede alcuni cambiamenti rispetto all’approccio classico:
Se la supermarca trascende dalla propria categoria è evidente che la quota di mercato classica diventa un indicatore pericolosamente parziale per capire se la nostra supermarca si sta indebolendo o rafforzando rispetto al mercato più ampio in cui viene collocata dai consumatori. Per seguire lo sviluppo della nostra supermarca in quanto tale diventa quindi necessario allargare il mercato di riferimento su cui misurarne le performances.
La supermarca compete nella mente del consumatore con concorrenti che vanno al di là dei prodotti appartenenti alla categoria. Anzi è probabile che nel momento in cui diventa supermarca, la nostra marca non si confronti più con i prodotti della sua categoria.
La definizione del set competitivo corretto è cruciale per osservare e controllare le attività dei concorrenti e l’atteggiamento del mercato nei loro confronti.
Nel caso della Keglevich Vodka e Frutta io ho cominciato a confrontarla in due contesti: quello dei liquori e distillati nella loro totalità e quello dei “night spirits” come categoria creata ad hoc.
Nel mercato dei superalcolici esisteva già la categoria dei “white spirits”, basata sul colore e comprendente rum, vodka, gin e tequila. Quella dei “night spirits” invece era una categoria basata sull’atteggiamento del consumatore e le modalità di consumo che quindi oltre ai “white spirits” comprendeva anche, ad esempio, l’amaro Jegermeister.
Per sviluppare e rafforzare una supermarca come tale, la visione dello scopo e posizionamento della marca che guida le strategie (di marketing) deve essere più ampio rispetto ad una marca “normale”. E’ proprio grazie a questa visione più ampia che le attività di marketing differenziano la marca non solo rispetto ai concorrenti “naturali”, ma anche alla categoria in generale.
La supermarca trascende così dai codici della categoria e si porta ad un livello superiore.
Quello sinteticamente descritto qui sopra è il percorso per gestire con efficacia ed efficienza una supermarca. E già questo è un bel risultato.
Ancora più bello però è riuscire a creare una supermarca.
Per farlo si può usare lo stesso percorso, seguito però in senso inverso. Partendo quindi dalla definizione della nostra marca che ne allarghi i confini, pianificando le relative strategie e costruendo gli strumenti di controllo in grado di guidarci ed orientarci nei nuovi territori.
Perché, come sempre, se vogliamo realizzare qualcosa dobbiamo prima immaginarlo.
Qualche settimana fa si parlava con un amico, già giornalista, redattore e pubblicitario dell’ineluttabilità (secondo me) del ruolo editoriale delle aziende e quindi della direzione marketing come editore/direttore responsabile dei contenuti raccolti, creati o sviluppati dalle aziende.
Lui era contrario, nel senso che non vedeva nelle aziende le competenze per svolgere questa funzione (concordo al 100%), che dovrebbe rimanere patrimonio dei professionisti dell’informazione.
Questa la sintesi, per i curiosi però descrivo di seguito il percorso del ragionamento.
Per quelli che invece vogliono sapere davvero cosa succede nel mondo dell’informazione rimando, come sempre al sito Datamediahub.
1. (la maggior parte de) I giornali (italiani) sono morti.
O meglio si sono suicidati. Nell’ormai lontanissimo 30 agosto 2008 ho pubblicato un post dal titolo “Perchè i giornali si stanno suicidando“. Non ho molto da aggiungere a quanto scritto allora (è un post breve, una volta ero più bravo), se non che la situazione è andata peggiorando.
Non faccio distinzione tra edizioni cartacee ed on line. Quello che sta uccidendo i giornali è la pochezza dei contenuti, l’imprecisione (se non peggio) delle notizie, il livello sempre più basso della scrittura.
Non a caso, ad esempio, diffusione e raccolta pubblicitaria de “L’Internazionale” sono in crescita.
La questione non riguarda solo l’Italia, ma in Italia mi sembra più evidente. Andate a guardare, ad esempio, i siti di El Pais o del Guardian, dove non esistono “colonne destre” piene di notizie da click baiting e capirete cosa intendo.
2. La comunicazione delle aziende / marche si baserà sempre di più nella raccolta, selezione e creazione di contenuti.
La pubblicità come strumento di spinta al consumo è morta tanto quanto i giornali (non fatevi ingannare / impressionare dagli zombis dell’uno e dell’altro tipo che vedete ancora in giro).
Il posizionamento delle marche si costruisce e rafforza legando alla marca dei contenuti. Quanto più i contenuti sono originali, tanto più il posizionamento sarà forte (ampio e profondo).
Quindi tutte le aziende oggi di fatto operano (anche) nel settore dell’editoria (altrimenti perchè hanno un sito, un profilo facebook, twitter, instagram, pinterest, ecc…).
In Italia ha fatto sensazione ENI che dialoga alla pari con Report. In giro per il mondo ci sono già esempi di aziende che pubblicano giornali, e non intendo house organ. Io nel mio piccolo per 3 anni al Vinitaly ho pubblicato un’edizione quotidiana di “Santa Margherita News”.
3. Perchè siano credibili, le aziende devono gestire direttamente la creazione dei contenuti.
Nuovamente non è una questione di forma ma di sostanza. Comunicare contenuti non è come fare pubblicità e quindi non basta definire una copystrategy, definire un brief con l’agenzia ed aspettare che loro preparino la campagna.
Questo significa che le aziende devono dotarsi di competenze giornalistiche al loro interno (la creazione dei contenuti, altro non è che giornalismo). Tutte le diverse competenze giornalistiche necessarie per gestire la creazione e diffusione di contenuti.
Oggi le aziende hanno questo tipo di competenze? Al 99,9% no.
Ma questo non sposta di una virgola i termini della questione. Se vogliono competere con successo dovranno svilupparle / acquisirle.
Il salto più difficile è quello culturale, in termini di visione del proprio lavoro e del proprio ruolo. Le competenze sono quasi un tecnicismo.
In realtà è un processo che non ha niente di nuovo: con lo sviluppo delle analisi di mercato, ad esempio, la funzione marketing aziendale ha dovuto acquisire competenze che le permettessero di gestire ed interloquire con gli Istituti di ricerca.
Affidare ad una società esterna la gestione dei propri contenuti e continuare in azienda a lavorare come prima è una finta scorciatoia che non porta in realtà da nessuna parte.
Per me il quadro è chiaro. Mi rimane solo un dubbio: chi formerà le prossime generazioni di giornalisti?
I giornali non lo stanno più facendo. Le aziende saranno in grado di fare un salto mortale culturale così difficile?
Uno dei temi di analisi e discussione più caldi nella comunità dei professionisti marcom (marketing e communication) negli U.S.A. oggi è quello degli ad blockers.
In sintesi gli adblocker sono sostanzialmente dei programmi (chiedo scusa ai nerds) che evitano il caricamento delle diverse forme di pubblicità durante la navigazione su pc, tablet e smartphone. L’utilizzo di adblockers da parte delle persone secondo Wikipedia è in forte crescita e tra il 2014 e 2015 è cresciuto del 41% a livello mondiale e del 48% negli USA. Si stima che nel 2015 circa 45 milioni di cittadini USA utilizzasero ad blockers.
In realtà concettualmente gli ad blockers non sono niente di nuovo, visto che i primi televisori con un sistema di videoregistrazione incorporato che permettevano di saltare la pubblicità risalgono al 1999. Praticamente il televisore registra i programmi eliminando automaticamente la pubblicità che quindi non appare quando poi i programmi vengono visti dall’utente. Il sistema più diffuso, esistente ancora oggi, è TiVo.
Ossia: i professionisti di marketing, comunicazione e pubblicità hanno la conferma del “sospetto” che le persone se possono preferiscono evitare la pubblicità da oltre 15 anni.
Eppure non hanno modificato di una virgola il loro approccio strategico basato sul rincorerre (perseguitare) le persone in ogni momento possibile. Invece di cambiare strategia di comunicazione (contenuti e media) nel 2002 i principali network televisivi americani per proteggere i propri investitori (e quindi i propri profitti) hanno fatto causa a Replay TV (concorrente di TIVO poi fallito) sulla considerazione che saltare la pubblicità viola i diritti di copyright.
Allucinante. Allucinante perchè più che “miopia di marketing” è un comportamento da “autismo di marketing” che non vuole accettare la realtà. E la realtà è che le persone non guardano la pubblicità, se gli togliete TIVO, si alzeranno e andranno a fare altro durante gli spot oppure semplicemente non gli daranno attenzione.
Il parametro classico che si è utilizzato per misurare l’efficacia della pubblicità nei media classici (televisione, giornali, radio, ecc…) è il GRP o Gross Rating Point. Io l’ho studiato per la prima volta nel 1989 durante il mio corso di Marketing Management all’università di Guelph in Canada. Sul testo di Philip Kotler il GRP viene definito come Reach x Frequency x Attention, ossia il numero di persone che sono raggiunte dal messaggio x il numero di volte che lo vedono x per l’attenzione che gli danno. Perfetto.
Peccato che poi quando sono entrato in azienda ed ho cominciato a lavorare con le agenzie di pubblicità e con le concessionarie che vendevano spazi pubblicitari (grandi quotidiani e riviste, RAI, Canale 5, Rete 4, Italia 1, grandi emittenti radio nazionali), di fatto il GRP veniva misurato solo come Reach (spesso in % sul totale del mercato obiettivo) x Frequenza. Io chiedevo lumi riguardo alla componente di “Attenzione” e loro mi guardavano come un alieno che crede di sapere come va il mondo solo perchè a letto un libro. Non è che non considerassero il parametro l’Attenzione per partito preso, è che si tratta di un parametro difficile da determinare e poi non era così importante partendo dal presupposto che tanto le persone si “bevono” tutto quello che i media gli propinano.
Questa stessa logica di spinta (push) è stata applicata all’attuale realtà di proliferazione e frammentazione dei media, con la crescita dei media digitali e dei social network.
Ecco quindi l’uso del big data così da (per)seguire il consumatore sempre più da vicino grazie a strumenti come il re-marketing (la tecnica di cui tutti siamo stati vittime grazie alla quale se cerco on line informazioni su una polizza auto, continuerò a ricevere pop up pubblicitari delle diverse compagnie assicurative fino alla morte; se volete provare qualche brivido guardate la spiegazione che ne dà la guida di adwords di Google)
Con un atteggiamento dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia, l’industria della pubblicità ha fatto finta di non sapere che questo modo di operare infastidiva le persone, tanto da creare un’attenzione negativa che danneggia la percezione dei marchi troppo invadenti.
Come se la rivoluzione digitale fosse solo tecnologica e non culturale.
Con l’uso degli adblockers le persone stanno dando un’informazione importantissima ai professioni del marketing e della comunicazione: il modo in cui vi rivolgete a noi non ci piace nè ci interessa.
Incapaci di adattarsi alla nuova realtà, la risposta dell’industria della comunicazione è: “ed io trovo il modo di mostrarti comunque la mia pubblicità”. Anche ammesso che ci riesca (cosa di cui dubito) questo non renderà la pubblicità più piacevole ed interessante per le persone. E quindi sarà fatica sprecata.
Il motto dell’Università di Guelph riportato sul logo che apre questo post dice “Rerum Cognosere Causas”, ossia conoscere la ragione delle cose.
Resto sconcertato vedendo come professionisti seri e preparati a fronte della scoperta di cose sgradevoli che li riguardano direttamente rispondano facendo semplicemente finta di niente.
Forse sono troppo abituati a (credere di) essere loro quelli che le determinano. La realtà vi seppellirà.
Colonna sonora per questo post: “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli.
La scorsa settimana mi sono occupato delle strategie di web marketing dal punto di vista concettuale (quasi dottrinale direi).
Oggi vado sull’operativo sintetizzando un interessante articolo uscito sul numero di novembre 2015 di “marketingnews”, una delle riviste dell’American Marketing Association (ho già detto che consiglio di associarsi?) a firma di Christine Birkner.
L’articolo originale ha esattamente lo stesso titolo di questo post, solo in inglese, ed indica 6 punti chiave per massimizzare i propri investimenti di marketing e comunicazione attraverso il SEO (che per i meno esperti significa Search Engine Optimization).
Prima di passare ai sei punti però alcune considerazioni generali sui principali fattori che avranno impatto sul SEO nel 2016 secondo uno studio della società di consulenza Moz Inc. di Seattle.:
- usufruibilità sui dispositivi mobili (smartphone e tablet): impatto + 88%.
- analisi del valore percepito delle pagine: impatto + 81%.
- dati di utilizzo delle pagine come il dwell time (tempo effettivo che un visitatore passa su una pagina web prima di tornare alla pagina dei risultati della ricerca sul motore di ricerca): impatto + 67%.
- leggibilità e design delle pagine: impatto +67%.
Lo studio identifica anche i fattori che ridurranno il loro impatto SEO nel 2016, quali l’efficacia di link a pagamento (-55%) e l’influenza dell’anchor text (il testo cliccabile di un link che porta ad una pagina, normalmente in blu) con -49%.
Ma veniamo ai sei consigli su come ottimizzare il SEO:
1. Intention is everything:
Non c’è può bisogno di focalizzarsi sulle parole chiave. Oggi i motori di ricerca si sono fatti più furbi (o più raffinati) e guardano a come le persone interagiscono con le pagine/sito. Vanno avanti e indietro tra la pagina dei risultati della ricerca sul motore di ricerca (SERP), oppure trovano sul sito quello che cercavano?
Prima per il SEO bastava preoccuparsi di avere i “clicks”, oggi è fondamentale l’attività dopo il click. Non basta più solamente avere i clicks, bisogna soddisfare l’intenzione / aspettativa dell’utente.
2. Keywords aren’t the be-all and end-all:
Inserire parole chiave nei titoli sta diventando meno importante. Una volta se si voleva migliorare la propria classifica come “miglior ristorante”, scrivevi “miglior ristorante” tre o quattro volte. Oggi i motori di ricerca hanno migliorato l’analisi semantica del discorso, quindi se scrivo riferendomi ae eccezzionali esperienze enogastronomiche nel mio ristorante, loro abboccheranno comunque (anzi meglio).
Va considerato anche che il 75% delle ricerche viene fatto inserendo da 3 a 5 parole, quindi i titoli dei siti/pagine vanno scritti di conseguenza.
3. Focus on the user experience:
Attualmente Google cambia il proprio algoritmo di ricerca circa 500 volte all’anno con lo scopo di far si che chi utilizza Google come motore di ricerca trovi quello che gli interessa nelle prime pagine (io direi nella PRIMA pagina, N.d.A.).
Il punto non è come faccio a fregare l’algoritmo; il punto è come faccio ad assicurarmi che il mio contenuto sia il miglior contenuto possibile sul web per le parole che mi interessano (che poi è il concetto dell’importanza dell’identità nell’approccio del marketing totale).
Per farlo la chiave è creare contenuti originali. Quindi bisogna darsi un piano editoriale (siamo tutti nel mercato dell’editoria vero Federico? Vero Pier Luca Santoro? Il bello è che i nostri contenuti originali possono partire anche da contenuti esistenti di altri. Curare i contenuti significa anche prendere pezzi di altri (citando SEMPRE le fonti) aggiungendo però la nostra idea / visione: “condivido questo perchè ….”
4. Size matters:
Gli articoli più lunghi sono quelli che in media ottengono i migliori risultati nelle ricerche sul web. Qui confesso che ho goduto, poi l’entusiasmo è un po’ scemato perchè come lunghi si considerano i pezzi tra 1.200 e 1.500 battute, il mio pezzo manualistico su “Come, ma soprattutto PERCHE’, fare il budget aziendale” uscito su Vinix superava le 3.000.
Per rendere più digeribili i pezzi lunghi divideteli in paragrafi, usate elenchi puntati, foto, ecc…
5. Optimize for mobile:
Le ricerche sui motori di ricerca da smartphone e tablet sono in costante crescita, quindi assicuratevi che i vostri contenuti siano ricercabili anche attraverso questi apparecchi. Punto.
6. Use unique images:
Le immagini in Google non sono un riferimento così importante come una volta, però ogni volta che potete usate un’ immagine personalizzata o unica. Nel lungo periodo sarete ripagati dello sforzo.
Ma il consiglio più importante di SEO più importante per il 2016, secondo la’utrice dell’articolo è focalizzarsi sulla propria audience. In passato gli operatori di marketing /aziende provavano a promuovere quello che loro volevano che le persone vedessero (in passato? Magari fosso passato. N.d.A.). Oggi quello che veramente fa schizzare il proprio SEO è dare alle persone quello che effettivamente vogliono vedere.
Ricordiamo che l’azienda non fa i profitti perchè appare prima o seconda nella pagina di ricerca di Google. L’azienda fa i profitti perchè apparendo nei primi risultati di ricerca la nostra audience obiettivo è facilitata a trovarci. Se poi quando arrivano nel sito/pagina/profilo social hanno una delusione è peggio che non se non ci avessero mai trovati.
Una delle mode (tendenza) del marketing strategico negli ultimi 10 anni è quella dell’importanza cruciale per le marche di stabilire un rapporto più stretto e diretto possibile con le proprie audiencies, intendendo con questo termine sia gli attuali consumatori che quello potenziali.
Questo approccio ha dato luogo ad azioni di “marketing di massa individuale” (confezioni di Nutella con il tuo nome, lattine di Coca Cola con i nomi, ecc…), all’utilizzo del BIG DATA per profilare sempre più precisamente e dettagliatamente i propri consumatori obiettivo, sviluppo di presenza delle aziende sui social network in modo da permettere l’interazione diretta tra le persone e la marca, ecc…
Il famoso concetto di creazioni di legami (emotivi) tra le marche e le persone (tema che ho già trattato su questo blog, l’ultima volta la scorsa settimana).
Un’altra tendenza, più tattica, diffusasi negli ultimi anni è quella dell’utilizzo delle vendite telefoniche, sia per i servizi, soprattutto, che per i prodotti.
Ora, credo non ci siano dubbi che uno dei momenti di maggior coinvolgimento tra una marca ed i suoi potenziali consumatori è quando la marca li chiama a casa loro per proporgli i suoi prodotti/servizi (repetita iuvant, una persona consuma sempre un servizio, che sia incorporato o meno in un prodotto fisico).
Logica vorrebbe che per mettere insieme l’approccio strategico e la sua realizzazione tattica, le aziende battessero tutte le Università della Repubblica a contendersi i laureati di psicologia per avere nei propri call-center le persone più qualificate nel difficile ed ingrato lavoro (parlo per esperienza diretta) di stabilire un legame emotivo con un estraneo attraverso una conversazione telefonica.
Sorprendentemente invece le aziende trattano l’attività di vendita telefonica come se fosse una cosa esterna al sistema della marca e quindi lo esternalizzano a società che utilizzano le più trite e becere “tecniche di vendita”. Anche se chi chiama non dice chiaramente che si tratta di una telefonata per vendervi qualcosa, le formule di “rito” sono talmente fruste che lo capiscono tutti (a parte l’accento straniero ed il tono di essere impegnato a fare altro della voce dell’azienda che mi chiama).
Non so se si tratti dell’ennesimo esempio di scollamento tra marketing e vendite, ma la cosa per me è sconcertante: cosa c’è di più diretto della voce dell’azienda che mi parla? Eppure è evidente che nessuno in azienda si cura di capire e valutare se quella voce e quello che dice è coerente/allineato con il dialogo che la marca cerca di costruire con me in tutte le altre occasioni/situazioni (che sono meno dirette e quindi più “deboli”).
L’ (ennesimo) esempio di questo l’ho avuto la mattina dello scorso 8 dicembre (festa nazionale in Italia, ma forse non nel paese in cui risiede la persona che mi ha chiamato), quando mi ha telefonato a casa la Vodafone. Dopo il cortese, ma secco, diniego ho fatto un tweet.
Siccome la Vodefone (ma potete cambiare il nome con l’azienda che preferite) è una grande azienda ben organizzata (?) che fa un puntuale monitoraggio delle conversazioni social per conoscere in tempo reale il sentiment nei confronti del marchio ed essere vicina ai propri clienti, mi ha prontamente risposto.
Ecco la conversazione:
Col ciufolo che vi fornisco ulteriori informazioni mie.
E’ mai possibile che le aziende non abbiano ancora capito che l’esperienza della marca è complessiva e globale?
E se l’hanno capito è mai possibile che siano così burocratizzate da non riuscire e gestire le diverse attività di conseguenza?
E se il problema non è di burocratizzazione ma di prevalenza della visione finanziaria, è mai possibile che questi geni della finanza che negli ultimi anni hanno conquistato il comando della aziende siano capaci di ragionare solo in termini di costo (di breve periodo) e mai di valore (di lungo periodo)? La marginalizzazione del marketing e la crisi economica mondiale (ottobre 2010)
Fino a quando? Fino a quando non mi chiamano per una consulenza sul Marketing Totale.
Oppure fino a quando non arriva Maxino: Ailò. Una risata vi seppellirà.
“Queste regole sono semplicissime, le capirebbe un bambino di quattro anni, Chico, vammi a trovare un bambino di 4 anni, perché io non ci capisco niente!” (Rufus T. Firefly) alias Groucho Marx.
Mia nipote teen ager l’altro giorno mi chiede cosa ne penso della sponsorizzazione di X factor da parte di Wind. Io rispondo che non ne penso niente perchè nè sono cliente wind nè guardo X-Factor.
Mi spiega quindi rapidamente la questione.
Wind è (uno) dei main sponsor di X-Factor ed ha lanciato delle tariffe “music” collegate a questa sponsorizzazione (quindi al programma, quindi al mondo della musica, quindi al target dei teen-ager) che permettono di scaricare ed ascoltare musica tramite l’applicazione di Napster.
Essendo totalmente in target, lei se la scarica, ma poi scopre che negli oltre 30 milioni di brani che ci sono su Napster, non ci sono tutti quelli cantati dai partecipanti ad X-Factor. O meglio, se ho capito bene, su Napster ci sono tutte le cover cantate durante il programma, ma non tutte le versioni originali.
Ergo, dopo aver sentito una canzone cantata da un partecipante di X-Factor ha voluto andare a sentire com’era la versione originale (sarà stata meglio o peggio di come l’hanno cantata ad X-Factor?) e non l’ha trovata perchè non è tra quelle di cui Napster ha i diritti.
Siccome lei non è così naif come la dipingo io, è assolutamente cosciente che è una questione di diritti e quindi la domanda vera che voleva farmi, come professionista di marketing (lo so ho una brutta vita) era “Ti sembra possibile che questi della Wind diano un pacco di soldi di sponsorizzazione ad X-Factor e non riescano neanche a fare in modo che le canzoni utilizzate nel programma rientrino nei 30 milioni di brani (mi rifiuto di usare la parola “traccia”) di cui Napster ha i diritti, per evitare che i loro clienti si sentano ingannati?”.
Forse alla wind non hanno bisogno di un bambino di 4 anni, ma un’adolescente di 17 potrebbe dargli una mano.
Questo aneddoto tocca alcuni punti interessanti del concetto di marketing totale:
1. Apparire coerenti è più facile che essere coerenti: una volta le interazioni tra la marca e le proprire audiencies erano meno frequenti nel tempo e nello spazio. Soprattutto erano in larghissima misura unidirezionali e sotto il controllo della marca.
La marca preparava con cura la realizzazione e l’esecuzione delle proprie campagne di comunicazione, quindi era molto più semplice che queste mantenessero una loro coerenza interna e con le altre strategie di prodotto, distribuzione e prezzo.
Adesso le interazioni tra la marca e le proprie audiencies sono diffuse e continue nel tempo e nello spazio. Di conseguenza la coerenza si può ottenere solamente con la definizione di una chiara identità/personalità della marca e la sua condivisione ed (intima) adozione all’interno dell’organizzazione (nell’organizzazione io comprendo tutte le funzioni aziendali+più i suoi fornitori di prodotti e servizi).
Per dirlo in un altro modo, una volta le marche incontravano i propri consumatori (quasi) esclusivamente dandogli appuntamento, quindi si ppotevano preparare con cura, scegliere il vestito adatto, truccarsi, aggiustarsi i capelli, comportarsi secondo l’immagina che volevano dare, ecc…. Oggi le marche incrociano le proprie audiencies sempre, anche appena sveglie oppure alla fine della giornata quando sono stanche e vorrebbero solo mettersi in pantofole e pigiama. L’unico modo per non far prendere paura ai consumatori è ESSERE se stessi in ogni occasione.
Se la marca mostra qualche lacuna nel suo approccio (rispetto) verso (le aspettative) dei propri consumatori non basta cambiare spot, bisogna intervenire sulla propria essenza (carattere). E questo è molto più difficile.
2. (voler) Creare dei legami emotivi con le proprie audiencies è un arma a doppio taglio. Le marche si sono spostate dall’apparire all’essere un po’ perchè forzate dalla società dell’era digitale ed un po’ perchè si sono convinte che creare legami emotivi con i consumatori sia un fattore di successo.
Io non sono del tutto d’accordo con questa visione (vedi il mio post Lovemarks vs. users: i rischi dell’amore platonico (per le marche)), ma per il momento prendiamo per buona la validità dell’obiettivo delle marche di creare legami emotivi con i propri consumatori.
Detto in parole semplici l’obiettivo è che i miei consumatori mi amino.
Il problema di maneggiare sentimenti forti è che se poi sentono traditi, mi odieranno. E l’unico modo per evitare (ridurre) il rischio che si sentano traditi è che io, marca, a mia volta ami i consumatori.
Non è un impegno da poco e le parole hanno tutto il peso che possiedono nei rapporti tra le persone. In realtà non sarebbe nemmeno troppo difficile se nelle aziende l’approccio di marketing fosse prevalente e la funzione marketing svolgesse il ruolo strategico che le è proprio. Purtroppo però la situazione più diffusa attualmente è quella di un marketing marginale nella definizione e realizzazione delle strategie e di una predominanza dell’approccio finanziario, che tipicamente ama più il denaro che le persone.
Alla fine di questo pistolotto pseudo filosofico qualcuno potrebbe dire che dò troppa importanza alla coerenza.
Vi, e mi, chiedo voi stabilireste una relazione stabile con una persona incoerente? Avreste fiducia in lei? Soprattutto fareste affari con una persona incoerente?
Cambiate “persona” con “marca” e capirete perchè io continuo a considerare la coerenza delle attività della marca come precondizione per il suo successo.
A pensarci bene credo che siano 3 i libri fondamentali per ilmio marketing. Fondamentali nel senso che tutto quello che ho letto/studiato/imparato dopo averli letti (ed anche qualcosa prima) si sono ancorati / appoggiati sulle fondamenta costruite con questi libri.
Sono tre libri che ho studiato nei miei corsi all’Università di Guelph – Ontario, oramai 25/26 anni fa.
- P. Kotler, R.E. Turner, Marketing Management, Prentice -Hall Canada, 1989.
- J.F. Engel, R.D. Blackwell, P.W. Miniard, Consumer behavior, The Dryden Press, 1990.
- D.A. Aaker, G.S. Day, Marketing Research, John Wiley & Sons, 1989.
Si tratta quindi libri ed autori ai quali sono particolarmente affezionato, con cui si è stabilito un rapporto speciale di stima (unidirezionale, ovviamente perchè, a parte Kotler, non li ho mai incontrati). E’ stato un po’ come quando all’università mi sono trovato come professore di Topografia e Costruzioni il Prof. Chiappini, che aveva scritto il libro di testo su cui avevo studiato alle superiori. Mi è sembrata una garanzia di qualità del corso ed anche un po’ di conoscerlo già.
Ecco perchè sono stato contento quando Aaker ha cominciato a pubblicare sulla rivista Marketing News dell’American Marketing Association i suoi articoli tratti/ispirati dal suo ultimo libro Aaker on Branding: 20 Principles to Drive Success.
L’ultimo articolo in ordine di tempo si intitola Three Ways to Build a Competitive, Compelling, Purposeful Brand, che da me tradotto in italiano è il titolo di questo post, e mi è sembrato particolarmente utile ed interessante.
Ecco la mia sintesi (riassunto e commento si diceva alle elementari).
Ci sono 3 tendenze che si stanno velocemente affermando nelle strategie e tattiche di creazione della marche (branding), trasversalmente praticamente in tutti i settori. Il successo futuro delle organizzazioni deriverà dalla loro capacità cavalcare queste onde piuttosto che nuotarci controcorrente.
La prima tendenza è lo spostamento della concorrenza dalle preferenze di marca alle sottocategorie di un settore.
La concorrenza basata su preferenze di marca è caratterizzata da innovazione incrementale, per cui la promessa della marca diventa “la mia marca è meglio della sua”.
La concorrenza basata su sottocategorie è caratterizzata da innovazione sostanziale, per cui la promessa della marca diventa “la mia marca ti offre qualcosa che non ha nessuno”. In questo senso l’offerta della marca può diventare un “must have”. Per non parlare sempre di Apple, un esempio nel settore dell’automobile è stata l’introduzione dei SUV o dei minivan. La marca crea una sottocategoria dove non ci sono (ancora) concorrenti rilevanti.
N.d.A., ossia mia: è un altro modo guardare al famoso concetto di Blue Ocean Strategy. Un modo che ha il vantaggio rispetto all’approccio economico-aziendale del testo di Kim e Mauborgne di fornire un approccio più efficace per perseguire l’identificazione / definizione / creazione degli “oceani blu” ex ante e non solamente a posteriori. E’ un po’ la stessa differenza che c’è secondo me tra Kotler e Porter.
In effetti Aaker prosegue indicando le implicazioni che questa detenza determina nella gestione dell’impresa e delle marche:
- spostare parte degli investimenti dalla ricerca di innovazione incrementale a quella di innovazione sostanziale.
- sviluppare la capacità e gli strumenti per riconoscere quali sono i (potenziali) “must have” e quali no (N.d.A.:ricerca di marketing se ci sei batti un colpo).
- diventare il leader di riferimento della nuova sottocategoria (N.d.A.: rapidamente perchè i plus sono destinati a diventare must per l’entrata nella sottocategoria dei concorrenti).
- la volontà e capacità di gestire sottocategorie piuttosto che marche (N.d.A.: pensando alle mie esperienze con Limoncè e, soprattutto, Keglevich io direi la visione di gestire sottocategorie)
- possedere la sottocategorie creando barriere all’entrata dei concorrenti.
La seconda tendenza è lo spostamento dal comunicare fatti relativi alla marca / offerta /azienda al creare “contenuti sweet-spot per il cliente”, contenuti che interessino e coinvolgano i clienti attuali e potenziali (N.d.t., sempre io: una traduzione decente di sweet-spot non l’ho trovata, quindi l’ho lasciato così).
Un contenuto generato / ispirato da uno sweet-spot del cliente rafforza la percezione della marca e genera molta più fiducia, credibilità ed autenticità rispetto alla miglior pubblicità.
N.d.A.: se volete è il vecchio caro concetto di comunicare i vantaggi che il cliente ottiene dal consumo della marca grazie alle sue caratteristiche e non fermarsi alle semplici caratteristiche, lasciando al cliente l’onere di capirne i (potenziali) vantaggi. Però più approfondito e calato nella realtà attuale dei “contenuti”. Nell’era digitale siamo tutti nell’attività editoriale, anche se facciamo biscotti, è il marketing totale bellezza.
La terza tendenza è quella che le mmarche devono avere / trovare / adottare uno scopo più ampio ed elevato rispetto al semplice battere la concorrenza sul mercato.
Ovviamente perchè questo scopo più ampio ed alto riesca ad avere un impatto all’interno ed all’esterno dell’organizzazione / marca deve essere vissuto in modo genuino e sostanziale.
Direi che per oggi abbiamo abbastanza food-for-thought
Per i lettori di biscomarketing la segnalazione del mio post
uscito ieri su Vinix.
Il 31 agosto del 2014 nel post “Il marketing nel 2024 secondo me (biscomarketing) 3: le politiche di prodotto” segnalavo la tendenza alla “parsimonia” e scrivevo “La competizione che spinge a contenere i costi e l’attenzione alla eco-compatibilità da parte delle persone, premierà le aziende che sapranno operare con parsimonia.”
Sono andato a riguardarmelo l’altro giorno dopo che ho sul giornale ho trovato questa pubblicità della ditta Ravelli incentrata sulla “Zero philosophy”.

Mi è sembrato un segnale ed una conferma interessante di un atendenza che sento tanto forte come nuova ed alquanto disruptiva rispetto al passato.
Anche se ovviamente declinata nei benefit positivi “Zero limiti, infinite possibilità”, “Zero manutenzione, infinito tempo libero”, “Zero rumore, infinito silenzio” (qui i creativi erano un po’ a fine turno), non deve sfuggire la peculiarità della valorizzazione della marca basta su un concetto per cui “meno è più”.
La storia dello sviluppo economico degli ultimi 100 anni, ma potrebbero bastare anche gli ultimi 50, è una storia di conquista dell’abbondanza in cui il “più è più.
il valore dello zero rappresenta una vera e propria inversione culturale: “km 0″, “0 emissioni”, “0 solfiti” (nel vino), “Coca Cola 0″ (nel trend c’entrerà anche Zerocalcare?).
Una tendenza più che una moda, visto che sta proseguendo anche dopo la crisi economica che ha riportato in auge il lusso da un parte ed i concorsi a premio più imeediati e semplici dall’altra.
Mi è già capitato in una cosnulenza di sottolineare la parsimonia e chiedere all’azienda quale assenza era in grado di fornire al mercato.
Mi viene in mente una vecchissima, sciocca battuta: “Siate parchi, come il Parco Nazionale dell’Abruzzo”
L’altra domenica Pier Luca Santoro nel suo gruppo pubblico di facebook “I giornali del futuro il futuro dei giornali” ha inserito il collegamento all’articolo di Luca De Biase “La partita della pubblicità è tecnologica” dove l’autore sostiene la tesi che “l’editoria ha bisogno di ridiventare un business fondamentalmente tecnologico. Innovativamente tecnologico.”, chiedendo al gruppo cosa ne pensava.
Confesso che normalmente non non entro in questo tipo di discussioni su fb, perchè non mi sembra una piattaforma adatta a confrontarsi in modo articolato. Però questa volta, un po’ per la stima nei confronti di Pier Luca, un po’ per l’interessante del tema (le due cose sono collegate), ho commentato andando un po’ oltre al tema dell’articolo e della domanda, chiedendomi (e chiedendo) se la pubblicità continuerà ad esistere strutturalmente, indipendentemente dalle soluzioni di media e/o di tecnologia che si possono inventare.
Non ho approfondito il concetto perchè sono partiti alcuni commenti (semi-ideologici) sull’ineluttabilità della pubblicità, sulla pubblicità buona e quella cattiva (non esiste pubblicità cattiva, esiste solo pubblicità indisposta, come ci ha insegnato la pubblicità della Dolce Euchessina.
L’argomento però continuava a ronzarmi nella testa ed è stato di nuovo Pier Luca a riportarlo in superfice ieri con questa considerazione su adbloking e dintorni: “È una questione di linguaggi, di modo di porgere e di rispetto nei confronti delle persone, in antitesi all’attuale invasività anche della pubblicità online. O, come dicevo, l’advertising cesserà di essere ciò che interrompe gli interessi della gente per diventare il più possibile quel che gli interessa oppure le imprese ricercheranno autonomamente, come già avviene con il brand journalism, nuove forme, nuovi format di comunicazione e di relazione con i propri pubblici di riferimento. Non c’è scelta.“.
Condivido “O l’advertising cesserà di essere ciò che interrompe gli interessi delle persone per diventare quello che gli interessa oppure non sarà.“, quindi sostengo che “non sarà”.
Attenzione, non ne faccio una questione ideologica (da professionista del marketing ci mancherebbe altro) e voglio sottolineare che la comunicazione delle aziende e/o dei marchi è cosa ben diversa dalla pubblicità.
Dico che la pubblicità, intesa come “ogni forma di presentazione e/o promozione non personale di idee, beni o servizi realizzata a pagamento da uno sponsor chiaramente identificabile.” (mia traduzione dal Kotler, Marketing Management) è strutturalmente destinata ad interrompere gli interessi delle persone. Non c’è tecnologia o contenuto che tenga.
Già nel 2008 scrivevo come la pubblicità fosse già il rumore di fondo della nostra vita e quindi fatalmente destinata all’irrilevanza. Credo che ci siamo arrivati molto vicini.
Mi guardo intorno e mi sembra evidente che le persone hanno sviluppato una sorta di “adblocking mentale” per cui nè vedono nè sentono la pubblicità, meno che meno le marche che la realizzano. Le persone non hanno più interesse nel ricevere (questo tipo) di informazioni non richieste perchè si sono abituate che le informazioni le cercano e le trovano autonomamente quando gli servono ed interessano.
Forse in questo scenario l’unica pubblicità che si salva è l’affissione, perchè spesso non interrompe nessun interesse specifico delle persone che la vedono, e la comunicazione di promozione/offerte speciali, meglio se fatte al momento e nel posto giusto sul cellulare tramite la geolocalizzazione.
Nell’ottobre 2012 mi chiedevo quale sarebbe stato il futuro della pubblicità in termini di modalità. Oggi ho l’impressione (convinzione?) che la pubblicità manchi di un futuro tout court.
Sarà per questo che fino dall’inizio della mia carriera in azienda nel 1994 ho sempre considerato le Pubbliche Relazioni e la pubblicità specializzata B2B come le componenti minime ed irrinunciabili del mio budget di comunicazione?
Più di una volta ho dichiarato che volevo evitare che biscomarketing diventasse un blog di marketing del vino (anche se sono i post che storicamente mi hanno portato il traffico maggiore).
Ho mantenuto l’intenzione e quindi ho cominciato a pubblicare i post di argomento enologico sulla piattaforma Vinix.
Non c’è motivo però perchè gli affezionati lettori di biscomarketing ne siano esclusi e quindi ecco qui il link.
No dai, la promozione che regala UNA COPIA cartacea di Oggi oppure UNA COPIA del Corriere della Sera digital edition ancora ad ottobre 2015? Basta dai. #FerrariFormaggi.
Capita abbastanza spesso che su questo blog parli di cosa fa Ferrero, quasi sempre con una punta di invidia, non tanto perchè sono grandi, ma perchè sono svegli e riescono a realizzare cose che io avevo solo immaginato.
Questo è uno di quei casi perchè è partita da un po’ la campagna premio certo con il claim “Bontà è Bellezza”.
E’ una campagna con almeno deu elementi interessanti. Il primo è la spinta promozionale data dalla certezza della vincita, fatta però attraverso premi di valore aggiunto. Quindi non c’è un appiattimento della marca sul prezzo / sconto e si riesce a dare al consumatore qualcosa che per lui vale più di quanto costi all’azienda.
Volendo parlare tecnicamente, la Ferrero crea un surplus di valore che trasferisce al consumatore.
In più collegandosi a degustazioni di specialità alimentari italiane, la promozione si inserisce nel filone ancora molto attivo dell’enogastronomia (leggi foodporn) e permette di trasferire sui prodotti Ferrero promozionati l’alone di qualità dei prodotti tipici italiani.
Potrà sembrare un’idea banale, ma realizzare una promozione di tipo così aperto nella scelta e fruizione del premio richiede un’organizzazione non da poco.
Questa promozione utilizza e realizza in pieno due concetti che ho espresso tempo addietro: il crescente interesse dei consuatori alle promozioni in seguito alla crisi economica (il post del marzo 2013 lo trovate qui) e la necessità che nell’era del marketing totale le strategie siano tattiche e le tattiche strategiche.
Ma quello che mi intriga di più della campagna è il claim che collega direttamente la bonà alla bellezza. Questo perchè nella mia carriera ho tentato varie volte di posizionare esplicitamente una marca / prodotto sulla base della bellezza come proxy della qualità e non ci sono mai riuscito (leggi non me l’hanno mai lasciato fare).
Gli esempi si specano, basta pensare al ri-lancio della Fiat 500, però la domanda rimane: c’è un’etica nell’estetica? il fatto che un prodotto sia bello lo fa anche automaticamente buono, in senso esteso?
Questa enfasi sulla bellezza, non rischia di diventare un posizionamento classista? Vale più il meccanismo per cui acquisto i cioccolatini Ferrero per appropriarmi della loro bellezza (indipendentemente dalla loro bontà) oppure di rifiuto di ridurre tutto all’estetica. Mi ricordo che quando ero a piccolo a Venezia i panifici avevano i biscotti “brutti, ma boni”, che si posizionavano in modo totalmente contrario.
Ma soprattutto la domanda definitiva è Ferrero Rocher, Mon Cheri e Pocket Coffee sono belli o sono brutti? E se sono brutti, automaticamente diventano anche cattivi?
Voi che ne dite?
Oggi pubblico da smartphone, quindi saro’ breve per forza.
Venerdi’ su l’ultimo numero de “L’Internazionale” c’era questa pubblicita’ delle capsule Lavazza (spero che voi la vediate dritta, perche’ io la vedo storta). Realizzata come sempre da Armando Testa.
La cosa che mi ha colpito e’, giustamente, l’immagine centrale che comunica con chiarezza e forza il concetto di italianita’.
Tanto forte che partendo dal pattriottismo puo’ arrivare al militarismo, passando per il nazionalismo.
Per questo mi e’ venuto da chiedermi: questa creativita’ e’ adatta alla audience de “L’Internazionale”?.
Nell’era del marketing totale, vedi i vari post dei mesi scorsi, dove i prodotti di massa personalizzano le etichette per i singoli consumatori e’ corretto NON porsi la questione di realizzare una creativita’ adeguata per ogni mezzo utilizzato. Fatta salva ovviamente l’identita’ della marca?
Paranoie da fanatici del marketing?