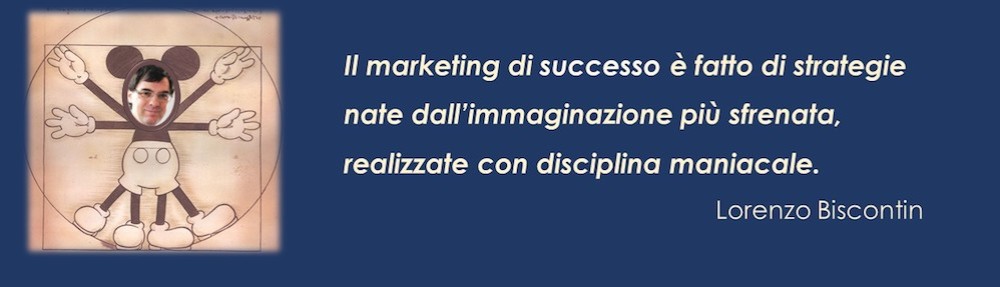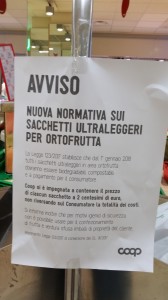Giovedì scorso ho scritto in anticipo il post per questa settimana. Si intitola(va) “Gli shopping bots stanno rivoluzionando i processi e l’esperienza d’acquisto e dimostrano l’importanza del concetto di Marketing Totale e delle sue implicazioni.”
E’ un bel post ed era già pianificato per la pubblicazione automatica questa domenica alle 19:21.
Poi sabato mattina sono andato a fare la spesa.
Ed all’ingresso del (piccolo) supermercato Coop che frequento mi sono trovato davanti questo espositore natalizio del caffè Illy in offerta.

Mi sono venuti in mente anche Benetton e Melegatti e quindi non sono riuscito a sfuggire al mio destino che mi vede dedicare, oramai da 10 anni, parte della domenica pomeriggio a scrivere il post di biscomarketing.
Comincio completando l’affermazione del titolo: le aziende vanno in crisi perché smettono di rispettare la propria identità, la propria cultura, i propri valori, in pratica quello grazie al quale hanno creato i vantaggi competitivi che le hanno portate al successo.
Questo è il principale fattore interno che determina i problemi di un’azienda / marca ed è anche il fattore che indebolisce la capacità dell’azienda / marca di anticipare/reagire con successo ai fattori di crisi esterni quali cambiamenti tecnologici e/o nel comportamento delle persone (consumatori), ecc…
Una marca capace di rimanere fedele al proprio spirito, senza per questo essere immobile, ha buone probabilità di convertirsi in una “Supermarca” che trascenderà le tendenze del proprio settore merceologico (per l’approfondimento del concetto di Supermarca potete leggere questo mio post del febbraio 2016).
Per me non è una novità. Sono sempre stato convinto dell’importanza cruciale della definizione chiara ed onesta del posizionamento delle marche come pilastro e come guida di ogni strategia di successo.
Si tratta di una cosa a cui ho sempre dato massima importanza nel mio lavoro in azienda ed è l’aspetto principale in cui opero nella mia attività di consulente.
Eppure le aziende continuano a sottovalutarlo, forse perché sembra una cosa talmente semplice da non meritare importanza. Certo che è semplice, ma (proprio per questo) difficile.
Le dichiarazioni di Luciano Benetton nella recente intervista rilasciata a Repubblica sulla crisi della sua azienda e sulle strategie di rilancio sono illuminanti:
«Mentre gli altri ci imitavano, la United Colors spegneva i suoi colori. Ci siamo sconfitti da soli(N.d.A.: il grassetto è mio). I negozi, che erano pozzi di luce, sono diventati bui e tristi come quelli della Polonia comunista. E parlo di Milano, Roma, Parigi… Abbiamo chiuso in Sudamerica e negli Usa»
«hanno (N.d.A.: riferito ai manager che gestivano l’azienda dopo la sua uscita dai ruoli operativi) smesso di fabbricare i maglioni. È come se avessero tolto l’acqua a un acquedotto. Ho visto cappotti alla russa, con il doppiopetto, il bavero largo, le spalle grosse… di colore grigio sporco. Pensi che hanno chiuso le tin-to-rie!».
Con il senno di poi sembra evidente l’assurdità per un’azienda che si chiama “United Colors” di chiudere le tintorie, però dei dirigenti (che si presume) qualificati ed esperti l’hanno fatto.
E’ giusto ricordare che i problemi di Benetton non nascono dal fatto che il concetto di instant-fashion di cui sono stati gli inventori / pionieri sia entrato in crisi. Tutt’altro: si tratta dell’approccio tutt’ora vincente nella produzione e distribuzione di abbigliamento.
Solo che mentre Zara ed H&M, per fare due nomi, si ispiravano al successo di Benetton, trovando soluzioni di maggior successo, Benetton smetteva di farsi ispirare da se stesso (o di essere fonte di ispirazione, se preferite).
Credo che sia evidente l’enorme vantaggio competitivo in termini di competenze, dimensioni, curve di esperienza, capillare presenza sul mercato, (potenziale) capacità di ascoltare i consumatori, esperienza, ecc… che Benetton aveva sui concorrenti che oggi lo hanno superato quando questi concorrenti sono partiti.
Patrimonio completamente dilapidato nel giro di 10 anni (se la “nuova” strategia di rilancio sia effettivamente nuova oppure una minestra riscaldata è un tema in cui qui oggi non entro).
Attenzione che non è sufficiente il mantenimento della gestione famigliare per assicurare la coerenza tra visione e gestione. Il figlio di Luciano Benetton è stato presidente dell’azienda dal 2012 al 2014. E’ necessario formalizzare l’identità attraverso un lavoro di (psico)analisi dell’azienda / marca, per poterla poi trasferire nel tempo e nello spazio
Forse ancora maggiore era il vantaggio competitivo di Melegatti indipendentemente dal brevetto del pandoro nel 1894 chiunque ha almeno 45 anni sa che fino agli anni ’80 il pandoro era solo Melegatti. E non si trattava di uno slogan, era un dato di fatto. Ve lo dice un vecchio bambino degli anni ’70 che, minoritariamente ai tempi, non mangiava il panettone.
Le cose sono cominciate a cambiare a partire dagli anni ’80 (grazie?) all’arrivo di Bauli sul mercato nazionale (sull’invenzione del pandoro Ruggero Bauli diceva “Chi l’ha inventado non se sa, ma el pandoro Bauli lo gò inventado mi”), seguito poi da Paluani.
Quindi anche qui ci troviamo in un settore in crescita, in cui il pioniere si è perso in strategie che rincorrevano il mercato invece di lavorare sulla propria proposta per aggiornarla ed affermarla. Qui trovate il mio post di 2 anni fa (tempi non sospetti) “E se il problema principale di Melegatti fosse la qualità del prodotto e non comunicazione e posizionamento?”
E arriviamo, brevemente, ad Illy. A partire dagli anni ’90 e per almeno vent’anni Illy è stato il riferimento nel settore del caffè per tutti: consumatori, baristi, produttori concorrenti.
Ha costruito il proprio successo diffondendo la cultura del caffè basandosi sull’eccellenza in ogni aspetto. Massima qualità intrinseca del prodotto, conoscenza assoluta e trasferimento delle conoscenze per utilizzarlo al meglio (ossia su come fare il caffè, vedi “Università dell’Espresso”) e stile che (s)confina con l’arte.
La qualità intrinseca è stata messa in discussione con le capsule (area di affari in cui tra l’altro ha tradito/abbandonato i principi con cui aveva dato vita al progetto delle cialde E.S.E.) ed in quanto a stile, la foto all’inizio di questo post parla da sola.
La pressione del mercato, una certa uggia che subentra al fare sempre le stesse cose, la voglia di novità portata dalle nuove persone che entrano in azienda, sia per un naturale modo diverso di vedere le cose sia per provare a se stessi ed agli altri di cosa si è capaci. Sono tutti fattori che tendono a minare la coerenza intrinseca della gestione e, soprattutto, la coerenza con l’identità / spirito / personalità della marca.
Ma sono tutte scorciatoie faticose ed in cui è facile perdersi.
Siate onesti con voi stessi, così la vostra proposta sarà autentica ed i consumatori vi troveranno. Siate confusi o, peggio, falsi ed i consumatori scapperanno per quanto li cerchiate e li blandiate.
Onestà, autenticità, coerenza non significano fissità ed immobilismo.
Come sa chiunque sia stato al timone di una barca a vela con il brutto tempo (ad esempio navigando di bolina per tornare da Melilla, enclave spagnola sulla costa mediterranea del Marocco, a Motril, porto vicino a Granada, con mare forza 5) per mantenere la rotta bisogna continuamente aggiustare il timone e regolare le vele.
Si impara più rapidamente in barca, dove l’effetto degli errori ed i relativi rischi si vedono subito, che non in azienda. Però, se non si impara, si naufraga uguale (oppure si chiama un consulente, che sia bravo mi raccomando).