Interessantissimo articolo del New York Time Magazine pubblicato sull’Internazionale. Lo pubblico a puntate perchè (purtoppo) è veramente troppo lungo per il web; limiti del digitale (come quelli che mi dicono “L’i-pad è troppo comodo per leggere il giornale la mattina”, però con l’i-pad non leggi il giornale, lo guardi e non è la stessa cosa).
Forse sto facendo una violazione del copyright, ma se Zuckerberg dice (probabilmente a ragione) che la privacy è un concetto superato, spero che citare la fonte basti a farmi perdonare.
Poi finite le puntate probabilmente farò un post sulle riflessioni stimolate da questo articolo, nel frattempo se volete mandare le vostre ….. Mettetivi comodi e cominciate
La forza delle abitudini
Charles Duhigg, The New York Times Magazine,Stati Uniti.
Condizionano la nostra vita ogni giorno, da quando ci laviamo i denti a quando guidiamo la macchina. Da vent’anni gli scienziati cercano di capire come nascono le abitudini. Ora le loro ricerche hanno un nuovo campo di applicazione: il marketing.
Nel 2002 Andrew Pole era appena entrato a lavorare come esperto di statistica alla catena di grandi magazzini Target, quando due colleghi del reparto marketing si fermarono accanto alla sua scrivania per fargli una strana domanda: “Siamo in grado di scoprire se una cliente è incinta, anche se lei non vuole farcelo sapere?”. Pole ha un master in statistica e uno in economia e si è occupato per tutta la vita dell’incrocio tra i dati e il comportamento umano. I suoi genitori insegnavano nel North Dakota, e mentre gli altri ragazzi andavano in campeggio, Pole studiava algebra e scriveva programmi per computer. “Lo stereotipo del nerd della matematica non è un mito”, mi ha detto quando ho parlato con lui l’anno scorso. “Mi piace andare in giro a diffondere il vangelo dell’analisi”. Come gli spiegarono gli esperti di marketing – e come lui stesso ha spiegato a me prima che la Target gli proibisse di parlarmi – le persone che hanno appena avuto un figlio sono una miniera d’oro. La maggior parte della gente non compra in un unico posto tutto quello che le serve. Fa la spesa nei negozi di alimentari, compra i giocattoli nei negozi di giocattoli e va alla Target solo quando ha bisogno di certe cose che
associa ai grandi magazzini, come i detersivi, i calzini o la carta igienica. Ma la Target vende di tutto, dal latte agli orsacchiotti di peluche, dai mobili da giardino all’elettronica, perciò uno dei suoi obiettivi principali è convincere i clienti che l’unico negozio di cui hanno bisogno è il suo. Ma questo è un messaggio difficile da trasmettere, anche con le campagne pubblicitarie più ingegnose, perché non è facile far cambiare abitudini alla gente. Tuttavia, ci sono alcuni periodi della vita in cui una persona è costretta a modificare la sua routine e le abitudini d’acquisto sono più fluide. Uno di questi momenti, anzi il principale, è quando nasce un bambino, perché i genitori sono esausti e soprafatti dal nuovo impegno e più disposti a cambiare abitudini d’acquisto. Ma come spiegarono a Pole i colleghi del marketing, il tempismo è fondamentale. Dato che i registri delle nascite sono pubblici, quando una coppia ha un figlio viene immediatamente tempestata di offerte e pubblicità da aziende di ogni tipo. Perciò è decisivo riuscire a conquistare quella famiglia prima che chiunque altro scopra che è in arrivo un bambino. In particolare, i colleghi di Pole volevano mandare pubblicità mirate alle donne che avevano superato i primi tre mesi di gravidanza, perché quello è il periodo in cui la maggior parte delle mamme in attesa comincia a comprare cose come le vitamine e l’abbigliamento premaman. “Sapevamo che se fossimo riusciti a conquistare le future mamme in quel periodo, sarebbero rimaste nostre clienti per anni”, mi ha spiegato Pole. “Se cominciano a comprare i pannolini da noi, poi comprano anche tutto il resto”. Naturalmente, questo desiderio di
raccogliere informazioni sui clienti non è una novità né per la Target né per le altre catene di distribuzione. Sono decenni che la Target accumula dati sulle persone che entrano regolarmente nei suoi negozi. Quando è possibile, assegna a ognuna di loro un codice, che chiama numero di identificazione del cliente, grazie al quale controlla tutto quello che compra. “Se qualcuno usa la carta di credito o un buono sconto, risponde a un questionario, chiede un rimborso, chiama il nostro servizio clienti, apre l’email che gli abbiamo mandato o visita il nostro sito, noi registriamo l’operazione e la colleghiamo al codice”, spiega Pole. “Vogliamo più informazioni possibile”. Collegate al numero di identificazione del cliente sono anche tutte le informazioni di tipo demografico: l’età, se una persona è sposata, se ha figli, in quale zona della città vive, quanto tempo ci mette a raggiungere il negozio, approssimativamente quanto guadagna, se ha cambiato casa di recente, che carte di credito ha e quali siti visita. La Target può comprare anche i dati sull’origine etnica, sui lavori che una persona ha fatto, su quali riviste legge, se ha mai dichiarato fallimento o ha divorziato, in che anno ha comprato (o perso) la casa, se è andata all’università, di cosa parla online, se preferisce una certa marca di caffè, di tovaglioli di carta, di cereali o di succo di mela, qual è il suo orientamento politico e il suo genere letterario preferito, se fa donazioni e quante auto possiede. Tutte queste informazioni però sono inutili se non c’è qualcuno che le analizza e gli dà un senso. Era proprio questo il compito di Andrew Pole e dei suoi colleghi dell’ufficio Guest marketing analytics Quasi tutti i grandi rivenditori, dalle catene di prodotti alimentari alle banche di investimento, hanno un reparto “analisi predittive” che si occupa di scoprire non solo le abitudini d’acquisto dei consumatori, ma anche le abitudini personali, per poter arrivare a loro più facilmente. “La Target è sempre stata una delle migliori in questo campo”, dice Eric Siegel, un consulente che presiede una conferenza del settore chiamata Predictive analytics world. “Siamo nell’epoca d’oro della ricerca sui comportamenti. È incredibile quante cose possiamo sapere oggi su cosa pensano le persone”. Il motivo per cui la Target può ficcare il naso nelle nostre abitudini d’acquisto è che, negli ultimi vent’anni, la scienza della formazione delle abitudini è diventata uno dei maggiori campi di ricerca degli istituti di neurologia e di psicologia di centinaia di centri medici e di università, per non parlare dei ricchi laboratori delle aziende. “Accaparrarsi gli statistici più in gamba ormai è una specie di corsa agli armamenti”, dice Andreas Weigend, l’ex capo scienziato di Amazon. “I matematici sono improvvisamente diventati molto ricercati”. L’analisi dei dati è sempre più sofisticata, e il desiderio di capire come le abitudini quotidiane influiscono sulle nostre decisioni è uno dei temi più appassionanti della ricerca, anche se la maggior parte di noi non si rende conto di essere schiava di certi schemi. Secondo uno studio condotto dalla Duke university, sono le abitudini più che le decisioni coscienti a condizionare il 45 per cento delle scelte che facciamo ogni giorno. Le ultime scoperte stanno cambiando completamente il modo di vedere molte cose, da come concepiamo una dieta a come
i medici stabiliscono le cure per l’ansia, la depressione e le dipendenze. I ricercatori hanno scoperto come impedire a qualcuno di mangiare troppo o di rosicchiarsi le unghie. Sono in grado di spiegare perché alcuni di noi ogni mattina vanno a correre e sono più efficienti nel loro lavoro, mentre altri non riescono ad alzarsi dal letto e perdono tempo. A quanto sembra, esiste una formula per controllare i nostri desideri inconsci. Il processo grazie al quale il cervello trasforma una sequenza di azioni in una routine automatica è chiamato chunking. Ogni giorno ripetiamo decine, se non centinaia, di comportamenti di questo tipo. Alcuni sono semplici, per esempio mettere il dentifricio sullo spazzolino prima di spazzolare i denti. Altri, come preparare il pranzo per i figli, sono un po’ più complicati. Altri ancora sono così complessi che il fatto che siano diventati abitudini ci sembra incredibile. Prendiamo, per esempio, uscire dal garage di casa a marcia indietro. Quando abbiamo imparato a guidare, questa manovra richiedeva, giustamente, una buona dose di concentrazione, perché bisogna guardare nello specchietto retrovisore e in quelli laterali per vedere se ci sono ostacoli, spingere con un piede il pedale della frizione, ingranare la retromarcia, togliere il piede dalla frizione, calcolare la distanza tra il garage e la strada, mantenere dritte le ruote, calcolare come le immagini che vediamo negli specchietti si traducono in distanze reali, e regolare la pressione sull’acceleratore e sul freno. Ora facciamo tutte queste cose ogni volta che usciamo, senza pensarci troppo. Il nostro cervello ha trasformato in routine una buona parte di questi gesti. Se lo lasciamo fare, il cervello cerca di trasformare tutti i comportamenti ripetuti in abitudini, perché così si sforza di meno. Ma questa tendenza a conservare l’energia mentale può essere pericolosa, perché se il nostro cervello va in automatico nel momento sbagliato, potremmo non accorgerci di qualcosa di importante, come un bambino che attraversa la strada in bici o una macchina che arriva a tutta velocità. Perciò abbiamo inventato un sistema per decidere quando possiamo agire automaticamente. È qualcosa che scatta all’inizio e alla fine di un segmento di comportamento, e ci aiuta a capire perché, anche con le migliori intenzioni, è così difficile cambiare un’abitudine.
Cambiare si può
Il processo di formazione delle abitudini è formato da tre fasi. Prima di tutto c’è uno stimolo che dice al nostro cervello che può andare in automatico e quale sequenza deve usare. Poi c’è la routine, che può essere fisica, mentale o emotiva. Infine c’è la gratificazione, che aiuta il cervello a capire se vale la pena di ricordare quella sequenza in futuro. Nel corso del tempo, questo ciclo – stimolo, routine, gratificazione, stimolo, routine, gratificazione – diventa sempre più automatico. Livello neurologico, lo stimolo e la gratificazione si legano strettamente tra loro fino a quando non si instaura il desiderio. L’aspetto particolare di questo meccanismo è che gli stimoli e le gratificazioni possono essere molto sottili. Alcuni studi neurologici hanno dimostrato che certi stimoli durano solo qualche millesimo di secondo. E le gratificazioni possono andare dalle più ovvie (come l’innalzamento del livello glicemico provocato dalla ciambella che mangiamo al mattino) alle più insignificanti (come il senso di sollievo impercettibile, ma misurabile, che proviamo quando usciamo dal garage). Nella maggior parte dei casi tutto succede così rapidamente che non ce ne rendiamo conto. Ma il nostro sistema neurale se ne accorge e usa queste sequenze per costruire comportamenti automatici. Le abitudini non sono immutabili. Possono essere ignorate, modificate o sostituite. Ma quando abbiamo issato una sequenza e acquisito un’abitudine, il cervello smette di intervenire nelle decisioni. Perciò, a meno che non decidiamo di combattere quell’abitudine, cioè di trovare una nuova sequenza, la vecchia si ripeterà automaticamente. “Abbiamo condotto alcuni esperimenti con i ratti, addestrandoli a percorrere un labirinto fino a quando per loro non è diventata un’abitudine. Poi abbiamo modificato l’abitudine spostando la ricompensa finale”, racconta Ann Graybel, una neuro scienziata del Massachusetts institute of technology. “Un giorno abbiamo rimesso il premio dov’era prima e la vecchia abitudine, incredibilmente, è riemersa. Le abitudini non scompaiono mai del tutto”. Fortunatamente, capire come funzionano le abitudini le rende più facili da controllare. Prendiamo per esempio una serie di studi condotti qualche anno fa alla Columbia university e all’università di Alberta. I ricercatori volevano capire come si instaura l’abitudine di fare esercizio fisico. Il programma prevedeva che 256 persone con un’assicurazione sulla salute frequentassero un corso in cui si dava molta importanza all’esercizio fisico. Metà dei partecipanti assisteva a una lezione in più su come si formano le abitudini e in seguito doveva individuare gli stimoli e le gratificazioni che avrebbe potuto usare per prendere abitudini più sane. Il risultato fu sorprendente. Nel corso dei quattro mesi successivi, le persone che avevano imparato a individuare la sequenza facevano il doppio dell’attività fisica di quelle che non avevano imparato a farlo. Altri studi hanno prodotto risultati simili. Secondo un recente studio, se vogliamo cominciare a correre tutte le mattine, è essenziale scegliere uno stimolo semplice (come mettere sempre le scarpe da ginnastica prima di colazione o preparare la tuta vicino al letto) e una gratificazione chiara (come un dolcetto a mezzogiorno o la soddisfazione che dà registrare i chilometri percorsi in un diario). Dopo un po’ di tempo il cervello comincia ad aspettarsi la gratificazione – a desiderare il dolce o quel senso di soddisfazione – e produrrà un impulso neurologico a infilarci le scarpe da ginnastica ogni mattina. Il nostro rapporto con la posta elettronica funziona nello stesso modo. Quando il computer o il cellulare segnalano che c’è un nuovo messaggio, il cervello comincia ad anticipare il “piacere” che (anche se non lo riconosce) gli provoca cliccarci sopra e leggerlo. Se non viene soddisfatta, questa aspettativa può crescere fino a farci impazzire all’idea che c’è un messaggio non letto, anche se a livello razionale sappiamo che probabilmente non è niente di importante. Se rimuoviamo lo stimolo togliendo la vibrazione al telefono o il volume al computer, il desiderio non si scatena, e riusciamo a lavorare tranquillamente senza controllare di continuo la posta in arrivo.
Piccoli riti
In questo campo, alcuni degli esperimenti più ambiziosi sono stati condotti dalle aziende private. Per capire perché i manager sono così affascinati da questa scienza, pensate che una delle più grandi aziende del mondo, la Procter & Gamble, ha usato la teoria delle abitudini per trasformare un flop in uno dei suoi prodotti più venduti. Questo colosso produce una gamma vastissima di articoli, dagli ammorbidenti per il bucato agli asciugamani di carta, dalle batterie a decine di prodotti per la casa. A metà degli anni novanta i manager della Procter & Gamble avviarono un progetto segreto per la creazione di un nuovo prodotto in grado di eliminare i cattivi odori. L’azienda spese milioni di dollari per creare un liquido incolore e poco costoso che si poteva spruzzare su una camicetta impregnata di fumo, su un divano puzzolente, su una vecchia giacca o sulla tappezzeria macchiata di un’automobile e far sparire ogni odore. Per lanciare sul mercato il prodotto, che si chiamava Febreze, la società creò una squadra formata da un ex matematico di Wall street di nome Drake Stimson e da alcuni studiosi della teoria delle abitudini. Il loro compito era garantire che gli spot televisivi, trasmessi in via sperimentale a Phoenix, Salt Lake City e Boise, nell’Idaho, sottolineassero nel modo giusto gli stimoli e le gratificazioni del prodotto. Nel primo spot c’era una donna che si lamentava della zona fumatori di un ristorante. Ogni volta che mangiava lì, diceva, la sua giacca si impregnava di fumo. Un’amica le faceva notare che con Febreze avrebbe potuto eliminare quell’odore. Lo stimolo era chiaro: l’odore acre del fumo di sigaretta. E anche la gratificazione: la scomparsa di quell’odore dai vestiti. Nel secondo spot c’era una donna preoccupata per il fatto che la sua cagnetta Sophie saliva sempre sul divano. “Sophie avrà sempre il suo odore”, diceva, ma con Febreze, “non ce l’hanno più i miei mobili”. Gli spot furono mandati in onda a rotazione e i pubblicitari cominciarono a pregustare i loro premi. Passò una settimana. Un mese. Due mesi. Le vendite erano sempre più basse. Febreze era un lop. In preda al panico, la squadra di esperti condusse una serie di interviste approfondite tra i consumatori per capire cosa non andava. Il primo sospetto lo ebbero quando andarono a intervistare una donna alla periferia di Phoenix. La sua casa era pulita e ben organizzata. Lei stessa si definiva una maniaca della pulizia. Ma quando i ricercatori della Procter & Gamble entrarono nel salotto, dove i suoi nove gatti passavano la maggior parte del tempo, l’odore era così forte che uno di loro ebbe un conato di vomito. Stimson ricorda che un suo collega chiese alla donna: “Cosa fa per l’odore dei gatti?”. “Di solito non è un problema”, disse lei. “Non lo sente?”. “No”, rispose la donna. “Non è meraviglioso? Non puzzano affatto!”. La stessa scena si ripeté in decine di altre case. Il motivo per cui Febreze non vendeva era che la gente non sentiva i cattivi odori. Se vivi con nove gatti, non ti accorgi più che puzzano. Se fumi, dopo un po’ non senti più l’odore di fumo. Quando l’esposizione è costante, non sentiamo più neanche gli odori più forti. Lo stimolo che avrebbe dovuto far scattare il bisogno di usare Febreze tutti i giorni non veniva recepito. E la gratiicazione, una casa senza odori, non aveva senso per chi non li sentiva. La Procter & Gamble chiese a un professore della Harvard business school di analizzare la campagna di marketing del prodotto. I ricercatori raccolsero ore e ore di filmati di persone che pulivano la casa per cercare qualche indizio che potesse aiutarli a collegare Febreze alle abitudini quotidiane delle persone. Non scoprirono nulla e decisero di fare altre interviste. La svolta avvenne quando andarono a trovare una donna sulla quarantina con quattro figli che viveva alla periferia di Scottsdale, in Arizona. La casa era pulita, anche se non perfettamente ordinata, e non sembrava avere alcun odore, non c’erano animali né fumatori. Con grande sorpresa di tutti, lei adorava Febreze.
“Lo uso tutti i giorni”, disse. “Quali odori cerca di eliminare?”, le chiese un ricercatore. “Non devo eliminare nessun odore specifico”, disse la donna. “Lo uso durante le pulizie, un paio di spruzzi quando ho finito una stanza”. I ricercatori la seguirono mentre riordinava la casa. In camera da letto, rifaceva il letto, tirava bene le lenzuola e poi spruzzava Febreze sulla trapunta. In soggiorno, passava l’aspirapolvere, raccoglieva le scarpe dei bambini, rimetteva a posto il tavolino e poi
spruzzava Febreze sul tappeto appena pulito.
“È piacevole, no?”, disse. “È un piccolo rito per concludere la pulizia di una stanza”. A quel ritmo, calcolarono i ricercatori, avrebbe finito un flacone in due settimane. Quando tornarono nel loro ufficio, gli esperti riguardarono i filmati. Ora sapevano cosa cercare e videro gli errori scena dopo scena. Chi pulisce ha già delle abitudini.
In uno dei video, una donna entrava in una stanza sporca (stimolo), cominciava a spazzare e a raccogliere giocattoli (routine), poi riguardava la stanza e sorrideva (gratificazione).
In un altro, una donna guardava il letto disfatto (stimolo), aggiustava le lenzuola e le coperte (routine) e poi sospirava mentre passava la mano sui cuscini appena sbattuti (gratificazione). Con Febreze la Procter & Gamble aveva cercato di creare una nuova abitudine, ma la mossa vincente era sfruttare quelle già esistenti. Doveva presentare il prodotto come il momento conclusivo del rituale delle pulizie, come una gratificazione piuttosto che come una nuova routine.
L’azienda preparò nuovi cartelloni pubblicitari in cui si vedevano finestre aperte dalle quali entrava aria fresca. Venne aggiunto più profumo a Febreze, così invece di eliminare gli odori lo spray ne aveva uno tutto suo. Nei nuovi spot televisivi le donne, dopo aver finito di pulire, lo spruzzavano sui letti appena fatti e sulla biancheria fresca di bucato. Le pubblicità si basavano su abitudini già esistenti: quando vedi una stanza appena pulita (stimolo), tira fuori Febreze (routine) e goditi il profumo che ti conferma di aver fatto un buon lavoro (gratificazione).
Quando inisci di rifare il letto (stimolo), spruzza Febreze e tira un sospiro di soddisfazione (gratificazione). Febreze, lasciavano intendere gli annunci, era un piacere in più, non un modo per ricordarti che la tua casa puzza.
E così un prodotto che in origine era stato concepito come un sistema rivoluzionario per eliminare gli odori diventò un deodorante per la casa che si usava dopo aver pulito. Tutto questo successe nell’estate del 1998. Nel giro di due mesi, le vendite raddoppiarono. Un anno dopo, Febreze fece incassare all’azienda 230 milioni di dollari. Da allora è nata tutta una serie di prodotti collaterali – deodoranti, candele e detersivi per il bucato – le cui vendite hanno raggiunto un miliardo di dollari l’anno. In seguito la Procter & Gamble ha cominciato a dire ai suoi clienti che, oltre ad avere un buon profumo, Febreze eliminava anche i cattivi odori. Oggi è uno dei prodotti più venduti nel mondo.
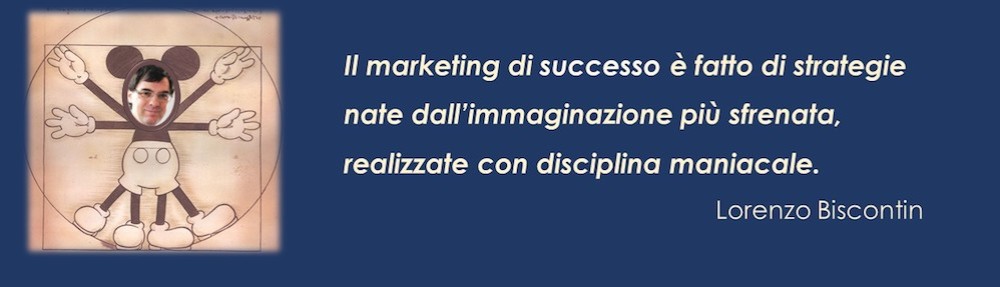
 Qualche tempo fa avevo visto sulla stampa specializzata la notizia del lancio da parte di Barilla della nuova linea Alixir e la cosa mi aveva incuriosito. Quando poi un paio di settimana fa ho visto la pubblicità in televisione, la mia curiosità è cresciuta ancora di più ed ho quandi pensato di condividere nel mio (rinato blog) i miei pensieri.
Qualche tempo fa avevo visto sulla stampa specializzata la notizia del lancio da parte di Barilla della nuova linea Alixir e la cosa mi aveva incuriosito. Quando poi un paio di settimana fa ho visto la pubblicità in televisione, la mia curiosità è cresciuta ancora di più ed ho quandi pensato di condividere nel mio (rinato blog) i miei pensieri.