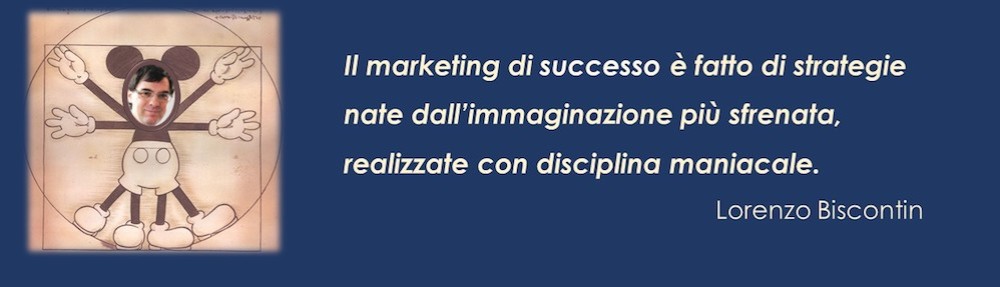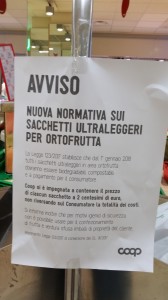Io la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) la frequento, ovviamente, da cliente/consumatore e l’ho frequentata da fornitore. Ho avuto colleghi e collaboratori che avevano lavorato come buyers per catene di livello nazionale, ma personalmente non sono mai stato “dall’altra parte della scrivania”.
Da esperto di marketing mi è sempre sembrato che le strategie della GDO del largo consumo (super ed iper mercati per capirsi), fossero sempre piuttosto nel targettizare, differenziare e qualificare la proposta rispetto alle insegne concorrenti.
Quando assistevo o conducevo trattative come fornitore rimanevo sempre un po’ stupito dalla comune impostazione tipo suk (senza però la gentilezza dei mercanti arabi) perché mi è sempre sembrata una logica che IMPEDISCE di lavorare per migliorare il business, tanto del fornitore come dell’insegna cliente.
Ovviamente secondo il mio connaturato approccio di marketing il miglioramento del business si ottiene attraverso la creazione di valore per le persone (consumatori).
Non è caso che il periodo in cui rapportarsi con la GDO mi è sembrato più proficuo, e sicuramente più divertente, è stato quando negli uffici acquisti delle catene ai category manager è stato dato maggior peso rispetto ai buyers nelle trattative con i fornitori.
Si è trattato però di un periodo di breve durata, 2 o 3 anni al massimo, dopodichè si è tornati a discutere solo di listini, sconti promozionali, premi di fine anno, listing e tutti i vari giochi delle tre carte ancora in uso nelle trattative di vendita.
Immagino che sia stato perché l’approccio di trattativa più o meno dura risultava più redditizio in termini di conto economico.
Di quegli anni mi ricordo una frase dettami da un buyer “Biscontin, io ho il dovere professionale di spremerla il più possibile perché in questo modo raggiungo due obiettivi: ottengo le migliori condizioni di acquisto possibili per me e riduco la sua capacità di dare le stesse condizioni (se non migliori) ai miei concorrenti.”
Non faceva una piega, come non la faceva il mio dovere professionale di trattare tutti i clienti allo stesso modo (che significa anche offrire condizioni migliori sulla base dei volumi di acquisto) non solo per una questione etica, ma anche per il concreto rischio che il cliente che scopre di essere stato trattato peggio decida di cambiare fornitore.
Poi l’altro giorno ho avuto un’illuminazione quando ho sentito per caso un vecchio amico che ha lavorato molti anni per insegne della GDO, enunciare un principio fondamentale della gestione delle insegne distributive:
“Con gli acquisti fai il margine, con le vendite fai il fatturato”
Immediatamente ho pensato “Dov’è il valore per clienti del supermercato in questa equazione?”.
E’ un mese che ci penso, ma non lo trovo.
Se parlassimo di un’azienda manifatturiera sarebbe come operare secondo il concetto di produzione. Traduco dalla mia edizione (canadese) di Marketing Management di Kotler:
“Il concetto di produzione sostiene che i consumatori favoriranno quei prodotti che sono ampiamente disponibili e di basso costo. I managers delle aziende orientate alla produzione si concentrano nel raggiungere alta efficienza produttiva ed ampia copertura distributiva.”
Da notare che nello sviluppo dei concetti di orientamento dell’impresa al mercato, quello di produzione è quello “primordiale”, a cui sono seguiti poi quello di prodotto, quello di vendita e quello di marketing, man mano che il concetto precedente entrava in crisi. Ossia non era più in grado di creare vantaggi competitivi per l’azienda .
Attenzione non significa che il concetto di successivo sostituisca il precedente (ad esempio quello di prodotto sostituisca quello di produzione), ma che il successivo si AGGIUNGE al precedente. Per cui in seguito all’attività delle aziende concorrenti le strategie legate al concetto di produzione da PLUS diventano un MUST (o conditio sine qua non, se preferite continuare con il latino), mentre quelle legate al concetto di prodotto sono il nuovo PLUS. E così via.
Visto con gli occhi degli economisti aziendali, il concetto di produzione del Kotler, somiglia al concetto di leadership dei costi sviluppato da Michael Porter.
Il punto però è che per un’insegna della GDO la leadership dei costi non si ottiene tanto con le trattative di acquisto dei prodotti in vendita, visto che i fornitori cercheranno di mantenere condizioni equivalenti per i vari clienti, quanto piuttosto lavorando sui costi della struttura e del funzionamento dell’organizzazione.
Che è esattamente quello che permette alle catene di discount di marginare bene, pur vendendo a prezzi più bassi rispetto a super ed ipermercati (non ho visto dati recenti, ma qualche anno fa la reddività per metro quadrato dei punti vendita Eurospin era seconda solo a quella di Esselunga).
D’altra parte operare con il concetto “gli acquisti fanno il margine, le vendite fanno il fatturato” implica non targettizzare e non innovare in termini di assortimenti, layout, arredi, promozioni, ecc…
Non voglio dilungarmi in considerazioni operative su un settore che conosco di riflesso e quindi lascio a voi le considerazioni implicite nel concetto, magari partendo da questo esempio: le catene della GDO disponevano dei dati relativi ai comportamenti d’acquisto dei titolari delle loro carte fedeltà molto prima che esistesse Amazon, ma invece di realizzare comunicazioni e promozioni mirate hanno continuato (e continuano) a riempire le cassette della posta di tutti indistintamente con gli stessi volantini (e quindi parlano TUTTE sostanzialmente solo di prezzo).