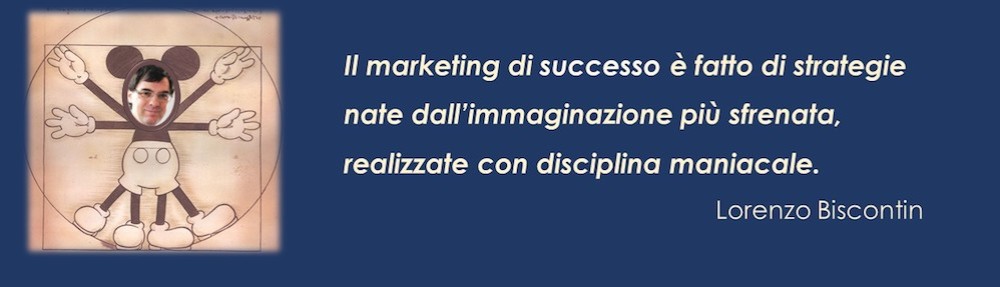Questa settimana avevo bisogno di un post leggero, defaticante, dopo lo sforzo di confrontarsi con un tema come la visione per il futuro del Paese di Farinetti.
Prendo allora spunto dalla campagna #coglioneNO, su cui mi sono già espresso con un tweet “Com’è che le agenzia di pubblicità non mi hanno mai proposto una campagna a basso costo così efficace? Cliente sì #coglioneNo.”
La campagna è già stata ampiamente commentata da diversi punti di vista. Qui di seguito i link ai primi risultati che appaiono su twitter: Wired, minima&moralia, il post, blog del Corriere, osservatori esterni, le parole e le cose con un post del 2012 coerente con il tema della campagna.
Pare che i media abbiano già consumato l’argomento, sicuramente più di quanto immaginavo. Cosa posso aggiungere io? Il punto di vista, finora assente, di chi da quasi vent’anni paga per servizi di creatività.
Ho iniziato a fare il cliente di agenzie nel settembre del 1994 e, se mi sono ricordato di tutti, in questi anni ho lavorato con almeno 20 agenzie pubblicitarie (che hanno fatto anche grafica, Pubbliche Relazioni, attività promozionali), 10 agenzie di Pubbliche Relazioni e 7 studi di design. A questi vanno poi aggiunte le agenzie che ho analizzato durante le selezioni per decidere a chi affidare i lavori, e altre strutture a minor intensità di creatività come le agenzie di oggettistica promozionale, i centri media, le case di produzione cinematografica e gli istituti di ricerca di mercato.
Si è trattato di strutture di tutti i tipi: multinazionali, nazionali, locali; agenzie affermate ed agenzie che iniziavano.
Diciamo in sintesi che ho visto un po’ di situazioni e sono stato testimone di un po’ di cambiamenti.
Nel 1994 c’erano ancora aziende che nel selezionare l’agenzia a cui affidare una campagna faceva una gara retribuita, a cui però le agenzie si presentavano con la campagna fatta e finita e declinata su tutti i mezzi (TV, radio, stampa).
Il compenso dell’agenzia era una commissione del 15% sull’importo dei costi della pubblicità, sia i costi di produzione che quelli di acquisto degli spazi pubblicitari. Questa % era uguale per tutti e nessuno nemmeno pensava che potesse essere oggetto di contrattazione. Se non ricordo male, era normale che l’editore fatturasse al cliente e poi versasse direttamente il 15% all’agenzia.
Se l’anno dopo si utilizzava la stessa campagna,la provvigione rimaneva sempre del 15%, anche se non c’era stato alcun lavoro creativo.
Le campagne rimanevano sempre di proprietà delle agenzie, i clienti in un certo senso le “affittavano”.
Erano i tempi descritti da Silvio Saffirio nel suo libro “Gli anni ruggenti della pubblicità”.
Poi si è iniziato a prevedere una scala sconti legata all’ammontare del progetto. Ricordo un contratto fatto ancora in lire per cui si arrivava all’11% di commissione nel caso di un investimento di 1.000.000.000 di lire (che bei numeroni maneggiavamo una volta). Le commissioni sui costi di produzione hanno cominciato ad abbassarsi fino ad attestarsi intorno all’8%.
Ovviamente con questa nuova situazione gli editori hanno cominciato a fatturare ai clienti i costi degli spazi al netto del 15% di agenzia (che è rimasto come retaggio del passato, tipo la campana che apre le contrattazioni a Wall Street) e le agenzie hanno iniziato a fatturare direttamente ai clienti, sulla base delle % definite nei contratti.
Circa nello stesso periodo si è iniziato a fare contratti che prevedevano un compenso fisso in base alle attività previste, come è sempre stato nel caso di agenzie di PR e studi di design.
I ricavi pubblicitari hanno continuato a crescere fino al 2008, secondo le rilevazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ma l’aumento dell’offerta di servizi di comunicazione era probabilmente cresciuto di più perchè intorno al 2005 le commissioni di agenzia oscillavano tra l’8% ed il 4% a seconda del budget pubblicitario e del fatto che la campagna fosse nuova oppure venisse ripetuta.
Basta l’eccesso di offerta attuale, complice anche una domanda calante, a spiegare la commoditizzazione dei lavori creativi che porta (tante) aziende a scegliere solo in base al prezzo fino al limite di puntare a non retribuire i servizi di cui hanno bisogno? Secondo me da solo non basta perchè un lavoro fatto male costa comunque. Un folder fatto male significa meno vendite, un evento mal organizzato implica comunque dei costi vivi, un’etichetta sbagliata abbassa il posizionamento del prodotto.
La percezione di assoluta fungibilità tra le diverse opzioni di servizi creativi (ma se volete parlate con un avvocato, la stragrande maggioranza ha lo stesso problema) che porta a scegliere solo in base costo, portandolo possibilmente a 0, è un atteggiamento predatorio (estremizzo) simmetrico a tanti anni del medesimo comportamento da parte delle agenzie (ho detto che sto estremizzando). Un po’ non ho la garanzia che pagando (di più) ottengo risultati migliori, un po’ sfrutto la posizione di (maggior) forza adesso che posso.
La situazione (forse) non sarebbe, e non è, così estrema in presenza di un rapporto di effettiva fiducia e collaborazione tra agenzie e clienti. Se i fornitori non ti chiamassero per proporti lo stesso gadget dell’anno prima al 15% in meno (sa, se lavoriamo direttamente possiamo risparmiare), se i designer non proponessero a due anni di distanza le stesse soluzioni scartate per un’altro prodotto facendo finta di niente (Davvero? Scusa ma abbiamo cambiato l’account. Ossia il responsabile clienti, n.d.a.), se non facessero seguire le campagne stampa nazionali agli stagisti (con io che vedendo l’errore nella bozza di stampa gli spiegavo dove si erano sbagliati i creativi rispetto alle proposte e lei che insisteva che no, che assolutamente, che avevano controllato tutto).
Poi c’è un punto che credo sfugga a buona parte dei giovani creativi, un po’ per inesperienza un po’ per scarsa/cattiva formazione: la creatività in sè non è quasi mai l’elemento discriminante nella scelta dell’agenzia con cui lavorare. La discriminante è la capacità/volontà della struttura di dare risposte creative coerenti alle esigenze di comunicazione del cliente in modo continuo e costante nel tempo e nello spazio.
Un reparto creativo qualche buona idea la produrrà sempre, se non altro per statistica, ma è l’impostazione complessiva del lavoro che garantisce che l’agenzia sarà in grado di fornire soluzioni efficaci per me come ha fatto in passato per altri. E quando ho cambiato agenzie (e ne ho cambiate un po’) è stato perchè si era persa la capacità e/o la volontà di sforzarsi per trovare soluzioni originali alle nostre necessità. Gli stessi creativi che mi avevano fatto campagne eccellenti, che vincevano i premi a Cannes con campagne fatte per altri clienti, non erano più in grado di dare a noi risposte altrettanto buone.
E non è vero che non si possano pianificare e misurare efficacia e valore del lavoro creativo nel fornire soluzioni di comunicazione. Però bisogna esserne capaci e non ha niente a che vedere con l’arte.
Concludo con alcune precisazioni:
- non è vero che nessuna agenzia non mi abbia mai proposto campagne a basso costo efficaci. Devo rendere merito a Marco Durazzi di aver sviluppato nel 2005 per Keglevich la campagna virale Your Fun quando dirigeva EuroRSCG 4D (costola di EuroRSCG che si occupava di promozioni e avd digitale).
- non ho mai pagato gli stagisti (a parte il rimborso dei pasti). Ho sempre avuto solo stagisti veri, ossia persone che all’interno del loro percorso di formazione dovevano passare un periodo in azienda. Li ho sempre coinvolti nel lavoro come un qualsiasi componente del gruppo così potevano imparare cosa succede davvero in azienda (si hanno anche fatto le fotocopie quando serviva). Spesso hanno chiesto di prolungare lo stage oltre il tempo previsto.
- non ho mai fatto lavorare gratis nessuno. A volte è stato difficile, perchè con persone veramente alle prime armi, quando ho chiesto un preventivo mi sono sentito chiedere quale era il budget. Ora se tu sei un professionista DEVI sapere quanto vale il tuo lavoro e se io sono un professionista a questa domanda devo rispondere “non c’è budget” e aspettare la tua controproposta. Dopodichè so’ ragazzi e vanno aiutati.
- non discuto (quasi) mai nel merito le richieste economiche delle agenzie perchè ognuno è libero di dare al proprio lavoro il valore che ritiene opportuno, soprattutto quando i costi vivi sono bassi. Le confronto sempre con le risorse disponibili per quel progetto e con il costo di soluzioni che valuto equivalenti.
- per certi lavori per cui le risorse erano limitate, inferiori alla media di mercato, ho segnalato quelle che potevano essere le ricadute di visibilità, addirittura di divertimento date dall’originalità dei progetti. In trasparenza, senza millantare del credito. Questo per permettere all’agenzia di fare una valutazione complessiva, considerando, se volevano, anche questi elementi. Non mi ricordo che mi abbiano detto no, nè che si siano pentiti dal non averlo fatto.
- ogni tanto l’agenzia va “frustata”. Lo dico con rammarico perchè implica fatica e perdita di tempo, ma dopo tanti anni non posso fare altro che ammetterlo. E’ necessario per farla uscire dagli impasse in cui si avviluppa perchè per pigrizia o testardaggine si blocca su punti di vista autoreferenziali. Ovvio che se vi trovate a farlo una volta sì e una volta no è il momento di cambiare agenzia.
Concludo davvero con quello che mi ha detto un giovane e bravo creativo di provincia (e di successo) l’altro giorno quando parlavamo della campagna #coglioneNO “Comunque se quando l’azienda XY mi propose un lavoro a 0 budget (detto in anticipo perchè la chiarezza è un indicatore di serietà ed affidabilità) avessi detto no, oggi non sarebbe uno dei miei principali clienti (paganti)”.
In realtà investire nel proprio tempo è più semplice che investire soldi (che magari, soprattutto agli inizi, sono pochi). Però in tutti i casi bisogna saper investire nel modo giusto.
P.S. mi scuso per il turpiloquio, ma di questo magari parlo un’altra volta.