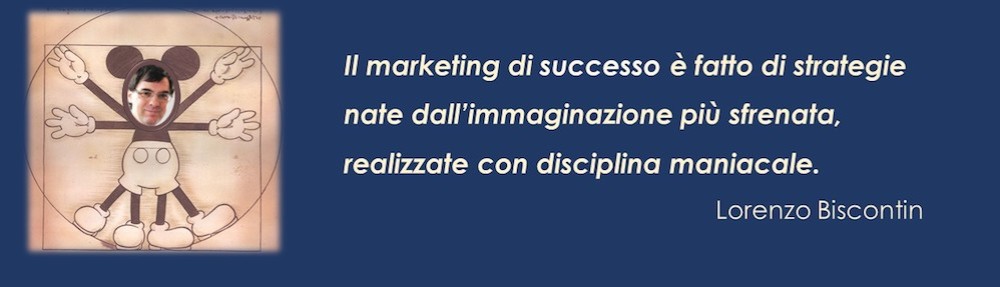Non sono morto, sono solo molto occupato. Sto pagando, come molti, il fatto che l’anno lavorativo e’ iniziato il 9 gennaio e sto cercando di recuperare. Quindi quando non lavoro mi dedico al riposo piu’ totale. In attesa di tornare a post piu’ corposi, linko (sara’ ammesso il neologismo?) questa notizia sul cambio di strategia di Procter & Gamble. Notizia di assoluto rilievo se si considera che P&G viene ritenuta l’azienda che ha negli anni 50-60 del secolo scorso ha creato il marketing management come modello aziendale.
Category Archives: Blog
Marketing di Natale: 1880, el turron mas caro del mundo
Per le feste appena trascorse, conoscendo le mie passioni, mi hanno portato del torrone dalla Spagna.
Il torrone in Spagna è IL dolce di Natale ed è quindi un settore su cui, soprattutto durante le feste c’è una fortissima concorrenza.
In teoria il torrone spagnolo non è molto diverso da quello italiano, in pratica è tutto altro perchè le proporzioni degli ingredienti vedono la netta predominanza delle mandorle (circa il 65% dell’impasto) e del miele sullo zucchero. Leggete la lista degli ingredienti, elencati per legge in ordine decrescente, su una confezione di torrone italiano e capirete cosa intendo. Poi in Spagna si produce un tipo particolare denominato di Jijona, dal nome della località che gli dà la denominazione d’origine, che è una specie di crema/pasta friabile fatta con gli stessi ingredienti del torrone “duro” macinati molto, molto finemente.
Prima di andare in Spagna e scoprire il torrone spagnolo, portato comunque, anche lì come da noi, dagli arabi, compravo lo Sperlari “Antica Ricetta”, ma non lo trovo da anni. Il mandorlato di cologna Veneta invece, non so perchè, non mi ha mai entusiasmato, malgrado le elevate percentuali di ingredienti “nobili”.
Ad ogni modo apro la sulla scatola della marca 1880 (una delle aziende storiche del settore) e sul film alluminato nero che avvolge il prodotto trovo il claim “1880, el turron mas caro del mundo” ossia “1880, il torrone più costose del mondo”.
Questa affermazione così ostentativa mi ha colpito visto che da diversi mesi a questa parte il sentiment è tutto basato sui concetti di convenienza e understatement. Mi mi ha anche colpito perchè mi ha dato immediatamente l’idea che avrei mangiato un prodotto di altissima qualità.
Attenzione si tratta di una marca e di prodotti che si comprano normalmente nei supermercati e, tra l’altro, non era nemmeno la mia marca preferita (io normalmente compravo El Almendro). Però quel claim inaspettato, anche perchè non era sulla confezione esterna, ma solo su quella interna, ha modificato il mio percepito.
Andando poi a vedere il sito ho scoperto che si tratta del posizionamento strategico della marca, su cui si basa tutta la comunicazione (spot TV compreso).
Ho ripensato quindi al razionale che ci può essere dietro a questa strategia:
- il consumo di torrone a Natale è sempre condiviso nel senso che è un prodotto che si regala oppure che si mangia insieme in famiglia e/o si offre a chi viene a casa
- il posizionamento come “più costoso del mondo” differenzia la marca rispetto ai concorrenti, anzi la stacca portandola nell’eccellenza assoluta;
- gratifica chi lo compra per il proprio consumo o chi lo riceve come regalo;
- rassicura chi lo utilizza come regalo, perchè gli garantisce di fare bella figura (che il prodotto piaccia o meno, io per te non ho badato a spese comprando il torrone più costoso del mondo);
- il prezzo oscilla tra i 7 e gli 8,5 euro (a seconda della pezzatura e del punto vendita) ed è quindi in assoluto accessibile alla stragrande maggiornaza dei consumatori. In media il torrone 1880 costa circa il 20% in più rispetto ai concorrenti, ossia 2 euro in più a pezzo. Non è poco, ma quanto vale la sensazione di sapere di aver dato il meglio a noi stessi ed ai nostri cari, almeno a Natale? Ancora di più in un periodo di incertezza e sacrifici.
Come sempre le strategie di marketing sembrano tutte ovvie a posteriori, ma a me questa sembra una delle strategie di “lusso accessibile” più brillanti che abbia visto ultimamente e probabilmente è quella che più si avvicina al concetto di “lusso inclusivo” di cui fantasticavo oramai più di tre anni fa.
E se vi sembrano considerazioni un po’ autoincensatorie provate a pensare alle strategie di posizionamento delle marche italiane da ricorrenza (Bauli, Motta, Melegatti, Paluani e compagnia).
Buon lavoro a tutti per domani.
Epifania
Questo post non c’entra proprio niente con l’argomento del blog, pero’ oggi leggendo “Tutte le Poesie” di Andrea Zanzotto mi sono imbattuto casualmente in questa dal titolo, appunto, EPIFANIA e la coincidenza mi ha fatto venir voglia di riportarla. Si concludono cosi’ le feste e da domani torno a parlare di marketing.
EPIFANIA
Punge il pino i candori dei colli
E il Piave muscolo di gelo
nei lacci s’agita, nel bosco.
Ecco il mirifico disegno
la lucente ferma provvidenza
la facondia che esprime
e riannoda e sfila
echi, gemme, correnti.
Tra voi parvenze e valli appena
sollecitate dal soffio del claxon,
mormorate dall’alba,
valgo come la foglia che riposa
col vivo cardo col bozzolo e l’oro,
valgo l’onda minuscola
che fu tua sete scoiattolo un giorno,
valgo oltre il dubbio oltre l’inverno
che s’attarda celeste ai tuoi balconi,
valgo piu’ che il tuo stesso
venir meno con la neve
che il motore per sempre, fuggendo
dietro al sole, tralascia.
Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia 3
L’intenzione era che questo post fosse l’ultimo della serie, però ho approfittato delle vacanze per leggermi con calma il numero di dicembre della rivista Meininger’s Wine Business International (rivista che consiglio caldamente a chiunque si occupi di vino) e ci ho trovatop una serie di spunti tale che forse un solo post non basterà per esaurire l’agomento. Ad ogni modo cominciamo.
Nella puntata n. 2 di questa serie dicevo che il principale problema da affrontare da parte del settore per rilanciare il consumo di vino in Italia è quello della percezione. Per chiarire meglio ed inquadrare la cosa attingo da diversi articoli che trovate nella rivista sopracitata. Mi scuso in anticipo con chi ha poca dimestichezza con l’inglese, ma lascerò le citazioni in originale per evitare di dare l’impressione di essere io troppo enfatico nella traduzione.
Joel Peterson, considerato uno dei più importanti enologi californiani di sempre, su come creare un vino super-premium: I’ve always thought the less advertising I do the better off I am.
Pancho Campo, cileno, tennista, allenatore di tennis alla Bollettieri Academy e della nazionale cilena, organizzatore di eventi e concerti a livello mondiale, fondatore della Wine Academy of Spain e creatore dei seminari internazionali Winefuture e World Conference on Climate Change & Wine in un’intervista a tutto campo (gioco di parole involontario) sul mondo del vino:
DOMANDA: The worlds of sports and event management are very different? What surprised you about the wine industry?
CAMPO: two things. One is that it is a very closed environment, especially in Spain. … I was also surprised to see the way that wine was marketed, sold and promoted. It was so ancient.
DOMANDA: What’s the biggest issue facing wine?
CAMPO: … We are losing consumers, which is for me the most worrying challenge. The wine industry is not exciting potential consumers…
DOMANDA: What’s the problem?
CAMPO: The way we communicate is only understood by wine people (n.d.a.: visto lo spessore del personaggio qui confesso che ho avuto un innalzamento di amor proprio). 90% of people who write or blog about wine look only at the top wines, the one above € 25,00. These are wines for experts and serious aficionados. What makes the industry tick is the bottom of the pyramid, the wines below € 7,00 (n.d.a: nella GDO italiano oltre il 50% delle vendite a volume di vino in bottiglia è realizzato con vino di prezzo inferiore a 5 €/bottiglia), but we pay no respect to those wines or those consumers.
DOMANDA: Is more education the key?
CAMPO: I am so totally against “we need to educate the consumer” (n.d.a.: adesso si che mi pento di non aver trovato il tempo di andare al Winefuture in Rioja). Somebody says, “I know nothing about wine,” and we say, “Oh! You should take a course!” no you don’t. If I go to a restaurant, I do not want to take a course to understand cheese. I just want the hedonistic experience. I will be ruined if someone tels meI can’t have the cheese unless I do a course. The people who need to be educated are the trade, on how to communicate, promote and sell wine.
Chiudo le citazioni riportando l’esempio che Robert Joseph fa nella sua rubrica (impossibile riassumerla, ma raccomando fortissimamente di leggerla) della descrizione che una cantina del Nuovo Mondo (nel settore del vino si intendono tutti i paesi al di fuori dell’Europa) fa del proprio Pinot Nero: 82 parole per descrivere come il vino è stato fatto e solo 31 per descriverne le caratteristiche o come scrive Robert … about the stuff a consumer might pay for…
Quanto si applicano queste considerazioni alla situazione italiana? Azzarderei un 100%.
Escludendo per un momento il vino in brick (ma poi ci ritorno) il sistema della comunicazione del vino in Italia italiana è dedica il la grandissima parte delle risorse finanziarie ed umane ad interagire con la critica enologica in termini di PR e per pubblicità sulle testate specializzate.
Dal punto di vista del target questo implica sostanzialmente predicare ai convertiti, ossia ai famosi wine lovers stimati in circa il 10%.
Dal punto di vista dei contenuti redazionali si utilizza un approccio da iniziati, in un certo senso coerente con il target, così tradizionale ed ortodosso nei contenuti e nello stile da risultare a volte (frequentemente?) settario. Il tutto con un’autorefrenzialità, che ha già vistosamente ridotto il seguito dei mezzi off line e si sta rapidamente estendendo a quelli on line.
La pubblicità del vino su questi mezzi rischia frequentemente di rivelarsi inutile, se non addirittura controproducente come dice come dice Peterson, perchè ha una credibilità e rilevanza per i lettori intrinsecamente molto più bassa rispetto alla parte redazionale (gli articoli). Se non si riescono ad individuare dei contenuti originali e credibili, espressi in modo coerente ed interessante (ma Robert Joseph ha evidenziato quanto sia difficile), l’effetto banalizzazione e conseguente massificazione è praticamente automatico, soprattutto ricordando qual’è il target dei lettori di questi mezzi.
Ritengo quindi estremamente improbabile che da qui nascano nuovi spunti di interesse per avvicinare al vino nuovi consumatori.
In realtà il problema principale della comunicazione del vino in Italia è il ridottissimo livello della comunicazione diretta delle eziende e delle marche al consumatore, sia in termini di pubblicità che di publicity/pubbliche relazioni.
Facendo una stima spannometrica per difetto il valore del mercato del vino in Italia ai prezzi di consumo si aggira sui 3 MILIARDI di euro. Un’incidenza delle spese di comunicazione del 2% porterebbe ad un investimento di 60.000.000 di euro. Ora i dati che ho sugli investimenti pubblicitari sono piuttosto vecchi, ma non credo che questi superino i 10 milioni di euro, comprendendo le campagne TV delle marche di vino in brick.
La conseguenza è che la principale comunicazione sul vino che riceve il 90% dei consumatori sono le (forti) campagne pubblicitarie di Tavernello, Ronco, ecc… Non c’è da stupirsi del calo di interesse nei confronti della categoria da parte dei nuovi potenziali consumatori.
Il ridotto livello degli investimenti viene spesso ricondotto alla frammentazione del settore ed alla conseguente piccola dimensione delle cantine.
E’ un’affermazione che non condivido per due motivi:
1) c’è comunque un gruppo di aziende che sviluppa sul mercato italiano un fatturato tale da giustificare/richiedere un sostegno pubblicitario della marca e l’investimento necessario, oltre ad avere (potenzialmente) la struttura e le competenze per sviluppare una comunicazione rilevante per ampie fasce di consumatori.
2) il calo dei consumi è legato ad un problema di percezione della categoria e quindi può essere efficacemente affrontato con strategie di comunicazione collettiva di respiro nazionale, vino italiano, o di distretto, Consorzi. In quest’ultimo caso addirittura favorita dalla frammentazione dei consumi che porta i consumatori a riconoscere più i marchi consortili delle marche aziendali.
Il problema quindi è più CULTURALE che strutturale.
Già che ci sono vorrei smentire un’altro mito del mondo del vino italiano relativamente alla mancanza di informazioni: il sito del Vinitaly fornisce ricerche che bastano per sviluppare strategie per i prossimi 5 anni a cui si accede con una semplicw registrazione e Marco Baccaglio continua il suo ottimo lavoro di quantificazione dei fenomeni di mercato sul suo blog “I numeri del vino”.
Anche qui il problema è culturale e non strutturale.
Concludo (finalmente) con l’ultima citazione da un articolo di Meininger’s Wine Business International sui Super Tuscans. Dice Sean O’ Callaghan, winemaker (uso il termine inglese visto il cognome) “The problem now though is that the “Super Tuscans” are basically French varieties, maybe blended with some Sangiovese, and the result is they are boring as these wines can be found all around the world”.
Senza aprire la questione del concetto di terroir (altrimenti non finisco più) mi basta prendere a prestito da Petrini il concetto del consumatore come co-produttore per sottolineare l’importanza della domanda interna nel mantenimento dell’identità del prodotto e quindi nella sua differenziazione rispetto ai prodotti concorrenti. Una domanda interna debole indebolisce l’identità del vino italiano, esponendolo ad una maggior concorrenza da parte dei vini prodotti in altri paesi sui mercati esteri.
A tutti il mio augurio di un felice 2012.
Social media marketing: cacciatori di scalpi!
L’altro giorno arriva una mail in azienda ricordando di rinnovare l’iscrizione ad un data base on line e sottolineando che allo stesso costo del 2011 avremmo avuto piu’ visibilita’ perche’ le visite al sito erano aumentate di 300.000 visitatori.
Telefonata all’agenzia che ci gestisce il sito, chiesto quanti visitatori avevamo ricevuto da quel data base, risposta “0″, risparmiati 100 euro.
Morale: come sanno oramai anche i sassi (che comunque sono vivi, solo ad un ritmo incredibilmente piu’ lento del nostro) il web ha il grande vantaggio di poter misurare buona parte dei risultati di quello che si. Bisogna pero’ averne il tempo, la voglia e la capacita’ (un po’ come per le catene di supermercati utilizzare i dati delle carte fedelta’ dei consumatori per realizzare strategie piu’ efficaci del 3×2 a tutti).
Invece anche nel web, come in ogni settore, valgono le mode e adesso siamo nel clou della moda del social media marketing.
Ecco quindi tutti a fare a gara per il numero di likes su facebook o di followers su twitter. I termini ufficiali sono fan, amici, followers, ma per me nella stragrande maggioranza dei casi la parola giusta è … scalpi.
Nel senso che finiscono per essere trofei da mettere in mostra senza diventare dei veri rapporti tra la marca/azienda e le persone/consumatori-trici.
Un po’ di numeri di fan presi da facebook pescando nel settore alimentare,senza nessuna pretesa di correttezza del campionamento:
Coca-Cola (pagina ufficialmente NON creata dall’azienda, ci credo fino a lì): 36.492.100 likes.
Starbucks: 26.517.529 likes (che diventano parecchi di più se si sommano quelli delle fan page nazionali dei diversi Paesi).
Nutella: 11.887.333 likes (poi ci sono tutti gli altri marchi della Ferrero che hanno altri svariati milioni, mentre quella della Ferrero come azienda che ha solo le informazioni, non ha nemmeno la bacheca e tra quella in inglese e quella in italiano non arriva nemmeno a 10.000 likes. Coerenti fino in fondo nella loro strategia di branding, come sempre giù il cappello davanti ai signori di Alba).
Illy: come tale non c’è. C’è come illyssimo e come espressamente illy rispettivamente con 11.229 e 3.202 likes (????).
Lavazza: 53.995 likes (??).
Barilla: 42.267 likes (???).
Qui mi fermo ed aggiungo il link ad una mia analisi sui risultati facebook delle cantine italiane presentata un anno fa al wine camp di Firenze Wine Town.
La domanda, oggi come allora, è: al di là delle mode qualcuno si è soffermato ad analizzare i dati quanti-qualitativi deilla propria attività di social media marketing?
Perchè la quantità di Coca Cola o Starbucks può fare da sola anche la qualità, per gli altri esempi di grandi aziende italiane, ma i commenti per Illy e Lavazza vengono anche dall’estero, direi che proprio non ci siamo (siccome è quasi Natale non vado a guardare quelle piccole). Ricordo che nel 2010 (dati più recenti non ne ho trovati) gli utulizzatori di facebook in Italia erano 16.000.000.
Non siamo in termini di efficenza perchè facendo una stima per difetto un’azienda come Barilla tra struttura delle piattaforme, loro gestione e gestione delle relazioni almeno 60.000 € all’anno sul social media marketing li mette. Quindi parliamo di 1,5 €/contatto. Che è un enormità.
La replica delle agenzie che si occupano di web a vario titolo è che però sono contatti qualificati, che costruiscono una relazione tra la marca e le persone, che a loro volta diventano ambasciatori della marca. Benissimo!
Signori brand managers quand’è l’ultima volta che siete andati a guardare le statistiche di attività dei fan della vostra pagina facebook? Scoprirete che, come accade tra gli “amici” della vostra pagina personale, l’80% dell’attività è fatto dal 20% degli iscritti (se va bene) e quindi i numeri di cui sopra diventano ancora più piccoli.
Anche perchè per creare una relazione bisogna avere dei valori forti ed impegnarsi poi a costruirla ed a mantenerla, magari, come insegna l’ABC del (web) marketing coinvolgendosi in prima persona e non facendo gestire le attività social al personale dell’agenzia di PR. Sarà un caso che Starbucks 2 anni fa aveva 16 dipendenti a tempo pieno per seguire le proprie pagine facebook?
Invece prevale il delirio narcisistico da onnipotenza che porta le aziende a credere alle agenzie quando gli dicono “noi creiamo lo spazio, per un po’ tempo attiviamo l’interesse e la discussione con i nostri contenuti e poi la comunità si muove e cresce da sola”. Non è necessaria una grande umiltà, basterebbe un po’ di buon senso per chiedersi se davvero i valori, la qualità e credibilità dei contenuti che esprime la marca siano così forti e rilevanti da portare le persone a coinvolgersi così tanto personalmente. In altre parole la maggior parte delle persone ha per la maggior parte delle marche poco più di una preferenza (ed è giusto che sia così), cosa che non è sufficente per accendere forti affinità con le altre persone che condividono questa preferenza e meno che meno per coinvolgersi personalmente attivimanete in quello che la marca fa on e off line. Detto in altre parole ancora, se voglio creare uno spazio sul web in cui trovarmi con i miei amici o trovare degli “amici”, ci sono un sacco di posti migliori.
Sto implicando che il social media marketing è un non-senso per la maggioranza delle aziende? Nemmeno per sogno. Sto implicando che vanno definiti obiettivi sensati e strategie coerenti agli obiettivi in termini dei risultati da conseguire e delle risorse da investire.
Quando mi occupavo di queste cose preferivo reclutare di APOSTOLI più che di ambasciatori della marca.
Preferivo avere 100 contatti in meno (tanto tra averne 1.000 o 1.500 sempre pochi sono).
Preferivo riuscire a seguirli in modo da arricchire la relazione ogni giorno.
Preferivo rivolgermi aglli opinion leaders pubblici e privati (ossia quelli che sono opinion leaders nel loro ambiente) per ottenere un effetto alone (o virale come si dice oggi).
E periodicamente c’era qualcuno che diceva si … ma … quel concorrente ha 100 – 200 -500 fan più di noi, mentre la vera domanda dovrebbe essere: non è che questi soldi possono essere investiti meglio in altre cose, al di là delle mode?
Trascorrete un Natale di pace perchè, come diceva lo spot della Coca Cola, la felicità non va mai in crisi. Oppure se preferite Tolstoi “Se vuoi essere felice, siilo”, che il concetto non cambia.
Per la befana prometto la terza,e ultima, puntata sul calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia.
Luck is an attitude
Il titolo di questo post è il claim dell’ultima campagna di Martini. Ancora una volta giù il cappello davanti alle loro strategie di posizionamento e di comunicazione (l’agenzia sarà ancora Armando Testa?).
Concetto positivo ed ottimista, però con trattamento cool e non buonista. Lancio della campagna su e con i social networks. Spot tv con schermo diviso in due, un po’ sliding doors, un po’ multitasking un po’ programma 3D senza occhialini. Tra l’altro la complessità della visione aumenta l’attenzionalità invece di diminuirla. Per di più un concetto alla base di un libro di gestione aziendale che avuto un discreto successo alcuni anni fa (come sempre meglio il libro del video, ma altro non ho trovato).
Altro spot degno di nota di questi tempi è quello di Campari che torna alle atmosfere un po’ oniriche e molto glamour/aspirazionali degli spot con cui 10 anni fa è riuscito a riposizionare la marca da vecchia ad “eterna”, senza però la cripticità di una volta (lo spot con i duel duellanti nel tempio indiona non l’ho capito nemmeno quando me l’hanno spiegato i pubblicitari.
Ci sono invece due spot alla radio che non si possono sentire.
“La festa decolla se non c’è il gorgonzolla” riesce a non vincere il premio come peggior campagna del consorzio solo perchè la precedente “bella topolona” toccava qualsiasi fondo immaginabile, soprattutto considerando che le donne sono le principali responsabili d’acquisto del prodotto. Sarà che mi hanno trattato con prosopopea fin dalla prima volta che ho conosciuto (l’allora) direttore del consorzio ai tempi della mia tesi di master, ma le strategie del Gorgonzola non riesco proprio a capirle. Non solo in termini di comunicazione, in termini di prodotto hanno abbandonato totalmente il segmento del formaggio erborinato piccante ai prodotti olandesi o danesi. Va bene che è una tipologia di consumo in calo, ma abbandonare anche solo una nicchia di mercato di questi tempi mi sembra parecchio miope (in realtà è una strategia che va avanti da lustri). Spero solo che non prendano troppi soldi pubblici.
Ma la palma della pubblicità radiofonica più insopportabile dell’anno va a quella della skoda dove c’è uno che parla tutto lo spot con la bocca piena. Tutte le volte che schiaccio il mute della radio appena la sento penso alle storie che avranno raccontato i creativi al cliente sull’impatto di questo trattamento iconoclasta.
Forse sono gli stessi che si sono autoconvinti che “La festa decolla se non c’è il gorgonzolla” sarebbe diventato un tormentone.
Chiudo con una frase di Peter Sellars che amo (la frase, non Peter Sellars): “la vita è uno stato mentale”. Non so come fosse in originale, ma credo si possa tradurre come “life is an attitude”.
Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia 2
In realtà la questione del calo del consumo di vino nel mercato italiano io l’avevo posta un paio di mesi prima del Vinitaly ai partecipanti al corso di sommelier di IV livello organizzatto da AIS ed Alma (detto senza ironia, l’apice istituzionale della conoscenza del vino in Italia), durante una mia testimonianza aziendale.
Alla domanda “perchè il consumo di vino in Italia continua a calare?” gli allievi avevano risposto in sintesi:
1) sono cambiati gli stili di vita/consumo (risposta semitautologica).
2) si è ridotto il consumo dei giovani (come sopra).
3) il consumo di vino è penalizzato dalla stretta dei controlli alcol test su chi guida.
Partendo dall’ultima risposta allora sono passato al livello superiore e quindi ho chiesto “e allora come mai il consumo di birra cresce” (fenomeno che si verifica in maniera ancora più eclatante in Spagna e, in modo meno chiaro in Francia: guarda caso i tre storici paesi produttori e consumatori di vino).
Qui la risposta è stata unanime: “perchè la birra è meno alcolica”. Peccato che si tratti di un falso mito, basato sul fatto intuitivo che la gradazione alcolica unitaria della birra è inferiore a quella del vino. Esistono però anche le verità contro-intuitive, che quindi vanno spiegate ed in questo caso la verità è che i grammi di alcolo contenuti in un bicchiere standard (qui il termine inglese serving è veramente l’ideale) di vino, birra o superalcolico è il medesimo.
Questa semplice (e non semplicistica) considerazione racchiude buona parte del problema del calo dei consumi di vino in Italia, che è sostanzialmente un problema di PERCEZIONE. A corollario aggiungo che la cosa curiosa è che il consumo di birra sta crescendo trainato da una ricerca e curiosità di approfondimento della varietà degli aspetti organolettici molto simili a quelli che (hanno) caratterizzato il vino.
Il problema di PERCEZIONE del vino nasce probabilmente dall’evoluzione che ha avuto il settore negli ultimi vent’anni in risposta allo scandalo del metanolo, sia in termini di qualità e profilo dei prodotti che, soprattutto, in termini di come questi sono stati presentati e comunicati dai mass media negli ultimi vent’anni. Il miglioramento della qualità del vino italiano, sia nella media che nelle sue punte di eccellenza raramente raggiunte in precedenza, è stato allo stesso tempo sostenuto e stimolato da un approccio al prodotto centrato sull’approfondimento degustativo delle sue caratteristiche organolettiche partito da un nuovo movimento di critica enologica che si è man mano diffuso in fasce sempre più ampie di consumatori. Il cristallizzarsi di questi due fattori, che hanno indubbiamente creato il rinascimento del vino italiano, è sfociato nell’attuale problema di PERCEZIONE, che, per essere compreso con maggior chiarezza, va suddiviso almeno in tre aspetti:
1) PERDITA DI IDENTITA’ DELLA CATEGORIA DI PRODOTTO
Circa 50/40 anni fa, quando il consumo italiano era di 100 litri/annui pro-capite, il vino era un alimento, o per meglio dire un nutriente, poi è divento una bevanda. Il cambiamento è determinato dal cambiamento della società e non è necessariamente negativo, poichè riduce l’effetto della legge di Engel che prevede una diminuzione della parte di reddito destinata all’acquisto dei beni alimentari al crescere del reddito in quanto questa interessa solamente la componente nutritiva di un alimento e non quella edonistica.
Attualmente però la componente culturale, ancor più che edonistica, del vino è diventata talmente preponderante da fargli perdere in larga misura la sua natura di bevanda. Il problema è che se un liquido che si beve non è una bevanda che cos’è. Può sembrare un discorso di lana caprina, ma per rendersi conto che non lo è basta ricordare che Giorgio Calabrese (docente di alimentazione e nutrizione umana e presidente dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) sta portando avanti da qualche anno il ritorno al concetto (reinterpretato) del vino-alimento.
Detto in maniera ancora più chiara e netta non è un discorso di lana caprina perchè oggi ci troviamo nella situazione in cui quando qualcuno ha sete il vino raramente rientra tra le possibili opzioni. Oggi la stragrande maggioranza delle persone beve vino quando ha fame (escludo la numerossisima minoranza dei cosiddetti wine lovers per cui il vino è un riferimento costante dell’esistenza).
Se a questo aggiungiamo la destrutturazione dei pasti conseguente alle modifiche dell’organizzazione della società, l’impatto sui consumi di vino è evidentemente fortissimo.
Pensando alla crescita del consumo della birra credo che conti anche il fatto che ha mantenuto la sua caratteristica di bevanda con funzione anche dissetante e non credo sia un caso che la categoria di vino con la maggior crescita in Italia siano gli spumanti, ossia vini che si bevono anche e soprattutto in occasioni diverse dai pasti (gli spumanti hanno anche un’altra importante caratteristica che vedremo in seguito).
Quello che invece mi stupisce è notare la sostanziale ineluttabilità con cui il fenomeno viene affrontato dal settore vinicolo se anche un guru del vino come Sandro Sangiorgi nel suo ultimo libro “L’invenzione della gioia” prende come un dato di fatto che “Il vino, per la gran parte delle persone, è legato a un momento speciale, raramente è quotidianità”.
2) IL VINO SI E’ APPIATTITO SULL’ECCELLENZA DIVENTANDO SEMPRE PIU’ IMPEGNATIVO.
Qui c’è poco da girarci intorno: oramai la parodia del sommelier di Albanese non fa nemmeno più ridere. A furia di far roteare i bicchieri alla maggioranza dei consumatori sono roteate le … scatole. Bere un bicchiere di vino in compagnia (ma per assurdo spesso anche da soli) richiede spesso un impegno psicologico (ed economico). Sempre meno interessante, quasi mai divertente, il vino diventa noioso.
Attenzione è vero che il vino per sua natura è complesso, ma questo non significa che sia per forza necessario ricercarne e sottolinearne la complessità in ogni occasione e situazione. Tornando alla birra, l’interesse sta crescendo in certe fasce di consumatori anche grazie alla percezione di una certa complessità, mantenuta e gestita però entro limiti stimolanti e non da comunità di iniziati che, inevitabilmente, diventa settaria ed escludente. Qui posso non dilungarmi perchè recentemente si è espresso benissimo l’ottimo Alessandro Masnaghetti.
Va riscoperto il divertimento di bere un bicchiere di vino e, nuovamente, non a caso vanno bene gli spumanti, ossia vini intrinsecamente divertenti per stile e situazioni di consumo.
3) GLI ATTUALI MESSAGGI ED I MEZZI ATTRAVERSO CUI VENGONO COMUNICATI SI RIVOLGONO AD UNA LIMITATA FASCIA DI CONSUMATORI.
La comunicazione del vino oggi si rivolge principalmente ai consumatori residenti nelle aree urbane, di età (circa ovviamente) tra i 40-60 anni (sarei tentato di scrivere 35, ma temo sia un’illusione giovanilistica). Si tratta dei consumatori che negli ultimi vent’anni hanno reso l’enogastronomia una componente culturalmente importante della società e per i quali la (ri)scoperta del vino è sostanzialmente la (ri)scoperta di arcadia. Il fatto è che credevamo (ci sono dentro anche io) di essere la prima generazione della società industriale ed invece eravamo l’ultima della società contadina emigrata in città.
Tutti quei valori legati alla tradizione (di fatto ai nostri nonni contadini) per noi sono rassicuranti, ma agli under 30 dicono poco o niente. Mentre sono ovviamente questi i consumatori che daranno o meno un futuro al vino (e, nuovamente, i consumatori alla base della crescita di birra e spumanti).
Su questo aspetto un’ultima considerazione sui consumatori oltre i 60 (prima che si dica che me li sono dimenticati): sono in genere forti consumatori perchè sono quelli che vivono il vino con normale quotidianità.
L’idea era che l’argomento si esaurisse con 2 post, ma l’ora è tarda e le forze sacrseggiano. Arrivederci alla puntata n.3.
Misura per misura
Oggi tre ore di Shakespeare e quindi niente tempo per la seconda parte del calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia.
Speriamo che nel frattempo la manovra preparata dal governo dia a tutti misura per misura, anche se la frase del Grande Bardo (termine non di alta cultura, bensì reminiscenza del Corriere dei Ragazzi) che mi porto a casa oggi è: “Il mondo è sempre uguale, non fa che peggiorare”.
Il calo dei consumi nazionali di vino e la microeconomia. 1
Il 2011 è stato l’anno in cui il settore del vino italiano si è posto la questione del calo del mercato interno (non userò il terribile anglicismo di mercato domestico, anche perchè in italiano ha un significato precise e diverso: indica i consumi realizzati in casa rispetto a quelli fuori casa o alla mescita. Di questo passo chiameremo le biblioteche librerie).
La cosa probabilmente ha raggiunto una dimensione tale da non poter più essere ignorata, se poco più di un mese ad una cena durante l’European Wine Blogging Conference un blogger americano mi chiedeva cosa si stava facebdo in Italia per affrontare il problema.
Visto che non è che si faccia molto, ma di questo parlerò tra poco, vediamo di inquadrare la dimensione del fenomeno. Normalmente si cita il confronto con il passato, diciamo i 100 litri pro-capite consumati 30-35 anni fa rispetto ai 43 litri di oggi. Si tratta di un dato sicuramente eclatante, ma che ritengo poco efficace per trasmettere l’urgenza di attivare azioni di contrasto alla tendenza in corso.
Preferisco quindi provare a fare delle previsioni e farle a lungo termine visto che il tempo del vigneto e de vino spesso non coincidono con il tempo dell’uomo (citazione da Alberto Ugolini).
Incrociando molto spannometricamente i dati dell’ultima ricerca sul consumo di alcolici realizzata da Doxa per l’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol del Censis con una proiezione della distribuzione della popolazione per classi di età da qui a 25 anni (preso come il tempo medio di vita produttiva di un vigneto) ho calcolato che nel 2024 il consumo di vino in Italia sarà di circa 2,3 milioni di hl INFERIORE a quello attuale. Per dare un parametro di riferimento si tratta di una quantità superiore di oltre 13 volte al vino italiano esportato in Cina (la grande speranza dei mercati mondiali) nel prima semestre del 2011.
Personalmente la ritengo una stima per difetto, ma potrei sbagliarmi anche di molto visto che l’ho calcolata nei ritagli di tempo e con una limitata disponibilità di dati. Commissionando ad un Istituto una ricerca del costo di 3.000-4.000 euro si può facilmente avere una previsione molto più solida. Se uno dei tanti organismi pubblici e/o collettivi che operano nel marcato del vino ritiene che si tratti di una cifra abbordabile (direi di sì) e di soldi ben spesi (direi doppiamente di sì), io sono disponibile a dare il brief all’istituto ed impostare l’analisi.
Tornando al numero, credo sia tale da giustificare una preoccupazione per il settore viti-vinicolo e mi è sembrata meritevole l’iniziativa del Vinitaly che quest’anno nell’immininenza della Fiera ha stimolato un dibattito sull’argomento, coinvolgendo operatori appartenenti a tutte le diverse categorie che operano nel sistema vino in Italia (in realtà i viticoltori erano poco o nulla rappresentati. La cosa secondo me è significativa e peculiare, ma questo è un altro discorso)
Sul sito del Vinitaly trovate tutte le brevi interviste (anche la mia). Al di là dei diversi spunti, nei fatti le aziende continuona ad operare soprattutto in un logica sintetizzata nella sua dichiarazione dal dottor Piero Antinori: “Quello della crisi dei consumi interni di vino è un falso problema, preoccupiamoci piuttosto di vendere bene nel resto del mondo. Il vino di qualità e’ il prodotto più globale in assoluto, non vedo perchè ci si debba focalizzare su una nicchia di 60 milioni di abitanti quando fuori c’è un mercato di 6 miliardi di persone da conquistare. Per una volta il nostro Paese dovrebbe pensare a crescere, non a conservare”. Così il presidente dell’Istituto del vino italiano di qualità Grandi Marchi, Piero Antinori, è intervenuto nel recente dibattito sulla crisi dei consumi interni di vino. “Allarmarsi per un calo fisiologico dei consumi interni è come guardare la pagliuzza per non vedere la trave. Negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti hanno visto raddoppiare i consumi interni, per non parlare dei Paesi Bric (Brasile, Russia, India e Cina), dove 3 miliardi di persone e centinaia di milioni di nuovi ricchi si ‘occidentalizzano’ attraverso i nostri status symbol, vino di qualità in primis. In Cina – che è già un mercato potenziale da un miliardo di bottiglie l’anno – ogni 100 litri di vino provenienti dall’estero solo 5 portano l’etichetta italiana. E ancora, a Hong Kong, hub principale per la distribuzione del vino in Asia, il vino italiano si colloca in settima posizione, con una quota di penetrazione del 2,3%, contro il 33% della Gran Bretagna – che distribuisce per lo più vino francese – o il 31% della Francia. Sono questi – ha aggiunto il presidente Antinori – i veri problemi del nostro vino, non tanto quelli legati ai consumi interni. I consumatori italiani sono senz’altro tra i piu’ maturi e consapevoli al mondo: qui, negli anni, il vino si è trasformato da alimento a piacere, da abitudine a scelta culturale. Certo – ha concluso Antinori -non giovano le campagne sempre più aggressive contro il consumo di alcoolici. Campagne dove il vino è sul banco degli imputati e dove si rischia di fare di un’erba un fascio”.
.
E qui entra in gioco la microeconomia, perchè questo approccio segue il principio di massimizzazione della produttività (e reddività) marginale della teoria dell’impresa. Detto in altre parole oggi la redditività di 1 euro investito in determinati mercati esteri è (con ogni probabilità) superiore a quella dello stesso euro investito sul mercato nazionale.
La teoria microeconomica dell’impresa si basa però su alcuni assiomi che non sempre trovano riscontro nella realtà, soprattutto nel periodo medio lungo, a cui bisogna guardare se si vuole vivere e non solo sopravvivere. Se così non fosse non si spiegherebbe, ad esempio, il successo di un denominazione come la Franciacorta, le cui vendite si rivolgono in larghissima prevalenza al mercato italiano.
Quindi le domande poste da Vinitaly vanno circostanziate con maggior dettaglio e precisione:
- quali saranno gli affetti di un calo di 2,5 milioni di hl del consumo interno di vino nei prossimi 25 anni?
- quali sono i fattori alla base di questa tendenza (le previsioni basate sui trend demografici hanno il grande vantaggio di basarsi in buona parte su cose già successe)?
- questi fattori possono essere affrontati in modo da correggere il trend? Se sì, come?
- le strategie di contrasto oltre ad essere efficaci possono essere efficenti, ossia economicamente giustificate a livello di settore e/o di azienda?
Io qualche ipotesi di risposta ce l’ho, però questo post è già andato oltre ogni logica e sensata lunghezza. Mi prendo quindi del tempo per la seconda puntata, sperando magari di raccoglierne altre dai commenti che sono sempre benenuti.
A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire. Non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. (Ligabue – Niente Paura)
Il punto qui non è di essere originali, quanto di riconoscere chi ci dà le parole, come diceva Yevtushenko.
E non poteva non tornarmi in mente Ligabue e vedere e sentire oggi Maroni dichiararsi orgogliosamente all’opposizione, senza la quale altrimenti non ci sarebbe vera democrazia e ci troveremmo con un parlamento di solo maggioranza come quello di Gheddafi.
Gehddafi??? Gheddafi???? Quello a cui Berlusconi ha letteralmente baciato le mani varie volte??? Quello con cui è stato firmato un trattato di amicizia, partenariato (si sà l’inglese per tutti era nel programma di governo) e cooperazione che prevede la realizzazione di opere infrastutturali in Libia a carico del governo italiano per CINQUEMILIARDI (5.000.000.000) di euro in vent’anni (finanziati con addizionale ires a carico delle aziende che operano nel campo degli idrocarburi (chissà come mai i carburanti in Italia sono tra i più cari d’Europa?) e che il 30 agosto, giorno della firma del trattato, sia proclamato “Giornata dell’amicizia italo-libica). Se volete continuare a ridere (o piangere vedete voi), leggendo ad esempio del patto di non aggressione qui trovate il link.
Ecco non sono riuscito a rimanere indifferente all’apparente sincerità di Maroni quando lo diceva. Oppure la sincerità era autentica, e la cosa è ancora più agghiacciante. Aggiungo il dettaglio, non so se rilevante o meno, che la dichiarazione è stata rilasciata alla conferenza stampa di presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa.
Il più profetico comunque rimane sempre il De Gregori di oltre vent’anni, che, ahimè, continua a rimanere attuale.
Bambini venite parvulus
Non c’è più Limoncè.
Quando faccio la spesa dedico una particolare attenzione al reparto dei vini e liquori per ovvie ragioni professionali. Ieri ho notato con sconcerto la nuova bottiglia di limoncè, che vedete nella foto qui sotto (non a caso di fianco a Limoncetta di Sorrento).
 .
.
Conoscendo bene la storia strategica e di risultati di mercato di Limoncè per averlo “frequentato” 7 anni e gestito circa 4, ho mentalmente ripercorso l’evoluzione dei pack: da qui lo sconcerto.
In ordine cronologico, questo era la versione precedente (in realtà questa è l’immagine del prodotto al momento del lancio nel 1997, poi negli anni il tappo di sughero è stato sostituito da un tappo a vite, la scritta Stock sulla capsula sul collo della bottiglia è stata sostituita da una ripetizione del logo che è evoluto graficamente ammorbidendosi come lo si vede oggi) e sotto si vede il Limoncè ’83 inserito nel contesto competitivo dei limoncelli nel 1997, prima del lancio di Limoncè come lo conoscono tutti.


Ora non entrerò nei dettagli perchè rischio di scrivere non un post ma un blog intero.
In sintesi nel 1997 Stock con Limoncè 83 era già il leader di mercato dei limoncelli grazie alla sua forza distributiva, ma,notando un forte potenziale di mercato inespresso, decide di uccidere quel prodotto (leader di mercato sottolineo una volta di più) per lanciarne uno in grado di dare contemporaneità alla categoria di prodotto.
Limoncè diventa così uno dei più grandi successi nel mercato dei liquori e distillati degli ultimi quindici anni grazie ad una strategia pensata e realizzata con chiarezza e precisione (la fortuna, chissà come mai, accompagna sempre queto tipo di operazioni, mentre scarseggia in quelle strategicamente deboli).
Uno dei principali elementi di differenziazione che hanno costruito l’immagine della marca è stato il packaging sia in termini di forma della bottiglia ovale e allungata, che in termini di logo, in cui l’elemente del limonè diventa parte integrante di una grafica che va in direzione opposta a quelle utilizzate fino a quel momento (anche da Stock).
In poche parole Stock crea il nuovo stile del limoncello, oggi si sarebbe detto un esempio di blue ocean strategy (però il libro non era ancora stato pubblicato).
Con questa modifica di packaging l’attuale management della Stock, dopo l’insulsa campagna TV di due anni fa e l’inutile lancio del liquore Limoncè, fa abdicare la marca al proprio ruolo di leader una volta di più e quindi le dà un ulteriore spinta verso il declino.
I ghirigori su bottiglia e capsula vogliono rimandare ad una generica tradizione (e ricordano stranamente l’immagine liberty del Limoncè 83) ed indeboliscono il logo. Il limone del logo ripetuto sulla capsula è diventato una (confusa) spirale di bucce e su capsula e bottiglia si trovano due frasi diverse ma simili che reclamano la genuinità del prodotto: “Solo Limoni italiani” e “Liquore naturale di limoni”. Excusatio non petita,accusatio manifesta.
Nel frattempo il pack di Limoncetta, da anni il principale concorrente, si è raffinato unendo simpatia ed eleganza nel comunicare il suo plus intrinseco: essere prodotto con limoni di Sorrento IGP.
In sintesi Limoncè ha perso la sua leadership innazitutto concettuale e di stile e si propone con un immagine che va nella direzione di Limoncetta di Sorrento, puntando, goffamente ed inutilmente (visto che è già contenuto nel logo), sul limone quale ingrediente principale della ricetta. Carta che risulterà sempre perdente nei confronti di Limoncetta che in etichetta dichiara nell’ordine “Liquore di limoni di Sorrento”, “l’Originale”, “Ricetta tradizionale per infusione”. Ho solo un appunto da fare ad Averna, proprietari del marchio “Limoncetta” (cosa credavate? Che lo facessero le suore cieche di qualche monastero della costiera amalfitana?): sul sito c’è ancora la foto del pack vecchio.
Se penso che nella proposta che avevo raccomandato per l’aggiornamento del marchio Limoncè nel 2006 il marchio diventatava l’immagine del limone+c’è, forse capite un po’ meglio il mio sconcerto.
Perche’ Renzi ha ragione (e Berlusconi resta il fulcro della politica italiana)
Non e’ che io sia nessuno per dare patenti di ragione a chicchesia e meno che mai a Renzi. E chi sembrava un titolo intrigante e comunque calza con l’argomento di questo post che nasce da due dichiarazioni di Berlusconi che ho sentito ieri alla radio.
La prima e’ quella che l’unica conseguenza alle sue dimissioni possono essere solamente le elezioni anticipate, perche’, viceversa, andrebbero al governo quelli che hanno perso le elezioni. Il che sarebbe antidemocratico.
Dichiarazione tatticamente raffinatissima che in modo indiretto ed implicito (e quindi molto forte) sottolinea che:
- gli altri sono dei perdenti,
- sono dei perdenti perche’ non possegono vere capacita’ e quindi puntano a raggiungere i propri risultati non con il merito a con i “traffici” e le “raccomandazioni”.
- per questo fanno prevalere i propri interessi ai principi della democrazia.
Questa dichiarazione però ha un grosso difetto di credibilità perchè al governo ci sono gia’ persone che le elezioni le avevano perse e fuori dal governo ci sono persone che le avevano vinte a conseguenza delle tattiche politiche realizzate da Berlusconi. Il difetto è grosso, ma allo stesso tempo poco evidente. E purtroppo nessuno si è preso la briga di palesarlo.
L’altra dichiarazione riguarda i traditori che hanno abbandonato il pdl per passare all’opposizione. Anche qui c’è un significato implicito, anche se meno sottile: chi e’ passato a sostenere il governo era un responsabile mentre chi ha fatto il percorso inverso è un traditore. Non ci vorrebbe molto per far risaltare la contraddizione, ma nuovamente, nessuno dei dell’opposizione si è preso la briga di farlo.
Sofismi di marketing politico? Forse.
Però alle elezioni chi votereste tra dei traditori senza ideali nè onore, sono capaci solo di trafficare per raggiungere i propri scopi (che non sono capaci di perseguire onestamente) e dei responsabili tutti di un pezzo?
E se poi si votasse dopo un governo tecnico che dimostrerebbe in maniera ancora più palese l’esproprio della democrazia dai professionisti della politica?
Sembra incredibile l’insipienza dell’establishment del cosìdetto centro sinistra, argomento in realtà già affrontato più volte in questo blog qui per esempio , in modo forse piàù chiaro di oggi.
Allora a ragione Renzi quando dice che alle prossime elezioni il nuovo rappresentato da Alfano si confronterà con il vecchio rappresentato da Bersani ed ha ragione un’altra volta quando dice che chi c’è oggi deve andare a casa, perchè, escludendo la complicità, non si può essere così stupidi: e che sono persone di un altro tempo, un tempo che oramai è passato.
Verissimo che la carta d’identità non è da sola una garanzia al 100% da una parte ed un limite dall’altra, ma le probabilità sono tutte dalla parte di chi è nato almeno dopo il 1970 (quindi, con rammarico, mi escludo anche io).
Purtroppo spesso non c’è niente di peggio di aver ragione.
Live happilly
Chi segue questo blog sa che non ho lesinato in passato le critiche ad alcune strategie della Illy. Non perchè ce l’abbia particolarmente con loro, anzi per la ragfione contraria: mi rattrista vedere un chiaro leader di opinione di mercato abdicare al suo ruolo ed agli oneri che comporta, perdendo di conseguenza gli onori.
E’ stato quindi un grande piacere vedere il nuovo spot live happily con cui l’azienda della mia città d’adozione torna a ridefinire il confine dello stile, interpretando i suoi valori fondanti, e quindi atemporali, nell’attuale contesto sociale con una coerenza, forza ed efficacia come, secondo me non faceva dai tempi dello spot con Ines Sastre (1996/97).
Chapeau!
Stravecchio Branca: confezione da brividi
Un paio di settimane fa (non un paio di decadi) sullo scaffale del supermercato dove faccio la spesa ho visto questa esposizioni dei nuovi (nel senso di ultimi) astucci realizzati da Branca per il suo Brandy Stravecchio. Magariè un’anticipazione del Natale.

Ad ogni modo la domanda che mi è sorta spontanea è molto semplice: quale gruppo di consumatori (leggi target) in Italia nel 2011 dovrebbe essere stimolato all’acquisto del prodotto da una grafica come questa?
Poi magari è stato un successo di vendita. Io però, che sono malizioso, ho l’impressione che nelle intenzioni dell’operazione ci fosse anche l’idea di spingere ad un collezionamento.
Sinceramente spero per loro che questa operazione sia stata imposta al marketing dall’Alta Direzione (capita a tutti).
Il bare bones marketing funziona!
Qualche settimana fa sono passato dalla teoria (poca) alla pratica del bare bones marketing.
Contattati 6 buyer stranieri, 3 richieste di quotazioni, 1 visita fatta in azienda ed 1 da organizzare.
Non male (anche se non ho ancora chiuso nessun contratto).
Adesso sto preparando la presentazione “luci e suoni”, così magari mi chiamano anche i tre che ad oggi non si sono fatti sentire.