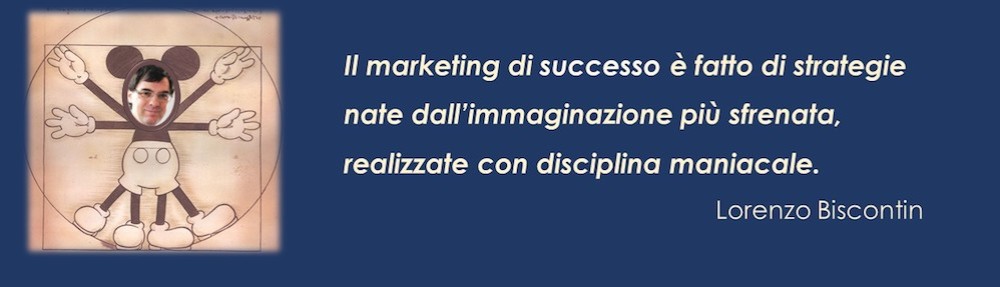Author Archives: Lorenzo
Costruire, rafforzare e mantenere marche iconiche.
L’altro giorno sul solito Marketing News dell’American Marketing Association ho letto un’intervista a Soon Yu, autore del libro Iconic Advantage .
La tentazione è di fare un copia-incolla totale, vista la quantità di cose che ho detto, pensato e (cercato di fare) nella mia attività professionale che ci ho trovato dentro.
Resisto alla tentazione e cerco di farne una sintesi ragionata, ricordando un concetto che ripeto in tutti i miei interventi formativi: le marche crescono, si rafforzano e prosperano nella misura in cui vengono alimentate di idee (significati).
Vedasi anche il mio concetto di “supermarca”.
Ma andiamo ad incominciare.
Come si crea una marca iconica?
Va innanzitutto definito il proprio punto di differenziazione unicità (vedasi il mio concetto di “Best Selling Proposition”) e quali sono gli elementi che lo rendono percepibile dal mercato (signature element).
Il punto di differenziazione non è MAI rappresentato dalle caratteristiche del prodotto, ma SEMPRE dalla rilevanza che i sui vantaggi (benefits) significano per la vita dei consumatori.
Per trovare il proprio punto di differenziazione può aiutare la piramide della marca iconica del Sig. Yu. Io uso un modello di ragionamento a matrice un (bel) po’ diverso, ma lo riservo per i clienti o per chi partecipa ai miei corsi di formazione
Bella comunque la metafora di Yu quando dice che la trappola per topi più efficace non è quella più grande o più veloce, ma quella con il formaggio dall’odore più forte.
Spesso le marche iconiche cominciano dalla leadership di una nicchia di mercato (“owning a market niche” rende forse meglio l’idea), perché questo implica una rilevanza distintiva. Per diventare iconici bisogna aggiungere la longevità alla distintività: una marca che mantiene rilevanza distintiva per un lungo periodo di tempo diventa iconica.
Come si mantiene una marca iconica?
Ci sono quattro elementi che costituiscono la cornice in cui si crea la rilevanza senza tempo di una marca iconica:
- Proteggere l’elemento che rappresenta la marca (brand signature element) per creare familiarità.
- Evolvere il racconto della propria eredità/retaggio/origini per alimentare la marca di significato.
- Innovare il vantaggio (benefit) per le persone in modo da rinnovare l’interesse (excitement).
- Re-immaginare il design per mantenerlo fresco ed attuale.
In realtà gli ultimi tre sono le leve da usare per realizzare la protezione dell’elemento che rappresenta la marca, che è il punto chiave.
Perché le marche iconiche si perdono?
Le marche iconiche si perdono per ignoranza interna, per eccessiva voglia di novità o per eccessivo immobilismo.
Ignoranza interna:
se l’azienda non sa cos’è che rende la propria marca iconica in termini di vantaggio distintivo per il mercato ed elemento rappresentativo non potrà proteggerlo. La marca continuerà a rimanere iconica “per caso”, fino a quando gli elementi della sua iconicità verranno cambiati (altrettanto per caso).
Eccessiva voglia di novità:
questo secondo è il motivo principale per cui le marche iconiche si perdono. Si verifica quando chi gestisce la marca smette di cercarne il vero significato ed elimina quello che la rendeva iconica per cercarne di completamente nuovi.
Invece di aggiornare gli elementi iconici, evolvendoli, si abbandonano per cercare di creare un significato totalmente nuovo.
Questo può avvenire:
- per un cambio del management, per cui il nuovo management non conosce chiaramente quali sono gli elementi che rendono la marca iconica (l’ignoranza interna di cui sopra) e/o vuole portare il proprio contributo alla marca.
- Per una “naturale” noia del management, che dopo anni di gestione della marca vuole fare qualcosa di nuovo e diverso.
- Per la presunzione di onnipotenza del management, che crede che l’iconicità della marca sia così forte e diffusa da prescindere dagli elementi che l’hanno generata e su cui si basa.
Eccessivo immobilismo:
E’ la trappola della coerenza, che resta comunque la base fondamentale di qualsiasi strategia di marketing di successo nel medio-lungo periodo.
Il management decide che per proteggere l’iconicità raggiunta dalla marca non si può né deve toccare niente fino alla morte. Quindi muoiono.
Coerenza vuole dire rimanere fedeli alla propria storia, ai propri valori, alla propria personalità. Questo permette di far evolvere la marca in modo equilibrato infondendo il giusto grado di novità per mantenere rilevanza ed interesse, senza perdere in familiarità.
Tutti i concetti precedenti sono sintetizzati in un esempio che fa il Signor Yu di una marca iconica e che riporto letteralmente parola per parola.
C’è Nike Air Max e il suo elemento distintivo che rappresenta la marca (signature element) è la bolla d’aria nella suola. Questo incapsula il loro punto di differenziazione della linea Air Max: rimbalzabilità (buoyance) e prestazioni. La maggior parte della scarpe da ginnastica perdono fino al 40% di sostegno durante la vita della scarpa, ma una bolla d’aria non perderà mai la sua rimbalzabilità. Nike fa tutto il possibile per evidenziare e celebrare questa differenza.
Il passo successivo da fare per proteggere la marca è infondere l’elemento distintivo con constante innovazione.
Quando Nike lanciò Air Max nel 1987 la bolla d’aria era nella parte posteriore del tallone. Col passare degli anni ha coperto l’intero tallone, poi anche la punta della scarpa ed infine l’intera suola. Successivamente sono state inserite “power pocket” di aria nei punti strategici della suola.
In trent’anni Nike ha continuato ad innovare il concetto della “bolla d’aria”, non è mai rimasto statico.
Hanno continuato a raccontare la storia della scarpa, come è stata creata, le nuove celebrità che la usavano, le nuove categorie sportive in cui la scarpa veniva introdotta e come queste introduzioni rivoluzionassero gli sport in cui entrava, fosse il golf oppure il tennis.
Nike ha continuato a far evolvere la storia, le storie creano significati e le persone amano i significati.
Se si guarda ai trent’anni di storia di questa scarpa si vede che hanno continuato a giocare con il design per mantenerla attuale con lo spirito del tempo e le tendenze della moda del momento/periodo.
Hanno protetto l’elemento distintivo che rappresenta la marca infondendolo di innovazione e creando storie al riguardo, circondandolo di rinnovato design, senza violarne la storia e famigliarità.
In pubblicità il tempismo è tutto!
Vero. E infatti avevo in programma un approfondito post sull’argomento.
Però poi mi sono trovato in aeroporto a Trieste a partire per Valencia e nell’area degli imbarchi mi sono imbattuto in questa pubblicità dell’Ente per il Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.
Un’immagine vale più di mille parole. Quindi con tre foto affronto sia il tempo che lo spazio, ossia la coincidenza il momento ed il luogo (niente a che vedere con Einsten).
La domanda è: “che senso ha?”
Che senso ha una pubblicità basata sul concetto di “convincere a non partire” un pubblico che si trova nella sala imbarchi dell’aeroporto, ha già comprato il biglietto, spedito il bagaglio, passato i controlli di sicurezza, eccetera.
E non ditemi che si gioca sul controsenso del “non partire” per convincerli a ritornare.
Story centric advertising (communication).

Storytelling è un termine che sembra oramai passato di moda nei discorsi di marketing (per fortuna diranno in molti).
Quello che non è passato di moda però è la necessità di contenuti per essere rilevanti agli occhi dei consumatori che non sono solo digital native ma anche advertising native, cosa che spesso ci scordiamo.
Sostenitore della necessità di comunicare un senso già negli anni ’90, quando il marketing è diventato il mio lavoro, assisto stupito a campagne di pubblicità/comunicazione (lo so non è lo stesso, ma passatemi la semplificazione per il momento) che sembrano vecchie di 25 anni, almeno, e mi chiedo chi può esserne interessato/coinvolto/colpito.
Tra quelle in onda adesso credo che un esempio di quello che intendo sia la pubblicità Ma – Fra, TUTTA cantata stile jingle ani ‘60 (purtroppo non sono riuscito a rintracciare lo spot sul web, questo è un link a dei commenti sulla campagna 2014, simile a quella di quest’anno ).
Pensavo a queste cose mentre leggevo un articolo su Marketing News, al solito, in cui si diceva che i professionisti di marketing di successo oggi sono quelli che si spostano da un marketing centrato sulla pubblicità ad un marketing centrato sulle storie.
Benchè non abbia MAI creduto che il marketing sia centrato sulla pubblicità e nemmeno sulla comunicazione in senso stretto, ma piuttosto sulla percezione in senso ampio, questa frase mi ha suggerito la sintesi della pubblicità centrata sulle storie che dà il titolo a questo post.
Il fatto che sia centrata sulle storie non significa che la componente verbale debba essere prevalente. Le campagne fatte da Toscani che hanno costruito la forza e la fama del posizionamento di Benetton in tutto il mondo erano basate su immagini, senza nessuna parola. Stiamo parlando degli anni ’80, a dimostrazione che la pubblicità funzionava meglio quando era centrata sulle storie anche nell’era analogica (ed anche a dimostrazione che la televisione non è mai stato un mezzo indispensabile se si vogliono fare campagne pubblicitarie forti).
E pensare che a quei tempi non c’era nemmeno Instagram.
Perché un altro dato interessante che appariva in quell’articolo è che negli U.S.A. tra il 2015 ed il 2017 la condivisione di contenuti riguardanti marchi è diminuita del 50%, malgrado i contenuti siano aumentati.
Il consumatore digital e advertising native sommerso di contenuti, decide di farsi i fatti propri il doppio di prima.
Sicuramente la quantità di comunicazione da parte dei marchi gioca un ruolo importante nell’infastidire le persone, ma anche il livello basso dei contenuti creati (intesi in senso generale) ha la sua parte di responsabilità nel generare irrilevanza.
E’ importante distinguere tra un “narrazione” ed una “storia”.
La narrativa è un elenco lineare di fatti, spesso in ordine cronologico, una storia è un racconto di persone con le loro idee, valori ed emozioni, i conflitti che succedono e come vengono superati. Perché i conflitti, interni ed esterni, cambiano le vite.
L’assenza di confitti è il punto su cui falliscono, o comunque diventano molto deboli, le storie delle marche perché nelle aziende e nei loro reparti marketing prevale una cultura di negazione dei problemi. Soprattutto nei confronti dell’esterno, per cui i panni sporchi vanno lavati in casa.
Così però le storie sono poco credibili e noiose, perché è impossibile che nessuno non sporchi mai neanche un panno.
Per le marche l’importante è ricordarsi del lieto fine, come ci insegna anche la grande fabbrica dei sogni hollywodiana.
A questo punto l’essenza di quanto volevo dire con questo post è già raggiunta.
Per completezza però concludo elencando gli 8 stadi che deve avere una storia di successo secondo il libro Storynomics di Robert McKee e Thomas Gerace https://storynomics.com/.
Non sono molto diversi da quelli che magari avete già letto da qualche altra parte in questi anni, ma repetita iuvant:
- Individuate l’audience obiettivo.
- Date dei principi/valori di base al protagonista.
- Si verifica un incidente imprevisto.
- Il protagonista desidera qualcosa che gli permetta di ristabilire l’equilibrio rotto dall’incidente di cui sopra.
- Il protagonista fa una scelta tattica che spera gli faccia ottenere quello che desidera.
- La scelta tattica si rivela un fallimento.
- Il protagonista fa una scelta critica/fondamentale/strategica.
- La scelta critica/fondamentale/strategica permette di raggiungere un nuovo punto di equilibrio per cui vissero tutti felici e contenti (quest’ultimo pezzo in corsivo l’ho messo io).
5 modi in cui i contenuti di marketing possono supportare le vendite.
Ispirato da un articolo apparso su Marketing News, ed in parte riprendendone i contenuti, propongo 5 regole per rendere i contenuti creati dal marketing più efficaci nel supportare le vendite.
Una delle frasi che ripetevo spesso in azienda è che le strategie di marketing vengono realizzate (soprattutto) dalle (funzioni) vendite. Se i risultati non saranno buoni, per qualsiasi motivo, la strategia dovrà essere rivista, quando non abbandonata.
E’ quindi fondamentale che gli strumenti sviluppati dal marketing siano efficaci (anche) in termini di vendita. Viceversa i nostri colleghi delle vendite li utilizzeranno con scetticismo, o non li utilizzeranno proprio.
Lamentarsi dopo non serve a nulla.
1.Siate precisi e specifici: l’utilizzo di termini vaghi maschera il vantaggio competitivo della nostra proposta (prodotto o servizio che sia). Termini generici tipo “tra i migliori della categoria”, “innovativo”, “facile da usare”, ecc… sono abusate e quindi deboli, quando non inutili, nel supportare le vendite.
Suonano bene, ma costringeranno i vostri colleghi delle vendite ad un maggiore sforzo nel far apprezzare ai clienti il vantaggio competitivo, con il rischio che non ci riescano.
Siate specifici e precisi nel descrivere il vantaggio competitivo che caratterizza la proposta, evitando i concetti generici o, almeno, contestualizzandoli in modo inequivocabile (e magari differenziante). Questo ridurrà il pericoloso spazio per le interpretazioni ed aumenterà l’efficacia dei colleghi delle vendite.
2. Focalizzatevi sul benefit che la proposta fornisce ai vostri clienti: se sono più veloce non dirò che sono molto più veloce, ma dirò qual è la mia velocità o, meglio ancora, che sono il 20 % più veloce del miglior concorrente (ricordate che le scelte di acquisto delle persone sono sempre comparative e mai assolute).
3. Non fate dichiarazioni vuote: fornite (ai colleghi delle vendite ed ai clienti) le prove di quello che dite. “Siamo il 20% più veloci del miglior concorrente perché costruiamo il nostro prodotto usando questo brevetto in esclusiva e questi sono i test che lo dimostrano”.
4. Usate termini famigliari e sensati per la categoria: non è lo stesso della precisione e specificità dette prima. Qui si tratta di permettere ai clienti di poter confrontare le proposte (prodotti o servizi) di due o più concorrenti e per farlo è necessario che i parametri che li descrivono siano confrontabili. Ad esempio la potenza, la velocità massima, il consumo per 100 km, ecc.. nel caso di una automobile. Usare parametri fuori dagli standard della categoria, tipo “da 0 a 38 km/ora in x secondi” creerebbe solo confusione nei potenziali clienti.
Inoltre sempre più spesso molti acquisti vengono confrontando prima sul web (molte) diverse alternativa e l’utilizzo di termini/parametri avulsi dalla categoria comporta il grande rischio di essere subito esclusi dal paniere delle scelte. Rischio che diventa praticamente certo se la comparazione viene fatta da appositi bot.
5. Non mischiate i messaggi: il tono ed i contenuti del messaggio vanno calibrati coerentemente al livello di conoscenza/professionalità che hanno le diverse audiences a cui ci rivolgiamo. Toni e contenuti per comunicare con gli intermediari dovranno essere diversi da quelli usati per il consumatore finale.
Tenete presente anche dei diversi livelli di conoscenza/esperienza/formazione dei diversi tipi di intermediari commerciali e dei diversi segmenti di consumatori. Ad esempio tra un ristorante stellato ed una trattoria nel proporre un abbattitore di temperatura o tra un appassionato degustatore ed un bevitore occasionale nel proporre un vino.
Le frontiere della fidelizzazione.
E’ da un po’ che ho rallentato molto (eufemismo) le pubblicazioni su biscomarketing.
Non è stata tanto una scelta cosciente, né mancanza di tempo. Soprattutto mi mancavano cose di interessanti da dire.
Magari perché ho già scritto tanto e tanto ho visto. Magari perché comincio a sentire gli anni e tutto il marketing digitale arrivo appena a capirlo, figuriamoci commentarlo.
Comunque sia negli ultimi 4 mesi ho ri-accumulato un po’ di idee e quindi torno a scrivere, con l’intenzione di mantenere la mia solita regolarità settimanale. Vediamo se ci riuscirò.
Anche per questo mi propongo di scrivere post più agili, più simili a quelli degli inizi, più con l’obiettivo di dare stimoli che risposte. E questo promessa sarà forse più difficile da mantenere.
Comunque …
Lo spunto del post di oggi è un’analisi delle tendenze dei programmi di fidelizzazione pubblicato da JWT Intelligence (iscrivetevi alla newsletter, che è gratis).
I programmi di fidelizzazione che tipicamente permettevano ai consumatori di accumulare punti da spendere in seguito a fronte degli acquisti, stanno perdendo di efficacia nello sviluppare e mantenere i fatturati e/o stanno diventando finanziariamente troppo costosi.
Il problema principale è il loro basso valore aggiunto.
Qualsiasi promozione di qualsiasi tipo dovrebbe sempre puntare a massimizzare il valore aggiunto per il cliente rispetto al costo sostenuto dall’azienda.
E’ evidente che quando io do 1 punto per ogni euro di spesa e poi i miei clienti possono usare i punti per acquistare i miei prodotti il valore aggiunto è minimo, se non inesistente. Il cliente riceve esattamente quanto dà e, soprattutto, il valore del premio è esattamente il prezzo a cui il prodotto viene normalmente venduto.
Man mano che tutte le linee aree, tutte le catene di supermercati, ecc… adottano dei programmi di fidelizzazione, il vantaggio competitivo originario dei pionieri (ad esempio American Airlines, Esselunga) si annulla.
Aggiungeteci poi la compressione dei margini portata dalla cultura low cost e moltiplicata dalla rivoluzione digitale e capite bene come i costi dei programmi di fidelizzazione classici rischino di diventare uno svantaggio competitivo.
Se un volo low cost mi costa meno delle tasse aeroportuali del mio biglietto premio “acquistato” con le miglia, non è che valga molto la pena.
I rimedi che le aziende stanno adottando individuati da JWT sono in parte concettualmente vecchi (ma non per questi meno validi), in parte innovativi solo tecnologicamente ed uno veramente rivoluzionario.
Smartphone al posto delle carte fedeltà.
E’ un tecnicismo direi obbligato. Concettualmente non cambia niente, ma operativamente cambia quasi tutto.
Immediatezza, rapidità, divertimento, praticità. Il limite di come interagire con il cliente sta solo nella fantasia di chi disegna la app.
Esperienze al posto dei punti.
Anche qui il concetto non è nuovo e punta a massimizzare il valore aggiunto per il cliente rispetto al costo per l’azienda di cui si parlava prima.
Il cliente farà fatica a dare un prezzo ad un’esperienza, soprattutto se si tratta di qualcosa che esula dalla norma, che quindi diventerà immediatamente priceless.
Inoltre è relativamente facile per le aziende offrire esperienze che i propri clienti da soli difficilmente potrebbero fare, non tanto e non solo per il costo, ma per questioni organizzative: incontri con celebrità, viaggi particolari, personalizzazioni di prodotto, ecc…
Se l’esperienza posso farla solo grazie all’azienda, ecco che diventa automaticamente inestimabile, come la sua forza fidelizzante.
Fateli divertire, ossia gamification.
Non starò qui a parlare dei vantaggi di fare le cose giocando in termini di coinvolgimento delle persone e quindi di livello di partecipazione e di ricordo del messaggio.
IKEA a Londra per incrementare l’utilizzo della Family Card (stranamente oltre il 60% dei possessori non sempre la usava al momento di pagare) ha offerto un premio immediato per ogni utilizzo della carta. I premi andavano da un hot dog ad un viaggio in Svezia per 4 persone.
Anche qui concettualmente niente di nuovo: quando io ero un’adolescente c’erano i “Boeri – Sempre si vince” (se ve li siete ricordati avete sorriso, altrimenti siete troppo giovani)
Più in linea con lo spirito del tempo il programma di fidelizzazione che dell’azienda di cosmetici Tarte, che fa guadagnare punti ai propri clienti che danno visibilità alla marca ed ai sui prodotti su web e sociale media. Man mano che avanzano nel livello di fidelizzazione i clienti possono accedere a diversi tipi di esperienze (perché ovviamente i diversi approcci si possono anche combinare).
Prevedere e personalizzare.
Big Data, Intelligenza Artificiale, Blockchain e chi più ne ha più ne metta.
Tecnicamente oggi è possibile ritagliare il programma di fidelizzazione su misura per ognuno dei propri clienti o quasi.
Attenzione però che le macchine non fanno tutto da sole, gli algoritmi di analisi dei dati vanno pensati e disegnati ed abbondano gli esempi di aziende che fanno un uso scadente dei dati dei loro clienti. Basta pensare alla quantità di offerte irrilevanti e/o generiche che tutti continuiamo a ricevere.
Flessibilità invece di schemi.
Qui la soluzione tecnologica ed rappresentata dal blockchain per integrare e collegare i programmi fedeltà di aziende diverse e quindi permettere maggiore libertà di utilizzo alle persone nell’accumulare e spendere i punti.
Vecchio sogno delle agenzie di promozione, la rivoluzione digitale riuscirà a trasformarlo in realtà?
Pagare per il privilegio di essere clienti fedeli.
Qui sta la vera innovazione. Il servizio Prime fornisce ai clienti Amazon una serie di vantaggi che normalmente altre aziende/settori offrono ai clienti fedeli.
In questo caso il concetto è ribaltato e siccome paghi, per ammortizzare il costo dell’abbonamento è probabile che sarai un cliente sempre più fedele. Tra l’altro se ti abboni significa che già apprezzi l’azienda e quindi sei già propenso ad essere un cliente fedele.
Il “programma fedeltà” invece di un costo diventa una (rilevante) fonte di ricavo, per di più anticipato nel senso che si realizza anche se poi il cliente non usa il servizio.
Per Amazon gli ultimi dati disponibili parlano di 100.000.000 di clienti abbonati Prime, che valgono quindi un fatturato di 9.900.000.000 $/€/£ ecc… all’anno.
Se Amazon è l’esempio più eclatante, lo stesso concetto lo utilizzano la catena di cash & carry Costco e quella di negozi americani Bed, Bath and Beyond.
Quest’ultima sta facendo delle prove per sostituire il proprio programmi fedeltà con un “abbonamento” annuale del costo di 29 $ che dà diritto al 20% di sconto ed invio gratuito dei prodotti acquistati.
Bastava pensarci? Non proprio: perché la gente sia disposta a pagare per avere il privilegio di essere un cliente fedele di un’azienda bisogna che questa azienda sia in grado di fornirgli un elevato valore aggiunto in termini di convenienza e/o unicità della proposta.
Cosa non così facile nell’era della turbocompetizione.
“Ok Google”: gli elementi di marketing che ne fanno un (potenziale) game changer.
“Hey Siri”, “Hey Cortana”, “Hey Alexa”, “Hey Mercedes”, “OK Google”.
Mai usato un assistente vocale in vita mia. Non è una posizione ideologica, immagino semplicemente la normale conseguenza di aver iniziato ad utilizzare il computer scrivendo i comandi per copiare file, formattare, ecc … sullo schermo monocromatico in linguaggio MS-DOS, prima che esistesse Windows.
Ai tempi esistevano già i Macintosh della Apple che utilizzavano il sistema operativo con desktop, cartelle e finestre di comandi che sia privano, ma questa è un’altra storia su cui torno dopo.
Probabilmente non userò nemmeno l’assistente di Google, ma la campagna pubblicitaria “Ok Google” mi ha dato da pensare sulle sostanziali differenze concettuali di posizionamento tra l’assistente di Google e gli altri più diffusi/conosciuti.
Si tratta solamente di spunti che mi piacerebbe veder sviluppati dal punto di vista psicologico / psicoanalitico / antropologico da professionisti di queste discipline. Se hanno psicanalizzato Coccolino a maggior ragione varrebbe la pena di farlo per gli assistenti vocali/personali con cui dialoghiamo.
Ultima premessa: giocoforza il mio è un punto di vista maschile, anche se spero non maschilista.
Il genere.
La prima è che, almeno in italiano, Google è l’unico di sesso neutro (o maschile?) mentre gli altri assistenti sono tutte donne. Vero che si può cambiare la voce da femminile a maschile (almeno per Siri), ma resta il fatto che la versione di default è donna e nomi come Cortana, Alexa e Mercedes sono inequivocabilmente femminili.
Potrà sembrare un dettaglio, ma trattandosi di qualcosa/qualcuno a cui si parla dando ordini / chiedendo informazioni è un dettaglio fondamentale nella percezione che l’utente ha dell’assistente. Tra l’altro la percezione è probabilmente diversa tra gli uomini e le donne.
In sintesi la mia impressione è che Google si posizioni più come un “maggiordomo”, mentre gli altri come una “collaboratrice domestica”. Al di là del sessismo di cui sono storicamente e culturalmente caricati i due termini, io intendo proprio un diverso livello nel rapporto.
Google si (pro)pone come il genio della lampada, le altre come fantesche. Entrambe figure al servizio del “padrone-utente”, ma con una relazione gerarchica molto diversa.
Il comando di attivazione.
Google utilizza “OK”, tutte le altre usano “Hey” (leggevo che anche Google stava passando a “hey” ma a quanto pare questo non è avvenuto ed io gli consiglierei di non farlo).
“OK” è intrinsecamente risolutivo, coinvolgente (ossia suggerisce che stiamo facendo qualcosa insieme) e più paritetico in termini di rapporto.
“Hey” intrisecamente non significa altro che un richiamare l’attenzione, suggerisce un legame più distante e un rapporto più freddo / separato: “hey tu.”
Di nuovo il genio della lampada e la fantesca.
Marca azienda vs. marca prodotto.
Qui c’è poco da ragionare, nel senso che la cosa è evidente “OK Google” è un tutt’uno con … Google (come “Hey Mercedes” con Mercedes) mentre Siri è una parte di Apple, Cortana di Windows ed Alexa di Amazon.
Il circolo virtuoso per cui “OK Google” gode di tutta la forza e posizionamento di Google ed allo stesso tempo contribuisce a rafforzarlo e farlo crescere ulteriormente è evidente.
Universalità e simbiosi
Comincio dalla simbiosi, concetto che ho visto legato al posizionamento di marche / prodotti nel 2016 da parte di Pier Luca Santoro riferito a Facebook
Concetto interessantissimo relativamente all’evoluzione del rapporto tra marche e persone / utenti / audiences che credo meriterebbe un maggior approfondimento strategico e formalizzazione teorica per sostanziare ed operare sui diversi aspetti che la semplice definizione del termine suggerisce.
Dizionario di Google:
simbiosi
sim·bi·ò·ṣi/
sostantivo femminile
- 1.
In biologia, associazione tra due o più animali o vegetali di specie diverse.
Treccani:
simbiosiAssociazione intima, spesso obbligata, fra organismi (animali o vegetali) di specie diverse, che generalmente comporta fenomeni di coevoluzione.
Dizionario Italiano del sito del Corriere della Sera
simbiosi
[sim-biò-si] s.f. inv.
- 1 biol. Associazione fra due o più individui appartenenti a specie vegetali o animali diverse, in modo che dalla vita in comune traggano vantaggio entrambi, ovvero uno solo ma senza danneggiare l’altro
E’ indubbio che il rapporto tra Google e le persone vada verso la simbiosi, sempre che non lo sia già. Siamo noi che cerchiamo sul web oppure è Google che trova? Secondo me domanda superflua, ancor prima che inutile.
Sarebbe però secondo sbagliato pensare che il rapporto simbiontico tra marca e persone sia esclusiva dei servizi offerti dalle piattaforme digitali, perchè credo si tratti principalmente di una questione di approccio della marca nella definizione e sviluppo della propria proposta.
Twitter è una piattaforma digitale ancora tra le principali per diffusione ed utilizzatori, ma mi sembra distante dal perseguire una simbiosi con i propri utenti.
Viceversa Apple, ben prima dei tempi dei social network, era molto vicina alla simbiosi con i propri utenti perché proponeva prodotti pensati partendo dalle soluzioni per le persone e non dall’efficienza ingegneristica.
Quando nel 1994 ho iniziato a lavorare in Levoni rimasi stupito dell’intensità dell’utilizzo dell’informatica a tutti i livelli ed in tutti i reparti aziendali, con i conseguenti vantaggi di integrazione e circolazione delle informazioni. Questo era possibile perché i tre titolari, responsabili delle diverse aree aziendali, erano i primi ad utilizzare normalmente il loro computer Apple. Ripeto parliamo di persone intorno ai cinquant’anni nel 1994. Io che venivo da una “cultura” informatica MS DOS mi trovavo in difficoltà perché il mondo Apple era troppo semplice: all’arrivo della nuova stampante cercavo il dischetto per caricare il programma per configurarla. Mi venne in aiuto il Direttore Amministrativo, spiegandomi che bastava collegarla al computer e si configurava da sola. Poi ha aggiunto “Se avessimo usato computer MS DOS non sarei mai riuscito a convincere le persone a smettere di utilizzare calcolatrici e macchine da scrivere”.
Non è un caso che la fedeltà alla marca degli utenti Apple fosse a livelli più settari che apostolici.
Se questo legame si è allentato è perché Apple ha ridotto la propria capacità di rendere la vita più facile alle persone, ben al di là di un’immagine che, svuotata di contenuti, rischia di passare da estetica ad estetizzante.
L’universalità rafforza la simbiosi.
Cortana è chiusa dentro ai computer che utilizzano Microsoft.
Siri si allarga all’I-phone, però non esce dal mondo Apple, che è sostanzialmente chiuso.
Alexa è legata all’enorme centro commerciale che è Amazon, ma la vita delle persone non si riduce solo a compravendite.
Google è dappertutto. Con il motore di ricerca, con Gmail, con Google Maps, con Google foto, ecc… Tutti servizi che prescindono dal sistema operativo Apple o Microsoft.
Proprio perché è dappertutto, Google può aiutarmi in (quasi) qualsiasi cosa debba fare durante la mia giornata. L’altra dimensione dell’universalità, che a questo punto sintetizzerei con la parola (neologismo?) UNIVERSATILITA’.
E Mercedes? Per quanto posso sembrare strano riferendosi ad un assistente nato e sviluppato esclusivamente per la gestione dell’auto a me sembra quello potenzialmente più simbiontico ed universale. Sarà forse perchè per otto anni ho passato almeno due ore al giorno in macchina?
Condivide con “OK Google” la corrispondenza del nome con il marchio aziendale e (quindi) il suo protagonismo nella campagna pubblicitaria.
Rendere centrale l’assistente vocale nella proposta di Mercedes aggiunge una performance rispetto ai concorrenti, ma mantiene la concorrenza con gli altri produttori sempre nell’ambito automobilistico.
Espandere la portata dell’assistente vocale “Mercedes” alla vita delle persone in generale potrebbe spostare la proposta di Mercedes su un ambito diverso, dove gli altri produttori di automobili non ci sono, cambiando radicalmente i rapporti competitivi.
Detto in altre parole scelgo una Mercedes perché così posso avere un assistente vocale che mi semplifica la vita, oltre ed al di là delle performances dell’auto. Certo, per la Mercedes si tratta di un altro lavoro, che però sta già facendo. La difficoltà nell’adottare un approccio universale all’assistente vocale/personale mi sembra più culturale che tecnica.
Ma perché le persone dovrebbero preferire l’assistente “Mercedes” a quelli delle aziende digitali?
Primo perché gli altri difficilmente mi assisteranno anche nella guida della mia macchina e secondo perché forse la Mercedes non darà in giro i miei dati, visto che i profitti li fa vendendo le automobili.
Perché se dite “OK Google …” poi non lamentatevi che Google sa tutto di voi.
Mare e Vitovska in Morje 2018: alla scoperta del Carso.
Continuo a non scrivere di marketing, però continuo a scrivere di vino: qui il link al post uscito su Vinix.
Salute!
Rosè: quanto, dove, come e perchè.
Continuo a non scrivere di specificatamente di marketing, continuo a scrivere di vino (marketing e non). Qui sotto il link:
Vini della Denominazione d’Origine Bullas (Murcia-Spagna): gemme a prezzi di bigiotteria.
Lo so biscomarketing è fermo da un po’, ma non mi viene niente di interessante da dire.
In compenso scrivo di vino: ecco qui il link
Un po’ di post di argomento vinicolo.
Lo so che il blog ultimamente langue.
Un po’ è perché non trovo molti stimoli su argomenti di marketing di cui non abbia già scritto ed un po’ è perché sto scrivendo di vino e dintorni con una certa frequenza.
L’impegno di riprendere qui i post pubblicati su Vinix a beneficio anche dei lettori di biscomarketing ultimamente è saltato. Si vede che ero distratto.
Rimedio con la scorpacciata che trovate qui sotto, leggete responsabilmente.
Malvasia Istriana e gelato gastronomico? Da fare!
Le fiere del vino come e perché.
Il mio Vinitaly degli anfratti e delle piccole cose.
Con la disintermediazione del commercio siamo diventati tutti operatori?
Sono stato all’Asolo Wine Tasting e non ho bevuto neanche un bicchiere di Prosecco.
E se il marketing relazionale fosse (soprattutto) una grande mistificazione?
Uno per scrutarli,
Uno per irretirli,
Uno per controllarli
E il prodotto rifilargli.
(mia reinterpretazione in chiave marketing relazionale dell’incipit del Signore degli Anelli).
La prima volta che ho sentito parlare di marketing relazionale è stato diversi anni fa, quando me parlò in toni entusiastici una mia ex collaboratrice che aveva partecipato ad un seminario sul marketing relazionale applicato al settore del vino.
La cosa mi colpì perché era la prima volta che sentivo il termine. Siccome di marketing ne ho studiato un bel po’ e continuo a studiarne abbastanza, sono sempre un po’ sorpreso e curioso quando mi imbatto in termini/concetti nuovi.
Dalla sua spiegazione su in cosa consistesse in concreto mi parve di capire che si trattatava di un versione aggiornata al mondo digitale delle strategie ed attività di marketing diretto.
Un anno dopo per delle lezioni di un Master sull’export del vino mi chiesero di inserire una parte sul marketing relazionale e quindi dovetti guardarci un po’ più a fondo.
Il mio problema è che ho una visione olistica, globale complessiva del marketing basata sulla definizione del Kotler secondo cui l’organizzazione che opera secondo l’approccio di marketing opera per raggiungere i propri obiettivi attraverso il soddisfacimento dei bisogni e desideri palesi o latenti dei mercati obiettivo a cui si rivolge in modo più efficace ed efficiente dei concorrenti.
Come dico ai miei corsi, capite bene tutte le parole di questa definizione, le relazioni che hanno tra loro e le relative implicazioni potremmo anche non aggiungere altro, perché qui c’è tutto. O meglio, il resto delle lezioni serve appunto a capire in dettaglio l’essenza dei concetti espressi sopra.
Detto in un altro modo, per il marketing è sempre relazionale perché una transazione, che sia economica od emotiva non importa, implica sempre una relazione. Indipendentemente dall’intensità che questa può avere o dal fatto che sia positiva o negativa.
Il resto, volendo estremizzare, sono tecnicismi.
Poi qualche mese fa mi hanno chiesto di tenere due giornate di lezione incentrate sul marketing relazionale e quindi mi sono messo a studiare. Il progetto alla fine si è arenato, ma il bello di studiare è che comunque quello che una impara gli rimane.
Quindi cosa ho imparato.
Innanzitutto la distinzione tra “marketing relazionale”, secondo il quale la marca punta a costruire una relazione con il cliente consumatore, e “marketing transazionale”, secondo il quale la marca punta a vendere qualcosa al cliente consumatore.
E già qui ho cominciato a mettere i punti di domanda sul bordo del libro.
A parte il concetto espresso prima che ogni transazione è una relazione, questa a me sembra una distinzione che, ben che vada, separa il buon marketing dal cattivo marketing. Oppure le aziende che operano secondo un approccio di marketing da quelle che operano secondo un approccio di vendita.
C’è poi un’altra questione: tutte le organizzazioni operano con l’obiettivo di far fare qualcosa alle audiencies a cui si rivolgono (che sia comprare, vendere, viaggiare, donare, ecc…). Nessuna azienda punta a costruire una relazione con un cliente/consumatore per instaurare un’amicizia ed andare a bere l’aperitivo, raccontare come stanno i bambini, ecc…
Non è cinismo è che un’organizzazione esiste per uno scopo, quindi manca intrinsecamente della gratuità che caratterizza le relazioni interpersonali amicali. Ossia l’azienda sviluppa relazioni per raggiungere transazioni.
Viceversa si crea il rischio di generare amore platonico per la marca (ne ho scritto in questo post del marzo 2015)
I miei dubbi continuavano a crescere man mano che passavo dalla teoria alla pratica del marketing relazionale.
Attività di database marketing, invio di mailing, profilazione sui social e tutte le altre tecniche e tattiche del marketing relazionale mi sembravano sempre di più un’evoluzione sofisticata dell’approccio di vendita, condita di stratagemmi per ottenere quanti più canali di accesso alle persone possibili (indirizzi e-mail, profili social, ecc…)
L’accuratezza della targettizzazione permessa dagli strumenti digitali porta a generare una comunicazione molto più rivolta alla transazione di quanto non succeda con gli strumenti di marketing classico.
Ad esempio le strategie di posizionamento “classiche”, che puntano a definire e costruire una percezione della marca e dei suoi valori da parte delle audiences, implicano una relazione molto più aperta, paritetica e meno invasiva delle campagne di content marketing sui social networks.
Intendiamoci, non che il marketing diretto non vada bene, ma non è un cambiamento di paradigma è solo un cambiamento (radicale) degli strumenti.
Talmente radicale che rischia di far regredire l’azione delle aziende ad una logica di hard selling come sembrano suggerire gli esempi degli e-shop che nascono e muoiono in un batter d’occhio sulla rete.
“Marketing relazionale” suona molto bene, ma abusare della pazienza e dell’attenzione delle persone può convertirsi in un boomerang perché non importa quanti siano i canali che l’azienda possiede per raggiungerle: l’attenzione selettiva non gli farà comunque vedere il contenuto della newsletter anche se l’hanno aperta né il banner che scorre sotto-sopra-adestra-asinistra.
Concludo riportando il estratto da un libro sul social CRM che ho letto per approfondire l’argomento (non importa dire titolo ed autore): “Sono inoltre disponibili strumenti per ottimizzare l’esperienza complessiva di registrazione come omissis che traccia quanti e quali campi vengono compilati, e se e dove l’utente abbandona il form prima di confermare la sottomissione”
Ecco l’uso dell’anglicismo “sottomissione” invece dell’italiano “invio” mi sembra significativo del tipo di relazione che si vuole instaurare con il consumatore.
Perdono.
La mia presunzione è una vecchia storia che si è riproposta con una certa intensità negli ultimi giorni.
Probabilmente un po’ perché la recente, quasi contemporanea, pubblicazione di una mia intervista sulla rivista francese “Vitisphere” e di un mio articolo su “Il Corriere Vinicolo” (n.12 del 9 aprile) mi ha effettivamente lusingato, ed un po’ per cercare di compensare con le gratificazioni professionali quello che manca a livello personale.
Stesse cose che succedevano in passato, immagino, quando gli amici, che ringrazio, mi rincuoravano dicendo che non era presunzione ma la (giusta) consapevolezza del mio valore. Visto che realizzavo quasi tutto quello di cui parlavo (e si sa che parlo molto) mi è piaciuto credergli.
Però si sbagliavano loro e mi sbagliavo io. La presunzione che porta alla perdizione il Capitano Achab non è quella di cacciare Moby Dick, bensì di riuscire a prenderla.
Si tratta di una regola che avevo imparato tanti anni fa, ma per troppo tempo me la sono dimenticata. Grazie a chi me l’ha ricordata.
Quindi chiedo scusa a tutte le persone che in passato (prossimo o remoto che fosse) si sono sentite prevaricate dai miei comportamenti. Per quello che può valere, l’intenzione è sempre stata (soprattutto) quella di aiutare, anche quando i modi potevano suggerire il contrario.
L’impegno per il futuro è di allineare i modi alle intenzioni.
Per chi è al Vinitaly, ci vediamo domani.
“Primo, pianificare” – biscomarketing è su Mille Vigne!
Sul primo numero di Millevigne del 2018 è uscito un mio articolo sull’importanza della pianificazione per raggiungere i risultati.
Nei prossimi numeri usciranno altri articoli su cosa fare per realizzare quello che si pianifica e controllare come stanno andando i piani.
Non serve essere piemontesi per abbonarsi!
Sono andato a fare la spesa da Aldi ed è stata una delusione 2.
Come promesso, eccomi di ritorno dopo la Pasqua, sia quella cattolica che quella ortodossa con l’argomento ALDI.
Nel primo post la spiegazione del modello di business di ALDI, che ritenevo comunque necessaria ed interessante, ha assorbito tutto lo spazio umanamente gestibile anche per un lettore di biscomarketing.
Quindi non ho affrontato l’argomento del titolo, spiegando i motivi della mia delusione.
Provo a farlo SINTETICAMENTE.
Il motivo principale è l’assortimento.
Gli scaffali del punto vendita ALDI a Trieste sono pieni di prodotti di marca. A spanne saranno almeno tra il 20% e 30% dell’assortimento. D’altra parte basta vedere le offerte della prossima settimana annunciate sul sito per capire che ALDI in Italia punta ad una strategia basata sulle marche più note dell’industria rispetto alle marche private.
Il problema dal mio punto di vista di consumatore è che quindi in Italia ALDI non è ALDI. Non è un punto vendita dove comprare prodotti di qualità medio alta ai prezzi più bassi del mercato, non in relazione alla marca (che negli altri paesi è sempre una marca privata dell’insegna), ma in assoluto.
Mi sembra che la scelta sia stata di fare un ALDI in salsa italiana (nel punto vendita c’è anche un banco bar che fa caffè e colazioni).
Piacerà? I consumatori italiani cambieranno supermercato per comprare la Coca Cola da 500 cl a 0,85 euro invece che 1 euro (prezzo normale in un vicino supermercato Coop), le brioches Bauli allo stesso prezzo (sempre confrontando al prezzo NON in promozione della Coop), i wurstel AIA quasi alla metà, ecc…?
Come giustificheranno le altre catene della GDO queste differenze di prezzo ai loro clienti?
E le aziende produttrici come lo giustificheranno ai buyers della GDO?
Partirà una guerra di prezzi che, presumibilmente andrà a svantaggio dell’industri?
Io intanto in Italia se voglio andare da “ALDI” dovrò continuare ad andare da Eurospin (lo so i punti vendita sono tristi, ma la strategia di assortimento ed qualità di prodotto e quella più “tedesca” che c’è) e se ho voglia di mangiarmi un buon brezel pagandolo solo 0,39 euro andrò da ALDI.
Vinitaly si avvicina, quindi aspettatevi qualche buco nel ritmo di pubblicazione del blog.