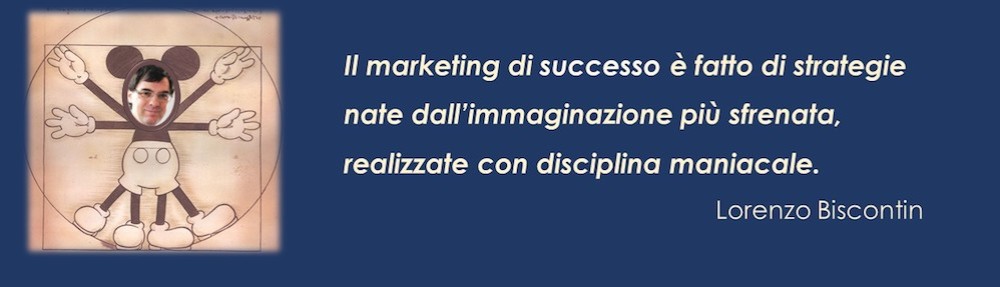Il concetto di “Brand Equity” è considerato, giustamente, uno dei più importanti in ambito aziendale perché descrive il valore il valore di una marca. La frequenza e l’enfasi con cui viene usato farebbe presupporre l’esistenza di una sua definizione chiara e, soprattutto, condivisa.
La mia esperienza pratica è che si tratta di un concetto piuttosto fumoso che le persone e le funzioni in azienda tendono ad utilizzare a proprio piacimento, (fortemente) influenzati dal proprio punto di vista ed esigenze. Innanzitutto dalla funzione e dai professionisti di marketing, che per primi hanno il compito di proteggere ed incrementare la “Brand Equity”.
Questa indeterminatezza è riconosciuta dalla definizione di “Brand Equity” fornita dal “Common Language Marketing Dictionary” dell’American Marketing Association: http://www.marketing-dictionary.org/Brand+Equity
Brand equity is strategically crucial, but famously difficult to quantify. Many experts have developed tools to analyze this asset, but there is no universally accepted way to measure it.
La traduzione che dà il traduttore di google (lo so mi sto impigrendo) è:
L’equità di marca è strategicamente cruciale, ma è notevolmente difficile da quantificare. Molti esperti hanno sviluppato strumenti per analizzare questo patrimonio, ma non esiste un modo universalmente accettato di misurarlo.
Le cose non migliorano molto se guardiamo la definizione fornita da Wikipedia in italiano:
Il patrimonio di marca o valore del marchio (conosciuto anche con il termine inglese brand equity), è una risorsa immateriale d’impresa che si fonda sulla conoscenza di una marca da parte di un determinato mercato.
Esso può essere definito come lo stato, in un dato momento, della relazione instaurata tra una determinata offerta e una domanda. Esprime il valore della marca in condizioni di funzionamento sintetizzando la forza di una marca sul mercato di riferimento.
Le determinanti della brand equity sono molteplici ma possono essere riassunte in
- valori di marca
- tratti distintivi
- riconoscibilità
- personalità di marca
- coerenza delle manifestazioni
- fedeltà alla marca
- conoscenza di marca
- qualità percepita
- associazioni di marca
- altre tipicità.
Direi che appare chiaro come dentro al termine “Brand Equity” ci possa stare (quasi) di tutto, probabilmente la ragione delle difficoltà di misurazione evidenziata dal Marketing Dictionary.
E questo è un bel problema perché è molto difficile gestire quello che non si può misurare. Tanto più che una maggiore o minore “Brand Equity” indica intrinsecamente un maggiore o minore valore economico della marca.
Ma anche volendosi limitare ad un impiego qualitativo del concetto è evidente che senza una condivisione dei suoi contenuti e del suo senso, sarà di poca utilità come strumento per l’analisi e lo sviluppo delle strategie aziendali.
L’innesco di queste riflessioni è stata la lettura di un articolo pubblicato su Marketing Insight di quattro anni fa (non sono così indietro con la lettura delle riviste dell’AMA, è che si era nascosta in un posto che non era il suo) che propone un metodo per misurare la “Brand Equity”.
Articolo su cui sono quasi totalmente in disaccordo (cosa che mi succede alquanto raramente con le pubblicazioni dell’AMA), malgrado parta da un approccio per definire la forza di una marca simile a quello che utilizzo io da molti anni.
In sintesi gli autori Ove Haxthausen e Pankaj Kumar propongo un modello in cui la “Brand Equity” è il risultato dell’interazione tra due misure: “salienza della marca” x “impatto della marca”= “Brand Equity”
La “salienza della marca” viene misurata con la conoscenza della marca (brand awareness), a sua volta legata allo “quota di voce” (share of voice) della marca. E già qui mi partono i dubbi perché la conoscenza della marca non dipende solo dalla quantità di comunicazione (share of voice) ma anche dalla memorabilità del contenuto e del messaggio. E poi qual è l’universo di riferimento dello share of voice? A seconda dei mezzi di comunicazione ci sono delle soglie minime di investimento sotto le quali non si ha visibilità perché inghiottiti dalla massa totale della comunicazione.
L’arbitrarietà della misura rischia di indebolire l’efficacia del risultato.
L’”Impatto della marca” viene invece determinato in due fasi attraverso ricerche qualitative e qualitative che inizialmente identificano quali sono i parametri rilevanti per la categoria merceologica a cui appartiene la marca secondo i consumatori e la loro importanza relativa.
Successivamente si passa determinare come si colloca la marca rispetto a questi parametri. Gli autori non forniscono dettagli delle tecniche utilizzate per individuare i parametri e l’impatto delle marche, al di là di indicare che si tratta di modelli basati sulle scelte discrete che possono essere ulteriormente migliorati aggiungendo l’analisi conjoint.
I miei dubbi qui sono legati al rischio che questa metodologia sia in grado di misurare la situazione esistente ma sfugga il potenziale. Una “Brand Equity” forte infatti è quello che permette alle marche di entrare in nuove categorie o segmenti, più o meno affini a quella centrale, portando nuovi valori, quando non nuovi prodotti, proprio grazie alla propria “reputazione”.
Infine gli autori propongono di misurare la “Brand Equity” attraverso un indice che risulta dalla moltiplicazione delle due misure: la “salienza”, espressa in % di conoscenza della marca, e l’”impatto”, indicizzando a 100 i risultati delle tecniche di analisi descritte prima.
L’incrocio delle due misure indicizzate permette di dividere le marche i quattro macro categorie:
Leaders: con salienza ed impatto elevati.
Marche di nicchia: con impatto elevato, ma salienza bassa.
Marche Commodity: con salienza elevata, ma impatto basso.
Marche nella Valle della Morte: con salienza ed impatto bassi.
Questo approccio ha un limite ed un vantaggio (che però ha poco a che vedere con la misurazione della “Brand Equity”.
Il grande limite è che determina un valore economico alla “Brand Equity” delle diverse marche, mma solo una classifica. Detto in altre parole applicando questo approccio alla fine il risultato sarà che io saprò se una marca ha un “Brand Equity” maggiore o minore rispetto ad un’altra, ma non saprò in assoluto quanto vale, se vale tanto oppure poco.
E’ un limite non indifferente, considerata l’importanza economica che si attribuisce alla “Brand Equity”.
Il vantaggio è che fornisce uno schema di analisi e classificazione delle marche che aiuta ad identificare le priorità strategiche nella loro gestione.
E’ un modello molto simile a quello che, come dicevo all’inizio, io uso da molti anni sintetizzando la forse delle marche ai due parametri fondamentali a cui sono riconducibili tutti gli altri: conoscenza della marca e reputazione della marca. (“Sul web si crea la reputazione non la conoscenza di marca“)
Nel guidare/ispirare lo sviluppo delle strategie il modello funziona definendo le misure sia in termini qualitativi che quantitativi. Voglio dire che per capire se c’è bisogno di lavorare più sulla conoscenza che sulla reputazione della marca ragionare in termini di conoscenza e reputazione alta-media-bassa (e tutto il continuum che c’è dentro) funziona quasi tanto bene come utilizzando misure puntuali dei due parametri.
Per la cronaca, se devo scegliere una misura della conoscenza della marca io preferisco usare quella spontanea rispetto alla sollecitata e la reputazione mi sembra un parametro concettualmente migliore rispetto all’impatto per considerare sia l’attuale che il potenziale.
E la misurazione della “Brand Equity” allora?
Premesso che in quanto risorsa immateriale ha delle componenti qualitative che difficilmente potranno essere quantificate isolatamente, secondo me misurare la “Brand Equity” ha senso solo se la si esprime in termini economici.
L’unica volta che, un po’ per gioco, ho misurato la “Brand Equity” è stato quando si è venduta la Stock.
Il valore (di vendita) delle aziende è normalmente definito come un moltiplicatore dell’EBITDA (sostanzialmente il margine lordo), la stessa cosa si può quindi fare a livello di marca.
Ovviamente è necessario disporre del conto economico della marca, in cui i vari costi comuni aziendali (personale, servizi informativi, ecc.) devono essere attribuiti secondo i criteri di controllo di gestione. Credo però che sia un’approssimazione migliore e più corretta rispetto alla costruzione di un indice sulla base di ricerche di mercato.
In questo modo si ottiene una valorizzazione della “Brand Equity” della marca sulla base dei suoi risultati economici, che dovrebbero essere conseguenza della sua conoscenza e reputazione.
Volendo un indicatore più pulito rispetto all’attribuzione dei costi comuni, si può applicare il moltiplicatore del valore al margine di contribuzione invece che all’EBITDA, modificandone leggermente il calcolo e comprendendo tutti i costi diretti legati alla marca sia variabili che fissi (normalmente per calcolare il margine di contribuzione si considerano solamente i costi variabili). Ovviamente in questo caso il moltiplicatore sarà diverso da quello usato per l’EBITDA, ma è facilmente ricavabile dal conto economico. Esempio se l’EBITDA è 25 ed il moltiplicatore per il valore dell’azienda è 12, con un margine di contribuzione comprensivo di tutti i costi diretti è 40 il moltiplicatore per definire il valore della marca sarà 7,5 ossia (25*12)/40.
Il bello di questo metodo è che permette il calcolo della “Brand Equity” degli investimenti aggiuntivi di marketing. Se prevedo che un investimento di marketing di 50 mi porterà un aumento di fatturato di 55, quindi un aumento netto del margine di contribuzione di 5, posso calcolare che, riprendendo l’esempio di prima, la “Brand Equity” della mia marca aumenterà di 37,5.
Qui la difficoltà sta nella prevedere il risultato delle attività di marketing in termini di fatturato, ossia volumi*prezzo medio.
Le eventuali variazioni dei costi variabili, come ad esempio un packaging più economico o più costoso, che hanno effetto sul conto economico sono invece più semplici da prevedere.
Ad ogni modo la difficoltà nel prevedere i risultati delle strategie è un problema generale della gestione aziendale, non legato specificatamente alla determinazione della “Brand Equity”, e counque non è una scusa sufficiente per operare senza fare previsioni.
Infine questo approccio al calcolo della “Brand Equity” presenta il vantaggio di poter tener conto anche delle sue componenti qualitative. Sulla base delle valutazioni aziendali e/o delle ricerche di mercato relative alla conoscenza ed alla reputazione della marca si può infatti decidere di alzare od abbassare il valore del moltiplicatore “medio”.
Infatti sono proprio le valutazioni sulla “Brand Equity” che portano a valutare diversamente i risultati economici di aziende e marche appartenenti allo stesso settore.
L’utilizzo di valori diversi del moltiplicatore dell’EBITDA, o di altri indicatori della redditività aziendale, permette anche di disegnare facilmente scenari alternativi.
Direi che come spunti per giocare con le vostre marche per oggi ne ho dati abbastanza e adesso posso andare in orto a raccogliere l’insalata.